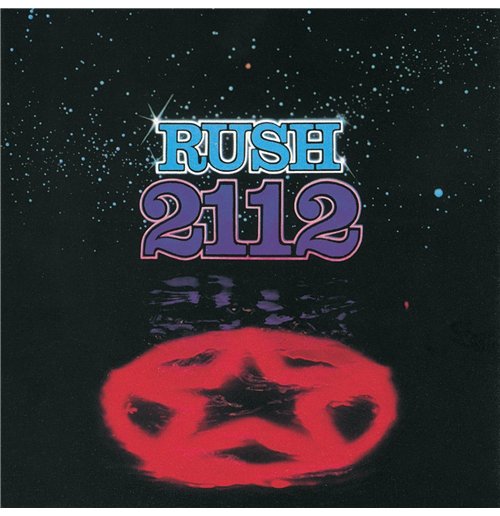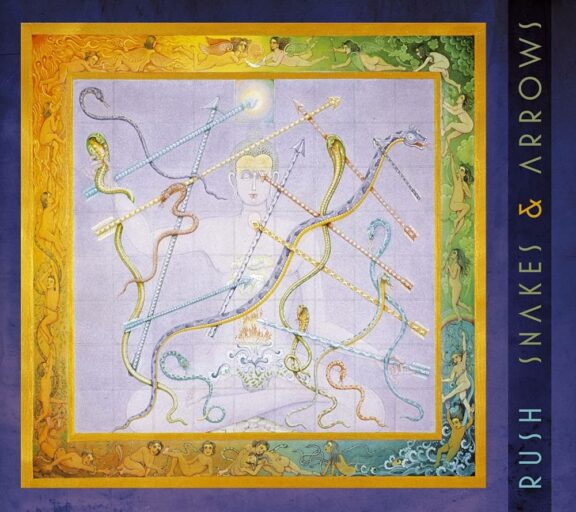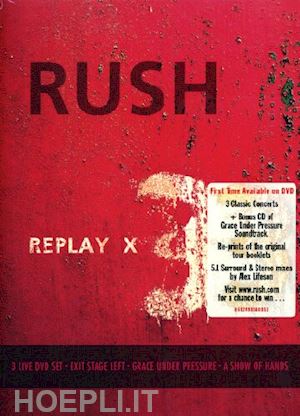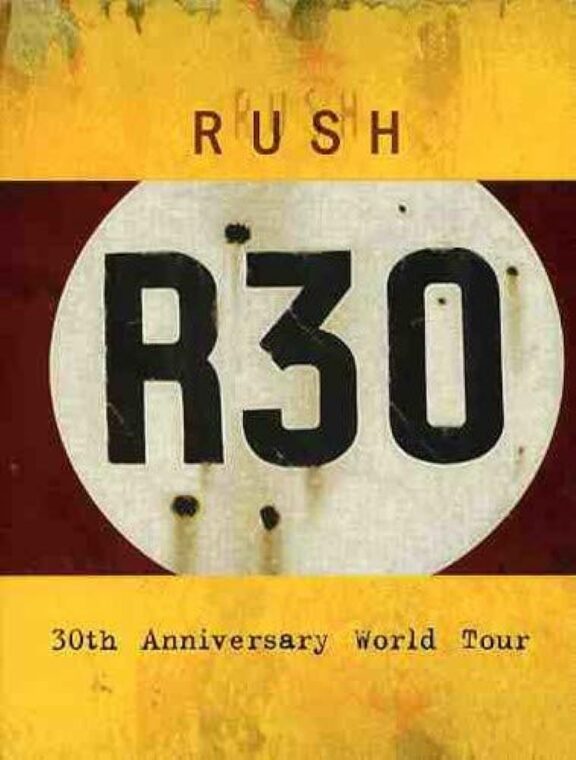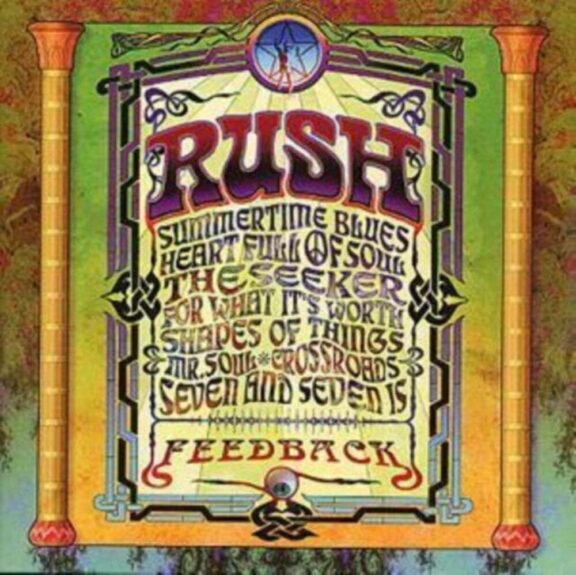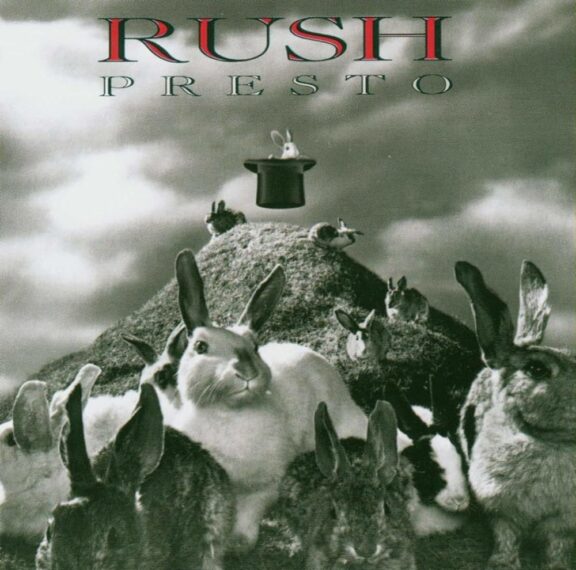Recensione: 2112
I grandi dischi sono quelli per cui la critica non scende a compromessi: c’è chi li ama e chi li odia incondizionatamente. Non ci sono vie di mezzo, e 2112 non fa eccezione a questa regola. Per i fan dei Rush e del loro genere esso rappresenta lo zenith, anche se molti si riferiscono solo alla titletrack. Sta di fatto che anche per gli addetti ai lavori, nonché per gli ascoltatori più freddi, 2112 è un caposaldo del prog rock, con l’epicità spesso pomposa della struttura dei suoi pezzi e i temi fantascientifici narrati.
Il punto debole della stragrande maggioranza delle progressive rock/metal band è quello di non riuscire ad emozionare l’ascoltatore, esasperando la tecnica a discapito del feeling. Nel caso dei nostri, questo vale un altro motivo di vanto, essendo Neil Peart un songwriter ispiratissimo e attento soprattutto al lato intimista delle sue composizioni.
Da bravo appassionato di letteratura fantasy e sci-fi, Peart si lascia travolgere dalla filosofia dell’individualismo di Ayn Rand, dopo averne letto la novella “Anthem”, e a soli 23 anni concepisce il soggetto e il testo della titletrack. Per 20 minuti ci delizia con la storia di un individuo che si sveglia in una società completamente controllata dai computer, che l’hanno conformata in base ai principi del meccanicismo di massa. L’argomento, battutissimo sia in letteratura (1984 di Orwell) che in cinematografia (Metropolis di Lang e Matrix dei fratelli Wachowski) viene presentato in uno stile musicale che rasenta il naif, nella sua entusiastica spontaneità, si narra dei sacerdoti del tempio di Syrinx. Essi hanno creato un mondo in cui tutti sono compiacenti, felici e, soprattutto, uguali, riuscendo a controllare i mezzi di comunicazioni e di divertimento di massa. Un bel giorno un giovane si imbatte in una vecchia chitarra (straordinarie le lyrics di questo passaggio), e capisce che potrebbe rivoluzionare l’industria del divertimento.
Eccitato la porta ai sacerdoti, che distruggono la chitarra e “spengono” il protagonista proprio come un computer… Da qui la sequenza onirica allucinata in cui egli si confronta con un oracolo e scopre il passato, venendo a conoscenza dell’antica razza che creò la chitarra e lasciò il pianeta molti anni prima con la promessa di tornare a riscattare ciò che le apparteneva. La suite termina con una vittoria oppressiva, il ritorno degli antichi.
D’accordo, forse la storia è un po’ stupida, ma è la musica che fa sì che essa non sia piatta e superficiale. Le parole si trasformano e il brillante drumming di Peart (quando la quantità significa qualità) riempie ogni spazio, e basterebbero i dialoghi tra la chitarra di Alex Lifeson e il basso di Geddy Lee a narrare la storia. Invece vi si aggiunge la voce alla Robert Plant di Geddy a tingere tutto dell’argento cromato tipico del cyber-spazio creato da Rand.
Qui si fa la storia del prog, amici miei: il pezzo si articola in sette parti che costituiscono un’ossatura dallo straordinario dinamismo: con la potenza estrema di “Overture” si entra in maniera bruciante in “The Temples of Syrinx”, e da qui, attraversando parti cangianti e coloratissime, si giunge al tempestoso “Grand Finale”. Molti, troppi sono i momenti che andrebbe la pena di sottolineare, e non credo di avere lo spazio necessario per farlo in questa sede: potrei citare su tutti
“The Discovery”, in cui il contrasto tra il suono leggero di una cascata e il guitar work di Alex si combina con le linee vocali e rende alla perfezione quel feeling che si sente quando prendi in mano uno strumento e inizi a suonare…
Debbono trovare spazio in questa mia recensione anche le altre tracce dell’album, non certo all’altezza della titletrack, ma di sicuro degne di nota. La mediorentale “A Passage to Bangkok” è un viaggio metaforico nei piaceri della marijuana e dell’oppio; “The Twilight Zone” è la sintesi del surrealismo post-adolescenziale di Peart, mentre “Lessons”, scritta da Lifeson, è una poesia frammentata da ritmiche hard rock e caratterizzata da pattern di chitarre acustiche e elettriche à la “Led Zeppelin”. Troviamo pure la ballad di rito (“Tears”), in cui Geddy arriva ai limiti dello stucchevole, prima di chiudere con “Something For Nothing”, lontana anni luce dalla opener per via del suo rock&pop.
Dopo il flop commerciale di “Caress Of Steel”, i Rush stavano per scomparire. Fortunatamente ciò non è accaduto, e questo capolavoro ha potuto vedere la luce. La scelta è stata ancora più coraggiosa se si considera che in “Caress” c’erano ben due suite multi-sezione, che non avevano però riscosso il successo di 2112. Ogni collezione hard rock non può essere considerata tale senza questo disco.
Tracklist:
1. 2112
I: Overture
II: The Temples Of Syrinx
III. Discovery
IV. Presentation
V. Oracle : The Dream
VI. Soliloquy
VII. Grand Finale
2. A Passage to Bangkok
3. The Twilight Zone
4. Lessons
5. Tears
6. Something for Nothing