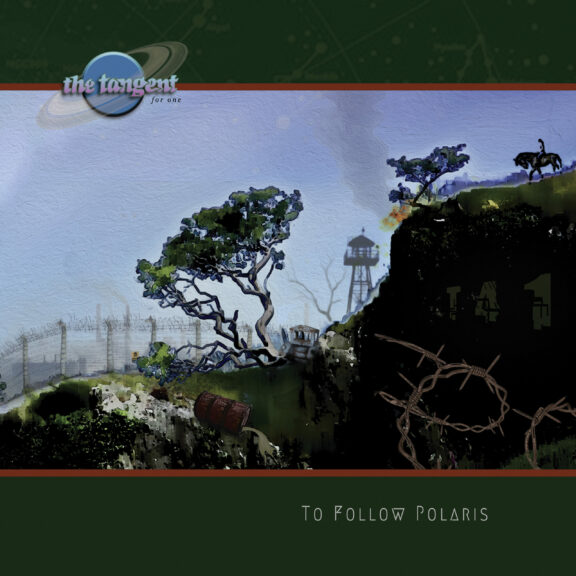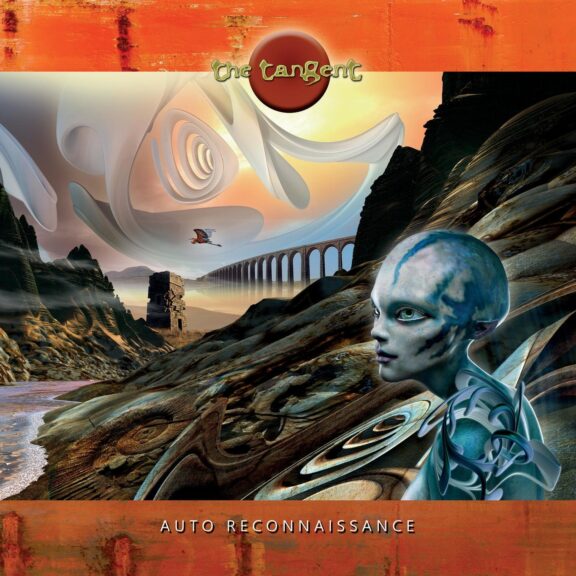Recensione: A Place in the Queue
Come si riconosce un classico?
Quando un album ha avuto il tempo di invecchiare, di accompagnare il cammino musicale di svariate generazioni di ascoltatori, non è troppo difficile: con tutta probabilità il tempo ha già avuto modo di emettere la sua sentenza. Ma quando sugli scaffali si affaccia un’opera ancora in fasce ecco che il problema si complica, tanto più se al genitore non è ancora riuscito di imprimere indelebilmente il proprio nome sulle labbra del grande pubblico. Fretta, distrazione, superficialità nell’ascolto sono spesso cattive consigliere del valore profondo di un album, anche e soprattutto in una realtà che non fa certo dell’immediatezza e della facile fruibilità le proprie carte vincenti quale è la scena progressiva. D’altro canto è buona regola diffidare dall’encomio nato dall’entusiasmo per la recente scoperta, distinguendolo dall’apprezzamento ponderato e temprato dal tempo. Di chi fidarsi dunque?
Lasciamo un momento in sospeso questa domanda, e diamo un occhiata a chi ci troviamo davanti. La storia dei The Tangent inizia nel 1999, quando due band fino ad allora ignare della reciproca esistenza si trovano per la prima volta a suonare spalla a spalla. Sarebbe bello poter dire che tra gli svedesi Flower Kings e gli inglesi Parallel or 90 Degrees fu amore a prima vista, ma se da un lato è vero che il tastierista britannico Andy Tillison ebbe subito occasione di compiacersi per la proposta sonora dei colleghi scandinavi, è altrettanto vero che tutt’oggi questi ultimi non ricordano una sola delle note suonate quella sera dai compagni di palco. L’incontro è tuttavia fecondo di ispirazione per Andy, che comincia ad accumulare idee di stampo progressivo per un ipotetico futuro disco solista.
2002: un demo è pronto e giunge alle orecchie di un compiaciuto Roine Stolt (Flower Kings), che subito offre la collaborazione della propria chitarra, imitato dal basso di Jonas Reingold e dalle pelli di Zoltan Czorsz. Dai Parallel or 90 Degrees viene a dar man forte la pianista Sam Baine, e con l’arrivo del celeberrimo flautista e sassofonista dei Van Der Graaf Generator, David Jackson, la line-up può dirsi completa. Il frutto degli sforzi dell’ensemble internazionale è The Music That Died Alone, un piccolo capolavoro che proprio non vuole somigliare al solito progetto solista di un professionista della tastiera. E’ nata una vera e propria band, serve un nome nel quale tutti possano identificarsi: prendono così vita i The Tangent.
I responsi positivi che accolgono l’esordio aprono la strada a un seguito in tutto e per tutto all’altezza: The World That We Drive Through, il quale vede l’avvicendamento ai fiati tra l’uscente Jackson, impegnato dalla reunion della band madre, e il degno successore Theo Travis, portatore di un piacevolissimo bagaglio di esperienza jazzistica che risalterà nel successivo e fortunato tour europeo (da cui sarà tratto il live Pyramids and Stars).
Lo scenario pare dei più rosei, ma improvvisamente sul finire del novembre 2004 la situazione precipita. I Flower Kings Roine Stolt – oberato di impegni – e Zoltan Czorsz annunciano la decisione di abbandonare la band, e con loro anche Reingold e Travis paiono sul piede di partenza: tutto lascia presagire che sui The Tangent sia destinato a calare il sipario…
Lasciamo alle parole dello stesso Andy Tillison il racconto degli eventi che hanno infiammato le ceneri della band agonizzante portandole a nuova vita: ciò che conta è che ora nelle mani abbiamo il terzo frutto delle fatiche dei Tangent.
Il biglietto da visita presenta una formazione versatile, eclettica e innamorata del rock progressivo nato nell’alcova di Canterbury, oltre che di quello più sinfonico dei maestri Yes. Andy è consapevole delle potenzialità della sua creatura, così come è consapevole del fatto che il nome dei The Tangent, per quanto stia cominciando a diffondersi insieme a commenti entusiastici tra i cultori del genere, non ha ancora avuto modo di affermarsi con l’autorità di un caposcuola. Ecco dunque A Place in the Queue, ardimentoso balzo in avanti con cui l’esperto tastierista tenta di superare l’oceano dei buoni gruppi per raggiungere i lidi su cui troneggiano gli immortali monumenti della musica. Un tentativo audace, che mira a raggiungere le altezze più elevate, altezze dalle quali basta un attimo per precipitare e sfracellarsi miseramente sugli scogli del biasimo o – peggio – dell’indifferenza generale.
Per riuscire nell’impresa Andy dà fondo alle proprie riserve creative fino a colmare pressoché tutti e ottanti i minuti di capienza del disco: “un doppio album in un singolo cd”. La quantità tuttavia non è certo sufficiente a conseguire successi se non accompagnata da una qualità limpida e cristallina: molte sono le band che proprio qui hanno fallito, tentando un passo troppo più lungo della gamba e cadendo proprio al momento cruciale. Ma non è questo il caso.
Come insegna la genuina tradizione progressiva i Tangent attingono a piena mani dagli universi paralleli del blues, del jazz e della musica classica, amalgamando i diversi ingredienti con la maestria dell’esperienza fino a plasmare sette brani tanto brillanti da abbagliare, ciascuno dotato di un’individualità spiccata e ben definita.
La portata principale è costituita non da uno ma da due colossi musicali di venti e venticinque minuti, rispettivamente posti in capo e in coda all’opera, da digerire senza fretta, assaporandone con voluttuosa lentezza ogni sfumatura di gusto. A dispetto di un’introduzione in punta di piedi, l’iniziale In Earnest si configura presto come la più frizzante delle due sorelle, grazie alla vivacità delle onnipresenti tastiere di Tillison, e trova la propria forza nella sapiente alternanza tra accelerazioni dinamiche e morbidi rallentamenti di gusto sinfonico. L’apice del pezzo coincide forse con i suoi minuti finali, che da un break di gusto classico si sviluppano poco a poco in un lento crescendo, dal quale prende vita un sontuoso assolo di chitarra, presto affiancata dalle tastiere, in una reciproca sovrapposizione prolungata fino all’ultima fugace ripresa del tema principale.
Più sensuale e suadente la title track conclusiva, frutto di uno sforzo a quattro mani del solito Tillison e del jazzista Travis. In rilievo, com’è lecito aspettarsi, passano i fiati, sassofono su tutti, e a giovarne è per prima l’atmosfera del brano, soffusa e romantica per la prima parte, più convulsa e concitata nei passaggi centrali, quelli in cui emerge prepotentemente il volto sperimentale della band, sempre mitigato da una robusta dose di melodie di gran classe.
A separare i due giganti ecco una doppia coppia foriera di sorprese, nascoste proprio là ove meno si sarebbe pensato di trovarle. Una volta emersi dalle nebbie policrome dell’evocativa Lost in London, districati i camaleontici intrecci psichedelici di Follow Your Leaders, troverete infatti ad attendervi due piccole gemme che a dispetto della durata proprio non riescono a considerarsi semplici intermezzi. E mentre l’improvvisazione jazz di DIY Surgery intratterrà gli amanti delle scorribande strumentali venate di una follia à la Frank Zappa, l’inatteso colpo di scena The Sun in My Eyes illuminerà insospettabili lidi disco-music strappati a forza agli anni settanta, conditi da una melodia scippata agli Animals di Don’t Let Me Be Misunderstood: un esperimento senza dubbio originale, divertente (prestate orecchio ai testi) e del tutto azzeccato oltre che un potenziale singolo di sicuro successo anche per il grande pubblico.
Baricentro dell’album e nodo cruciale della perfetta asimmetria delle sue parti è la hit GPS Culture – arricchita dalle chitarre di Dan Watts (Po90D) – che oltre ad appagare i palati dei nostalgici degli Yes grazie ai suoi cori avvolgenti e alle sue saltellanti danze di note variopinte, incarna eloquentemente il concept sotteso dai testi e suggerito dal titolo. A Place in the Queue, un posto in fila, in quella quotidiana interminabile lista d’attesa in cui ciascuno segue chi gli sta davanti senza sapere dove stia andando e perché, troppo preoccupato di conservare il proprio posto, e magari di scavalcare quello davanti, per poter pensare di uscire dall’insensato girotondo.
Ma dopo tante parole, la penna deve fermarsi, consapevole che quanto ha potuto dire finora del contenuto musicale dell’opera è senza dubbio insufficiente rispetto all’indescrivibile eterogeneità di sette brani che necessiterebbero di troppo inchiostro per poter essere introdotti in modo appena esauriente. Né miglior sorte attenderebbe chi volesse dedicarsi all’esame delle individualità chiamate in causa di volta in volta: basti osservare di passaggio che l’apprezzamento maggiore va tributato alla band nel suo insieme, per la capacità di condurre i giochi all’unisono, al pari di un solo strumento che cambia pelle di volta in volta assumendo le forme richieste.
E’ dunque questa la concezione di prog rock che Andy Tillison propone ai contemporanei: uno stile più che mai eclettico, vivacizzato da una robusta dose d’improvvisazione, consapevole debitore di un passato che pure tenta di superare, interpretando con gusto moderno quell’originale istinto di sperimentazione che fin dalle origini dà linfa al movimento progressivo. A Place in rhe Queue si dimostra così figlio di una personalità forte, cosciente del proprio valore e determinata non soltanto offrire buona musica, ma anche a rappresentare un punto di riferimento per chiunque in futuro voglia avvicinarsi al genere: ciò che serve per incidere indelebilmente il proprio nome tra i classici della storia del rock.
Dunque possiamo da ultimo tornare al quesito iniziale: combattuti tra la passione di chi già grida all’immortale capolavoro e la prudenza di chi puntualmente stempererà gli entusiasmi, di chi bisogna fidarsi? Forse non è dato trovare una risposta a questa domanda, ma se proprio dovete affidarvi a qualcosa, signori, il mio piccolo suggerimento è: fidatevi delle vostre orecchie.
Tracklist:
1. In Earnest (20:03)
2. Lost in London (8:08)
3. DIY Surgery (2:16)
4. GPS Culture (10:07)
5. Follow Your Leaders (9:21)
6. The Sun in My Eyes (3:44)
7. A Place in the Queue (25:19)