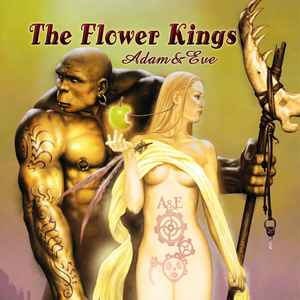Recensione: Adam & Eve
Un gruppo come i The Flower Kings, confessiamolo, non può comporre brutti album. Il combo, nato a metà anni Novanta attorno al mastermind Roine Stolt, ha fatto dell’anti-commercialità e della genialità progressive il proprio blasone; a queste va aggiunta una prolificità realizzativa impressionante, sempre su buoni livelli qualitativi, scusando la solita prolissità degli svedesi. Negli anni c’è stato, d’altra parte, un mutamento nel loro sound: i “TFK 2.0”, quelli (per intenderci) a partire da Space Revolver, suonano meno rock, ma più raffinati e maturi.
In questo contesto, Adam & Eve si ritrova album felicemente “isolato” tra due doppi album della band svedese, il capolavoro Unfold the future (del 2002) e il meno riuscito Paradox Hotel (del 2006). L’ottavo platter in studio degli scandinavi è, altresì, l’unico disco con Daniel Gildenlöw membro ufficiale in line-up, dopo la felice apparizione nel precedente album. La sua permanenza, tuttavia, sarà effimera e non confermata in futuro.
La copertina “primitivo-chic” su colori complementari allude ai testi del full-length che trattano del contrasto maschile-femminile (luce-ombra, attivo-passivo), come tracce leitmotiviche di una musica che vive proprio dell’alternanza di sonorità più e meno sognanti. Non manca poi il tema del tempo e della sua paradossalità in brani come “Timeline” e “Driver’s Seat”, con la giusta compresenza di sacro e profano.
La proposta musicale di Stolt & Co, tuttavia, pur restando su livelli tecnici notevoli, in questo album non prosegue nella direzione di Unfold the future e ne rinnega bruscamente le contaminazioni jazz e fusion, che potevano preludere a un nuovo corso stilistico della band. Un ritorno alle origini, dunque, con la solita produzione cristallina e un velato mea culpa per non voler osare ancor di più che in passato. Disco di maniera, in definitiva, ma ancora una volta gratificante.
Come invalso nel progressive, in apertura si trova una suite caleidoscopica, la prima delle due (insieme alla già citata “Driver’s Seat”) che possono essere considerati i momenti migliori di Adam & Eve. Fröberg fa da padrone al microfono e l’andamento sonoro è amichevole, con linee di basso appaganti di Reingold. Il refrain resta impresso fin da subito nel suo ottimistico fulgore: «It shines even brighter, for each single day we’re climbing the ladder / It shines even brighter, with a love supreme, all the work of the master’s hand». Ottimi gli abbellimenti chitarristici che danno un tocco di solennità agli arrangiamenti. L’affiatamento tra Reingold, Stolt e Csörsz è d’applausi e crea un sound unico: più in ombra l’eclettico Bodin, ma il suo apporto sarà meglio valorizzato nel prosieguo della scaletta. “Love supreme” scorre come azzerando il tempo: ascoltandola pare di stare a osservare un cielo sereno e il percorso ramingo di qualche nuvola smarrita. Lo stile di Stolt è, come ci ha abituato, un concentrato d’ispirazione e canone della naturalezza espressiva: come suonare difficile, ma far sembrare tutto una bazzecola. Memorabile lo stacco di chitarra acustica al min. 12:00, con Stolt a cantare: «It must be something that makes me feel right at home», cui risponde Fröberg («And all my wanting is down to understanding») su armonizzazioni di Gildenlöw. Questo trio è da brividi, peccato non figuri nella successiva discografia degli scandinavi. Da segnalare una delle ultime strofe, con testi che preludono a un finale appagante, insistendo su anafore ben calibrate («Every time we give, but not for selfish reasons / Every time a flower bursts to bloom in the desert / Every time a politician is telling the truth / Every time I see an end to a lifelong blues / It must be something that makes me feel right at home»). La composizione termina con un pianissimo che chiude circolarmente l’opener. In sostanza venti minuti di goduria prog. con echi degli Yes di Tales from Topographic Oceans e altri grandi dei Seventies.
I TFK non hanno mai negato che la loro proposta musicale inglobi anche elementi circensi e della tradizione folk scandinava. Nel caso di “Cosmic Circus” (che poco ha a che vedere con il classico “Circus Brimstone”), siamo di fronte a un delizioso brano gipsy di tre minuti. Fröberg al microfono, voci secondarie di Stolt e Daniel, hammond e l’inconfondibile ricerca melodica degli svedesi.
Progressive significa anche alternare suite e brevi composizioni, come la successiva “Babylon”, conciso e fatato brano strumentale scritto da Bodin, con ottime linee di basso e tastiere in risalto. Un intermezzo che continua sulla falsa riga delle atmosfere amichevoli dei primi due brani del platter.
I toni cambiano bruscamente, invece, con “A Vampire’s View”, canzone che per certi versi stona con l’identità del full-length e che per altri regala una versione inedita ed eclettica del combo di Stolt, con un istrionico Gildelnlöw come protagonista. L’inizio, un lungo crescendo mimetico, è tra i momenti che restano impressi nella memoria: «I am back at the beginning, I have a crust upon my eyes / I’m alone in this my blindness, I’m alone but there is still life […] Like one of those people that are nothing but evil / A life of regrets is saved in the flower of death». A parlare è un anonimo vampiro che sembra emerso da un passato imprecisato. Le percussioni di Bruniusson donano un tocco di preziosità suggestiva. Sulle parole «I ‘ll go underground, when the sun beats down», rintoccano oscure campane e il fretless di Reingold disegna linee sinuosamente penetranti. Lo sfogo del vampiro raggiunge l’apice: «I’m the man without shadow / […] There’s no man in the mirror, just me and I hate what I see!» Il ritornello diventa commovente, così il crescendo attorno al sesto minuto. Bodin suona meste cadenze di pianoforte, poi gli ultimi minuti strumentali sono pirotecnici, ma non privi dell’oscurità presentata all’inizio del brano. “Days Gone By” è un divertissment che fa da coda al precedente pezzo teatrale, con un piano solista che ben rende il susseguirsi della spietata monotonia cui è costretto la malinconica figura tormentata senza ombra.
E ancora il mastermind dei Pain of Salvation convince in apertura di title-track: Daniel qui dà il meglio di sé e sa essere camaleontico come pochi. I testi di “Adam & Eve” sono, altresì, piuttosto arditi per gli standard dagli svedesi e la voce androgina e acuta di Gildenlöw è perfetta nell’interpretarli: «Adam and Eve […] Found themselves drift in the dangerous zone / Like a priest and priestess in the pleasuredome». I veloci ritratti dei progenitori dell’umanità sono caricaturali come in copertina: «Adam was handsome but somewhat bizarre, / he looked at himslef like some kind of pornstar […] Adam would feed his internal debate / the dividing line between “make love” and “rape”». Adamo fusto un po’ tocco, dunque, mentre Eva appare (ebbe sì) vestita come una prostituta («she was dresses like a hooker»). Non stiamo certo parlando dei personaggi del Genesi, bensì dei prototipi dell’eterno maschile e femminile. La parte strumentale a metà brano è d’applausi, con un Reingold scatenato al min. 4:20. Le strofe meditabonde cantate in seguito da Stolt hanno testi tra il nonsensical e il filosofico: «We’re all connected through the blood, just different images and different Gods / The primal goal is to stay alive, to bread and live, thru love we cry». Trova spazio anche un riferimento intratestuale («A dark and distant ancient dream, a dream named “A Love Supreme”»), che ritornerà alla fine del platter, e una chiusa ironica («And when I look into your face… Is that the devil on a racehorse?») da ricondurre alla (presunta) misoginia degli svedesi, già cantata in brani come “Stupid Girl” e “Elaine”. Negli ultimi minuti torna Daniel al microfono e Fröberg si concede uno sguaiato urlo liberatorio da risata pura. Il brano parla, infatti, di come yin e yang siano legati indissolubilmente in una complementarietà gravosa e necessaria al contempo, ma i registri su cui si muovono i The Flower Kings sono sempre tutt’altro che tragici.
Dopo il profluvio d’energia della title-track, “Starlight Man” ha del consolatorio con il suo attacco dagli accordi dimessi. Nel refrain («I’m beside you / I’m the starlight in your mind / Look inside me / I am you, that’s what I am») brilla il fretless di Reingold e le note di Bodin. Tre minuti spensierati, con Daniel nel finale a dare una mano nei cori.
Inizio cacofonico con un Bruniusson sugli scudi per “Timelines”, composizione dalle tinte lisergiche e blues (che saranno protagoniste nel disco solista di Stolt, Wallstreet Voodoo del 2005). Il brano ha qualche affinità con “Thoughts Pt. II” degli Spock’s Beard e presenta una parte iniziale e finale sostenute, mentre i minuti centrali sono su registri compassati. La classe di Stolt al microfono è sempre un piacere, nei TFK quanto nei Transatlantic. I testi trasudano saggezza: «Time is a thief and timelines invisible / […] You can’t fight time and you can’t just shine on / Like in big bold American style». Un invito a riconoscere i limiti umani e a godersi la vita senza isterismi: «The ticking of time is non reversible / So sit back my friend, enjoy the ride».
Seconda e ultima suite del platter, la magnifica “Driver’s Seat” è prismatica e pazzoide, come da tradizione Gentle Giant. Una simile traccia non sfigura se accostata ai grandi classici degli svedesi e fa la gioia di ogni progster incallito. L’inizio ottimista e trascinante conferma quanto l’affiatamento della line-up sia il valore aggiunto degli scandinavi. Ritroviamo Daniel alla voce, dopo uno stacco attorno al secondo minuito, a opera di Bodin. Tra dissonanze e cadenze varie, al min 4:46 il brano acquista nuovo rigoglio, quasi fiume cristallino che torna a sgorgare all’improvviso. Dopo strofe cantate da Fröberg, al sesto minuto Stolt guida l’ascoltatore in un viaggio con meta la vecchia terra d’Albione: «Hope for a glorious Sunday / Push back the crappy Monday / Eight days to cross the poles / And reach the soil of old Britannia». Attorno all’ottavo minuto i suoni si fanno oscuri e velati; ottimi i fill di batteria, mentre Bodin crea suoni spettrali alle tastiere. Quando, trascorsi un centinaio di secondi, i ritmi si calmano nuovamente, si ha l’impressione di essere come “sopravvissuti” a un naufragio lungo un tunnel sonoro impervio. I giochi, però, non sono ancora terminati e, dopo pochi secondi di silenzio, il brano si rianima dimessamente su accordi semiacustici di chitarra. Scopriamo che la suite è un ritratto metaforico della vita: «On to the riverbeds of time / We’re scattered driftwood in a sad and lonely line / A sum of incidents called “Life”». Nel prosieguo Fröberg canta strofe tirate e Stolt è più spigoloso che mai alla chitarra. Le liriche rasentano lidi ambiziosi: «Just as the river made a hole inside the mountain / You throw your soul into the hole of the great nothing» (il “grande nulla” degli Spock’s Beard di V ?) Si giunge, infine, all’ultimo refrain da cui è tratto il titolo del brano («And so you find yourself in the driver’s seat […] Time is such a bitch and fate it’s little sister»). Al min. 16:00 compare un altro bel riff di Stolt, mentre il finale in pianissimo è vicino ai Transatlantic.
L’album è praticamente concluso, “The Blade Of Cain”, con una ripresa del refrain iniziale, è un mero postludio atmosferico forte del baso di Reingold, armonie dilatate e la chitarra di Stolt a cantare la tragica vicenda della prole di Adamo ed Eva. Attorno al terzo minuto un fade-out sfuma la breve strumentale con echi del ritornello di “Love Supreme”, che, reinterpretato in chiave acustica e su toni drammatici da Fröberg, si carica di nostalgia e rimpianto. Conclusione mesta, ma l’ultima parola resta un inno all’amore supremo.
Quasi un’ora e venti minuti di musica targata The Flower Kings, che scorre senza forzature ed è ricca di piacevoli sorprese: questo un succinto ritratto di Adam & Eve. Se la prova della line-up è ancora una volta meritoria, non passa inosservata, tuttavia, qualche pecca nel considerare la personalità e la struttura dell’album nel suo complesso: “A Vampire’s View” non riesce a integrarsi in scaletta e resta un unicum nella discografia degli svedesi; i filler “Cosmic Circus”, “Babylon” e “Starlight Man” pur ben composti non lasciano il segno; infine s’avverte la mancanza di mordente e della pazzia che ha consacrato gli svedesi nei ruggenti anni Novanta.
Un buon disco in definitiva, a tratti troppo cautamente manierato, ma che merita ascolti attenti e non lascia totalmente insoddisfatti i fan del combo di Stolt di vecchia e recente data.
Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)
Discutine sul forum, nel topic dedicato ai The Flower Kings