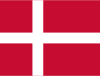Recensione: Allfather
Tempo di ritorni sulle scene per i danesi Vanir, che due anni dopo “Aldar Rök” pubblicano questo “Allfather”. Partiti una decina di anni fa proponendo un folk metal, diciamo così, caciarone e sopra le righe, i nostri hanno col tempo abbandonato gli aspetti più goliardici della loro musica avvicinandosi sempre più al death melodico, serioso e battagliero, di impostazione norrena, e bastano pochi secondi alla traccia di apertura “Væringjar” (anche se, per la verità, basterebbe dare un’occhiata alla copertina dell’album) per capire che anche stavolta l’andazzo è quello. Riff carichi e pastosi, melodie maschie riempite da tastiere vigorose e una produzione grassa – anche se sempre troppo bombastica per il viking come lo intendo io – a cui si aggiungono una sezione ritmica possente e temi riguardanti la storia danese e, in special modo, il re Svend Tveskæg; il risultato è un album robusto, veemente, in cui il già considerevole tasso di coatteria testosteronica dei nostri si impenna durante le brevi digressioni epicheggianti. Se tutto questo vi fa venire in mente qualcuno non temete, è tutto sotto controllo: in effetti, durante l’ora scarsa che compone l’ultima fatica del sestetto vichingo è impossibile non percepire l’ingombrante presenza degli Amon Amarth, ma una volta stabilito questo e inquadrato il terreno su cui ci si muove il resto è stato facile.
Al netto di quanto appena scritto, e senza dimenticare un tasso di prevedibilità altissimo, devo dire che “Allfather” non mi è affatto dispiaciuto: le canzoni sono immediate, cariche e cafonissime, accattivanti il giusto e ignoranti quanto basta, e cioè esattamente quello che mi aspetto da un album di questo tipo, con in più qualche insospettabile svolazzo folk in agguato dietro le quinte (forse per ricordare le origini del combo) per profumare un passaggio altrimenti monocromatico con quel quid che non guasta mai, senza prendersi la briga di dover spiegare per forza tutto e subito.
Si comincia con l’apertura poderosa e incombente di “Væringjar”: in un attimo l’aria si fa battagliera e i ritmi incalzanti, per un pezzo dinamico e dal marcato andamento folkeggiante a cui si affianca l’enfasi immediata dei brevi rallentamenti. Discorso simile si può fare per la successiva e più scandita “Svoldir”, il cui tono drammatico, però, unito a un approccio vocale più abrasivo e malefico, drappeggia il brano con atmosfere più vicine al black che non al death melodico o al viking. È però con “The Final Stand” che la band di Johan Hegg stende sui Vanir la propria ombra tutelare: riff corposi, densi e melodici, ritmiche scandite spezzate di tanto in tanto da fulminanti accelerazioni e tastieroni maestosi la fanno da padrone, confezionando un brano molto accattivante e dotato della giusta dose di coatteria. Il rumore delle onde e un ritmico pulsare aprono “Ironside”, marcia solenne che si carica di enfasi battagliera durante l’ispessimento del suono che occupa la seconda parte, in cui i nostri si giocano la carta dell’epica sborona: obiettivo centrato solo in parte, perché se è vero che la traccia nel complesso non è affatto male, la pesante carica di pathos di facile presa di cui è impregnata la appesantisce a mio avviso un po’ troppo, tanto che gli otto minuti e mezzo di cui è composta si sentono tutti. Per fortuna si torna nel mezzo della mischia con la furente “Shield Wall”, canzone agguerrita e frenetica che si ammanta di maestosità durante il ritornello più rallentato. “Fejd”, singolo apripista da cui è stato tratto un video, rallenta di nuovo per mantenersi su ritmi scanditi e trionfali, mentre il cantato più pulito di Martin Steene (cantante dei connazionali Iron Fire) si affianca alle solite harsh vocals: l’esperimento a mio avviso riesce, perché se è vero che il pezzo in sé (una power ballata trionfale, carina ma niente più) non mi ha entusiasmato, ho trovato gradevole questo doppio approccio proprio per movimentare un po’ la monotonia di Martin Håkan, forse un po’ poco incisivo (anche se, per spezzare una lancia in suo favore, va detto che anche la produzione non è esente da colpe in questo senso).
Dopo la cover di “Thor (the Powerhead)”, carina ma anch’essa penalizzata da un approccio vocale piuttosto incolore, si passa all’arpeggio vagamente inquieto di “Bearer of the Word”, altro brano scandito in cui i nostri abbandonano la tracotanza che li ha contraddistinti finora per insinuare nel loro tessuto sonoro ombreggiature più maligne. Questa tetra atmosfera viene spezzata di tanto in tanto da brevi interludi, ora combattivi, ora compassati e ora addirittura bucolici, salvo poi tornare alla fine per esigere l’ultima parola e aprire la quadrata e insistente “Ulfhednar”, nobilitata da una bella impennata nel finale ma, nel complesso, piuttosto monotona, anche per colpa di tastiere troppo asfissianti. Il profumo di Amon Amarth torna insistentemente in “Einherjer”, altra canzone ostinata in cui la tracotanza dei nostri viene trattenuta a stento da una struttura di riff pulsanti molto classica, solo sporadicamente stemperata da passaggi più ariosi. Bello anche l’intermezzo rallentato che apre la seconda parte del brano. Chiude l’album “Gravfærd”, monolite solenne introdotto da un arpeggio compassato ma anche vagamente teso: anche qui i ritmi si mantengono perlopiù scanditi, per consentire al trionfalismo latente del brano di distendersi in lungo e in largo, strisciando tra un riff e un giro di tastiere, e di prendere congedo dai fan con la giusta dose di pathos.
“Allfather” è sicuramente un lavoro riuscito, carico e ignorante, che di certo farà la felicità dei fan di un certo modo di intendere il viking: melodie azzeccate, riff corposi e ritmi battaglieri; forse le tastiere vanno ad inficiare un po’ la ruvidità complessiva e non si può certo dire che sia originale, ma compensa la sua prevedibilità intrinseca con un’attitudine propositiva e una certa varietà interna che alla fine mi hanno lasciato addosso una piacevole sensazione di pancia piena. Ascolto naturalmente consigliatissimo ai fan di Amon Amarth e del death melodico più coatto.