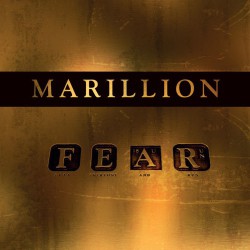Recensione: An Hour Before It’s Dark

Thank you for making me truly, truly alive
In a life where luxury was sometimes, to survive
Under the weight of lost love, disillusionment and shame
You came warm, and loved me like a tropical storm
Spiralled me up into the air
(da “Care”, pt II. An Hour Before It’s Dark)
Quarant’anni di carriera e il traguardo dei 20 studio album in vista: chi è fan dei Marillion conosce le sfumature emozionali che questa band ha saputo regalare nel corso dei decenni e ancora oggi la magia non è svanita. Dopo FEAR (uscito nel 2016) e due live act (All One Tonight del 2018 e With Friends at St. David’s del 2021), An Hour Before Is Dark conferma la sapiente alchimia che contraddistingue il sound di Steve Rothery e compagni, che si affidano di nuovo a un artwork minimale e al sagace produttore Mike Hunter. L’album curiosamente esce, inoltre, in contemporanea con By Royal Decree dei cugini The Flower Kings ed è come ritrovarsi di fronte a due lati opposti e complementari d’intendere il progressive: colorato e falotico quello degli svedesi, intimista e chiaroscurale quello degl’inglesi.
An Hour Before Is Dark si compone di sette tracce, due delle quali oltre i dieci minuti e una di pochi secondi. La scaletta in realtà comprende le singole parti delle canzoni più lunghe così arriviamo a 18 song complessive. L’avvio di “Be Hard on Yourself” è subito trascendentale e malinconico. Il pianoforte di Mark Kelly e le ghost note al rullante di Ian Mosley magnetizzano l’ascoltatore, le atmosfere sono elegiache in perfetta tradizione Marillion, con alcune improvvise schiarite. Questo non significa che i testi abbiano perso il mordente che contraddistingue l’identità del gruppo inglese: in “Lust for Luxury”, infatti, le liriche sono caustiche e la mente torna per un attimo al capolavoro Brave: «The monkey wants a new toy / And that’s all that it knows». Ascoltando l’ultimo movimento, “You Can Learn”, a tratti (specie all’avvio e nel finale) sembra di volare sospesi in una dimensione senza gravità, potenza delle sette note…
Proseguendo nell’ascolto, Steve Hogarth si diverte nell’interpretare i testi ambientalisti di “Reprogram the Gene” che recitano «I don’t wanna be food for the trees / […] As the planet simply shrugs us off / […] Listen to Greta T». Non manca una sezione centrale floydiana e un terzo movimento tra l’ottimistico e il perplesso: «Reprogram the gene / We’re clever enough / But / Is there a cure for us?». Dopo il brevissimo intermezzo strumentale “Only a Kiss”, “Murder Machines” accenna al tema della pandemia ma in realtà dipana una riflessione esistenziale sul tradimento tra esseri umani. Mai come in questi tempi il principio di autoconservazione e quello di autodistruzione collidono in modo potenzialmente nefasto per l’intero pianeta. Fanno bene i Marillion a non evitare la tematica e metterla in musica ricamandole un abito musicale sempre raffinatissimo che potenzia il messaggio delle liriche basate sull’uso massiccio di anafore.
“The Crown And The Nightingale” è pura poesia, la metafora del sole avvolto nella seta («Wrapping the sun …with silk») riesce a trasmettere un’emozione che travalica i limiti del pensiero razionale e fa di un ossimoro un inno di gioia assoluta. Il brano, in aggiunta, sembra l’epitome di certo rock postmoderno e nei testi vengono citati sia Christo, sia Elena di Troia.
Mancano all’appello le ultime due suite dell’album. I dieci minuti di “Sierra Leone”
richiamano i toni sognanti di Marbles, riproponendo la dissociazione tra musica e testi. Lo stato africano che dà nome alla composizione è tristemente noto per i blood diamond che abbiamo conosciuto con il film di Edward Zwick, ma il diamante che trova per caso il protagonista all’inizio del brano non va inteso solo in questa chiave, semmai si carica di simbolismi stratificati. Uno dei climax è contenuto nel terzo movimento con Hogarth a cantare «Walking free / In Freetown». Le dinamiche sono curatissime e le parti di pianoforte aggiungono ulteriore spessore a una traccia che prelude al gran finale del platter, intitolato semplicemente “Care”, suite divisa in quattro parti. Il primo brivido arriva dopo un paio di strofe, quando H sussurra in francese un sibillino N’est-ce pas seguito da un breve e alato assolo di Rothery.
Le tinte notturne della suite e l’uso di sintetizzatori eterei si spiegano arrivando al secondo movimento, “An Hour Before It’s Dark”, due minuti di poesia e perfetta sinergia tra musica e parole (rimandiamo alla citazione messa in apertura di recensione). “Every Call” inizia riprendendo il primo verso del precedente segmento («These are the days that will flash before our eyes at the end») ma ritorna anche il diamante di Sierra Leone che qui acquista ulteriore carica simbolica andando a legarsi al tema del luxury. Sembrerebbe tutto finito, invece il disco cala il sipario nel migliore modo possibile, con un momento degno del miglior Vangelis e lascia emozionati. Ascoltare “Angels on Earth” è un’esperienza che ha del mistico: il mantra “The angels in this world are not in the walls of churches” è ipnotico e spalanca scenari spirituali da brividi. Viene in mente la donna angelo stilnovista, in un tripudio di armonie delicate, opera dei sintetizzatori, su cui s’innestano le note di chitarra di Rothery sempre bravo a centellinare il suo apporto solistico. La presenza di cori rende il tutto ancora più coinvolgente, difficile trattenere le lacrime. Purtroppo anche “Angels on Earth” ha un termine e così finisce l’ascolto di An Hour before the dark. Siamo visibilmente soddisfatti, la catarsi è avvenuta immancabile.
Tra le cose per cui val la pena vivere, oltre alle sinfonie di Mozart, la musica di Louis Armstrong, i film svedesi, l’opera di Flaubert e le mele di Cézanne, possiamo a ragione invludere anche la musica dei Marillion, un toccasana per l’anima. Gli va dato merito: quando la tecnica non è tutto e si punta dritti al cuore, i risultati sono magnifici. Lunga vita alla band inglese, aspettiamo da loro altre perle… o forse è meglio dire diamanti.