Recensione: Animus
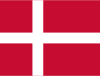

Stavolta è il turno dei danesi Royal Deceit, ad arrivare al debut-album, “Animus”, con relativa rapidità in un genere apparentemente semplice come quello del metalcore. Sì, perché le nazioni mitteleuropee e la Danimarca, Regno Unito incluso, pare abbiano davvero qualcosa in più in materia del genere predetto, versante melodico.
Non si tratta affatto di uno stile facile ed elementare, come amano affermare i suoi detrattori. Anzi, una delle sue principali peculiarità è la pulizia e precisione dell’esecuzione, ineccepibile nel delineare un sound fresco, scoppiettante, pulito e, soprattutto, affilato come una lama di rasoio come da tradizione della famiglia *.core.
Il che non è da tutti.
I Royal Deceit obbediscono a tali dettami con estrema naturalezza e scioltezza, come se fossero in campo da molto tempo e non dal 2014. Sicuramente la fedeltà alla foggia musicale scelta toglie un pizzico – ma neppure tanto, come si vedrà più avanti – di originalità all’insieme, giacché non mancano i ritmi rutilanti, i ritornelli catchy e la pesantezza dei micidiali breakdown che spezzano letteralmente le ossa.
Un suono pertanto possente, massiccio, dal notevole impatto frontale grazie al muro di suono elevato dalla strumentazione elettrica coadiuvata da un batteria che si potrebbe utilizzare a mò di metronomo (‘Chasing Ghosts’). Muro di suono abbellito con decisione dai profondi intagli operati dai soli di chitarra. O, meglio, dagli arzigogoli armonici elaborati dalle sei asce medesime.
Su tutto emerge la bravura di un cantante che risponde al nome di Mathias Rønde Uldall-jessen, grande trascinatore con la sua ugola caleidoscopica, capace di raschiare la pelle con la scabrosità delle harsh vocals ma, anche, di elevarsi in alto durante le parti in clean; ovviamente utilizzate in occasioni dei numerosi chorus che segnano indelebilmente il disco. Come per esempio quello di ‘Elitist’, semplicemente stupendo, che si schianta con forza sulla parete interna della scatola cranica per non uscirne mai più. A rendere varia la pietanza, inoltre, occorre osservare che non mancano neppure parecchi segmenti affrontati con la tecnica growling. E, naturalmente, i mirabolanti cori, retaggio specifico e proprio del melodic metalcore.
La varietà dei colori delle linee vocali si riverberano inevitabilmente nelle canzoni. Anch’esse mai simili a se stesse. Obbedienti al comune denominatore che si chiama marchio di fabbrica della band, in grado, essa, di imporre una decisa personalità e un sound adulto, immune da difetti e davvero notevole in quanto a serietà e professionalità, grazie all’impegno in esso profuso dal combo di Skanderborg. Giovane ma assolutamente in grado di competere ad armi pari con i migliori interpreti del tipologia artistica in esame.
Da ‘History Repeats’ a ‘Echoes of Hate’, quindi, si può godere di un tragitto ricco di piacevoli sorprese, insite in ciascuna delle tracce, le une dissimili dalle altre; con la melodia che non diviene mai stucchevole, ampollosa. Difatti, data la struttura poderosa che regge le tracce stesse come fa un tronco d’albero con i suoi rami, resta difficile pensare ad “Animus” come a un qualcosa concepito per ottenere un facile successo commerciale. Al contrario, gli aspri puntoni che, qua e là, spuntano materializzandosi in rabbiose dissonanze (‘Hang Them High’) e la ridetta energia che travolge chi ascolta, fanno del full-length un qualcosa a uso e consumo solo e soltanto degli appassionati, dello zoccolo duro del metal, cioè. Il che conferma i Royal Deceit abilissimi anche nel songwriting, ma non di quello floscio ed edulcorato di certi colleghi, quanto tosto, duro, deciso. Capace di donare al loro metalcore, come si è più su accennato, un quid in più, rispetto alla media, di anima e cuore.
Una piacevolissima sorpresa, insomma, e null’altro da aggiungere.
Daniele “dani66” D’Adamo

