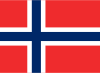Recensione: Another Return
C’è stato un tempo prima del tempo nel quale in Scandinavia il metal non era una religione (nera), nel quale non bastava dire “Svezia” o “Norvegia” per scatenare orgasmi borchiati e blasfemi in giro per il pianeta, anni nei quali Inghilterra, Germania e Stati Uniti rimanevano i capisaldi inviolabili del verbo metallico. La stragrande maggioranza di band era di là da formarsi, il reflusso hard rock non si sapeva nemmeno cosa fosse, e le foreste illuminate nottetempo dall’aurora boreale non erano ancora popolate di panda e granchi impazziti (o meglio, non si era ancora passati dai demo underground ai debutti discografici).
In quel periodo fare hard ‘n’ heavy tra i ghiacci era una sfida che non garantiva alcun ritorno di fama, visibilità e denaro. Il manipolo di eroi era risicato, Heavy Load, Axe Witch, Overdrive, Torch e pochi altri da una parte (ma c’erano già anche i Bathory), TNT, Witchhammer, Conception, Rough Justice, Private Eye dall’altra. Nella cosiddetta terra dei mille laghi c’erano pure gli Artch, capitanati dal vocalist islandese Eirikur Hauksson (rivisto per altro nel 2006 all’Eurovision Contest).
Ricordo di aver comprato il loro esordio “Another Return” un anno o due dopo l’uscita effettiva (1988), arrivato di importazione in un negozio specializzato della mia città. La copertina, semplice e un po’ naive, mi affascinò moltissimo. Non era la prima volta che acquistavo un album suggestionato quasi esclusivamente dal suo aspetto, però ad intuito stavo messo bene e spesso ci azzeccavo. Fu così anche stavolta perché “Another Return” non mi deluse affatto. Nel corso dei lustri non ho granché sentito parlare degli Artch, sono caduti subito nel dimenticatoio, o peggio, non sono proprio mai usciti dal novero delle band di quartiere della propria città (nonostante l’esportazione di qualche copia del vinile in giro per il mondo). A sorpresa recentemente si sarebbero riformati, producendo anche un dvd. Qualche palco celebrativo lo hanno calcato in giro per l’Europa e insomma, se sono rose (ri)fioriranno, stiamo a vedere.
Intanto, dall’83 all’86 i nostri avevano messo in fila tre demo; dei pezzi ivi contenuti la sola anthemica “Metal Life” verrà recuperata per “Another Return“. Il debutto è una album di metal solido e primigenio, che, ascoltato oggi, fa indubbiamente sentire il peso dei propri anni, ma che tutto sommato non è invecchiato malissimo. C’è il sapore delle cose antiche (e fatte bene), come dice la pubblicità di un noto amaro. I ragazzi avevano una impostazione classica, fondamentalmente maideniana, senza per questo scimmiottare pedissequamente la Vergine di Ferro di Albione. Il riffing soppesava equamente influssi tedeschi e anglosassoni, le melodie non erano di primo impatto (leggi: stucchevoli o troppo prevedibili) ma non per questo non riuscivano ad insinuarsi pervicacemente nel sistema cardiocircolatorio dell’ascoltatore. Su tutto ciò si stagliava stentorea la timbrica vocale di Hauksson, ribattezzato Hawk, valore aggiunto della formazione.
“Another Return” è un album semplice, maledettamente incisivo e accattivante proprio nella sua semplicità. Un disco demodé che gronda fascino da ogni solco e che oggi viene rieditato da Divebomb Records con nuove liner notes e foto. La label per altro si è assicurata pure i diritti del successivo (e altrettanto meritevole) “For The Sake Of Mankind“. La magnifica “Another Return To Church Hill” (un pezzo per il quale i vari Enforcer, Cauldron e compagnia revivalista del metal odierno pagherebbero per avere in scaletta), “Power To The Man“, “Loaded“, la già menzionata “Metal Life“, “Reincarnation” sono piccole gemme che hanno superato la prova del tempo, supereranno anche lo scetticismo di chi scopre solo oggi gli Artch?
Marco Tripodi