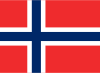Recensione: Arktis
La retorica trionfalistica con cui viene accompagnata l’uscita di alcune figure, figure attorno a cui ruota un meritato alone di leggenda peraltro, è tra le cose che maggiormente nuoce alla musica. Ma così va l’industria musicale: basta martellare il pubblico dicendo che un disco è megafigo e il pubblico ci crede, prima ancora che il disco sia uscito. Perché l’importante è che il disco venda il più possibile in relazione alla quantità di pubblico cui è destinato. E nel caso del nuovo di Vegard Sverre Tveitan – altresì detto Ihsahn – e del suo Arktis, la retorica, la pompa magna con cui è stato annunciato, veramente, aveva annoiato prima ancora che Arktis uscisse. E non perché Ihsahn non se lo meriti. Ma tant’è, diversi pezzi hanno anticipato l’uscita e altrettanti pezzi sono stati accompagnati da annunci, dichiarazioni e quant’altro, ciò che conta è che qualsiasi parola scritta a riguardo, sin qui, suona tra l’entusiasta e il molto entusiasta.
Fatto sta che Ihsahn è reduce da una prova che, a mio modesto parere, era buona ma non entusiasmante. Ma poco importa, perché ogni album deve fare storia a sé. Ad ogni modo, quanto sentito nei pezzi di “presentazione” di Arktis, dava l’idea che il nostro, riprendendo l’estetica dell’ormai terzultimo Eremita, avesse voluto strafare. Uno spettro sonoro estremamente ampio, un miscuglio di generi abbacinante, per risultati in tutto e per tutto diversissimi tra loro. Avrebbero potuto sonorità così diverse dar vita ad un tutto che stesse in piedi? Che fosse omogeneo senza disperdersi e risultare pretenzioso.
Beh…
La risposta è sì, e senza possibilità di obiezioni!
Arktis è la summa di un percorso artistico e, dato che si è parlato di molteplici influenze, sarà bene raccogliere i pensieri e inquadrare l’opera con ordine, per quanto difficile possa risultare. A semplificare le cose, ironia, viene proprio Ihsahn, che lascia in apertura quello che probabilmente è uno dei pezzi più ordinari tra quelli che sentirete nell’album. Di fatto però, anche Mass Darkness è un’opener strepitosa, retta da solidi riff di chitarra e da un groove davvero epico, nella miglior continuazione della linea tracciata da Barren Lands o da Arrival. Parte piano e nervosa da lì si leva un coro memorabile che mette splendidamente in luce l’ottimo clean del nostro, a parere personale la più bella voce pulita che la Scandinavia ci abbia dato, forse dopo il solo Kristoffer Rygg.
Al quinto minuto del disco sei già in orbita. Quello che segue è ancora meglio.
Segue uno dei tanti pezzi che hanno fatto da “singolo apripista”, Mass darkness, una cavalcata a dir poco insensata e geniale, un turbine di riff schizzoidi sui quali sono avvitati ulteriori ritornelli strepitosi che ancora una volta la poderosa cifra vocale del singer, letteralmente questo pezzo vola e sballotta l’ascoltatore tra continui cambi di ritmo e di atmosfera, sicché anche dopo diversi ascolti si è ben lungi da avere un occhio distaccato e capacità di analisi. Ma tant’è e meglio così.
Ora il track by track è pratica amatoriale che svilisce le recensioni, le rende noiose e schematiche, tipo bignami. Però è difficile analizzare questo album in altro modo.
Dall’inizio alla fine infatti Arktis è un immane tourbillon sonoro, con una moltitudine sterminata di influenze distribuite in maniera più o meno casuale, tramite una gestione schizzofrenica dei cambi di ritmo. My heart is of the north infatti è un pezzo di progressive, fatto di chitarroni psychedelici tipo Grateful Dead o anche Jefferson Airplain da un lato e mellotron dall’altro, sui quali comunque vengono inserite screaming vocals di rara ferinità, non fosse che ai tre quarti il pezzo si interrompe, e nessuno sa perché, e si arriva ad un’oasi di pace un po’ chill out e un po’ trip hop. La successiva South winds riporta alla mente Undercurrent (hai detto poco), e la arricchisce con attimi oscuri, minimali, di puro sperimentalismo, In the vaults ancora è un pezzo del tutto oscuro, quasi spoglio all’inizio, e successivamente viene arricchito da sfumature prog. Until I too dissolve vede la ricomparsa di riff settantiani permeati da freddezza nordica e interrotti da attimi di quiete cristallina e si rivela essere uno strepitoso pezzo di progressive blackened metal – e non so se il termine esista, ma dopo questa lo si potrebbe anche coniare – anche perché il pezzo successivo, Pressure, rappresenta l’altro lato della medaglia, un altro tourbillon di vertiginosi cambi di ritmo, in stile prog, ma ringhiosa e brutale (ritornello a parte).
A questo punto il disco rallenta, le trame si fanno lente, notturne, per quelle che sono le ultime quattro tracce. Ad aprire è Frail, con le sue ritmiche vagamente beatlesiane (se riuscite a sentirle, perché magari mi sbaglio) e la voce, caldissima, di Ihsahn che da voce ad un ritornello formidabile, quasi jazzistico – tranquilli, anche qui ci sono sfuriate di black… psichedelico. Dopo di che è la volta di Crooked red line, pezzo languido e da piano bar, altro pezzo usato, a buon diritto come apripista, ovviamente il growl riesce a farsi strada perfino qui. C’è ancora tempo per Celestial violence, pezzo oscuro e malato, con un grandioso, drammatico climax e, non ultimo, anzi, valore aggiunto, un duetto con Einar Solberg dei Leprous. In ultimo viene Til Tor Ulven, recitato metafisico in norvegese accompagnato da un pianoforte uggioso.
Ora la questione davvero seria: tutto questo malloppo non è per nulla di difficile ascolto!
Condensato in 48 minuti – cui si aggiungono i 9 del recitato – questo immane tourbillon sonoro vola via come se nulla fosse. Inutile l’ascolto dei singoli pezzi che ne hanno anticipato l’uscita, Arktis può e deve essere ascoltato esclusivamente per intero. Una proposta complessivamente impervia, in cui bene o male nessuna traccia somiglia particolarmente alle altre, è tenuta insieme da un songwriting magistrale. E da un gusto per la melodia, o meglio, da una capacità di creare melodie non banali, davvero rara. Sembra incredibile, dopo questa estenuante cavalcata descrittiva, trovarsi a dire che Arktis entra in testa nel giro di pochi ascolti. Tre, forse quattro. Ma testi alla mano, a quel punto si è già in grado di cantare più o meno tutto l’album, e poco dopo anche senza testi.
Ihsahn non confeziona il suo album più ambizioso – quello era Eremita, che pure però ogni tanto aveva degli attimi pesanti, verso la fine. Ci regala però un album di meravigliosa sintesi, di levata caratura artistica e di indiscutibile genio. Un disco non di rottura totale, ma comunque di indubbia evoluzione, un disco che guarda al futuro e risponde “vieni a sentirmi” a chiunque dica che il metal sta morendo. E soprattutto, come da tradizione prog, Arktis è un disco che fa sembrare facile il difficile, che si beve d’un fiato, quasi fosse musica d’intrattenimento. Eppure rimane impresso con ferina, geniale, grandiosità.
Vince tutto e contro tutti.