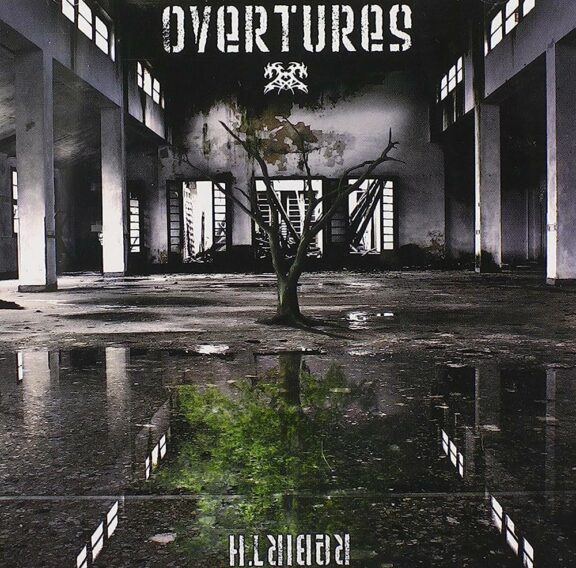Recensione: Artifacts
Tornano in scena gli Overtures, gruppo power di Gorizia che, in poco più di una dozzina d’anni (nascono ufficialmente solo nel 2003), ha saputo imporsi all’attenzione della critica e del pubblico con un trittico di album decisamente ben fatti. Oggi, a tre anni dal loro “Entering the Maze”, esce sul mercato questo “Artifacts”, ultima fatica dell’italico quartetto composto da Michele Guaitoli alla voce, Marco Falanga alla chitarra, Luka Klanjscek al basso ed Andrea Cum alla batteria. Dicevo poc’anzi che i sunnominati suonano power metal: in realtà non è proprio esatto, ma diciamo che il power è il genere che più si avvicina alla proposta dei nostri baldi ragazzoni, caratterizzata da tempi quadrati e massicce orchestrazioni che, pur dispensate a piene mani, non appesantiscono troppo le undici tracce che compongono questa loro ultima creatura.
Già l’inizio dell’album rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti: “Repentance” assale fin da subito l’ascoltatore con una ritmica spezzata, riff pennellati conditi da distorsioni ostentate e, come accennato, massicce iniezioni tastieristiche ad amalgamare il tutto. Michele giocherella con la voce, tra toni bassi e maligni e toni più alti ed esplosivi, lasciando l’iniziativa a Marco solo durante il breve assolo prima di reimpossessarsi della scena fino alla conclusione della traccia. Bel biglietto da visita. Anche la title-track parte macinando riff su riff, seppur marcati stretti dalle onnipresenti tastiere, ma si concede quasi subito un rallentamento per esplorare melodie apparentemente più contemplative sempre sorrette dal nervoso lavoro di chitarra, per poi elevarsi nel solenne ritornello e di nuovo giù, nel dominio dei riff. La canzone si fa strada così, alternando solennità e cattiveria anche durante il solo che spiana la strada al trionfale crescendo finale. In chiusura c’è ancora posto per una incursione del riff portante, che ristabilisce la sua supremazia un’ultima volta prima che tutto torni alla quiete.
“As Candles We Burn” si affida maggiormente al trionfalismo alleggerendo un po’ la cattiveria della proposta, pur mantenendo un buon ritmo: il risultato è, pur notificando una certa “ruffianeria”, la terza traccia su tre finora ascoltate che potrebbe fungere da singolo apripista per l’album. A buon intenditor, poche parole. “GO(L)D” sembra proseguire il discorso di cui sopra puntando, ancor più della precedente, su un incedere trionfale ed anthemico: non fatevi ingannare dall’improvvisa sfuriata dopo un minuto e mezzo, questo brano è fatto per farvi saltare e cantare ai concerti e sappiate che vi basteranno pochi ascolti per cedere a tale imperativo. A titolo di pura onestà devo ammettere che anche qui si sente un po’ puzza di ruffianeria musicale, ma direi che fintanto le canzoni si mantengono su questi livelli si può tranquillamente passare oltre.
È ora il turno di “Profiled”, traccia solare e molto melodica ma francamente poco incisiva, un po’ troppo canonica e inconsistente per essere degna di nota: il ritornello è abbastanza banalotto, e anche il resto della canzone, nonostante qualche bel gioco di batteria, sembra sottotono rispetto ai gioiellini che i nostri ci hanno fatto sentire finora. Va beh, una piccola flessione ci può anche stare. “Unshared Words” sembra abbandonare il trionfalismo delle precedenti composizioni per affidarsi a un incedere più diretto, ma ecco che con l’arrivo del ritornello ogni dubbio viene fugato col ritorno alle sfarzose melodie a cui siamo stati abituati. Anche qui, nonostante il livello si rialzi rispetto alla precedente “Profiled”, direi che ci troviamo dinnanzi ad un pezzo carino ma abbastanza scontato. La successiva “My Refuge” ricalca ancora gli stessi stilemi delle due tracce precedenti, con linee molto melodiche e un andamento quasi pop, per una canzone molto catchy che alla fine si lascia ascoltare ma, ancora una volta, non va oltre la sufficienza. Confesso che a questo punto inizio a preoccuparmi: dopo le prime quattro tracce strepitose sembra che il gruppo abbia tirato i remi in barca e proceda col pilota automatico, senza sforzarsi di creare soluzioni diverse dal solito compitino. Per fortuna arriva “New Dawn, New Dusk” a fugare, almeno in parte, le mie paure: messe (più o meno) da parte le onnipresenti tastiere, relegate per una volta a elemento di secondo piano, il brano parte con un approccio più chitarristico ed un incedere più aggressivo del terzetto di cui sopra. Michele trattiene la voce nella strofa, torcendola in un cantato nervoso che poi esplode nel trionfalissimo ritornello che, pur profumando di già sentito da lontano un paio di chilometri, si dimostra molto coinvolgente e, in soldoni, si lascia ascoltare che è una meraviglia. E si ritorna in pista giusto in tempo per la suite. Eh, sì, perché “Teardrop”, con i suoi dieci minuti abbondanti, è la traccia più lunga dell’album: l’inizio mi ricorda i Nightwish che furono (quelli dell’ultimo periodo con Tarja, per intenderci), con tutto il gruppo a sostenere le tastiere per dare alla traccia un respiro sontuoso e solenne, mentre la voce di Michele svetta nel mare di cori e contro-cori e duetta con quella di Caterina Piccolo, che insieme a Marco Pastorino (Secret Sphere, Temperance) e Paolo Campitelli (Kaledon) si mette a disposizione del gruppo in questa lunga suite, dispensando piccoli tocchi di classe a manciate. Considerate questa “Teardrop” la loro “Ghost Love Score” e chiudiamola qui, che tanto ci siamo capiti.
Chiudono quest’album “Angry Animals” e una versione alternativa di “Savior”, già presente in “Entering the Maze”: la prima è una canzone a modo suo divertente, veloce e tutta cori, che permette a Michele di sperimentare stili di canto, diciamo così, meno convenzionali; la seconda è, invece, una ballatona pomposa che conclude solennemente un album interessante, penalizzato da una flessione nella parte centrale ma capace di risollevarsi nel finale e di ritagliarsi meritatamente il suo spazio nel panorama metallico odierno. Ben fatto!