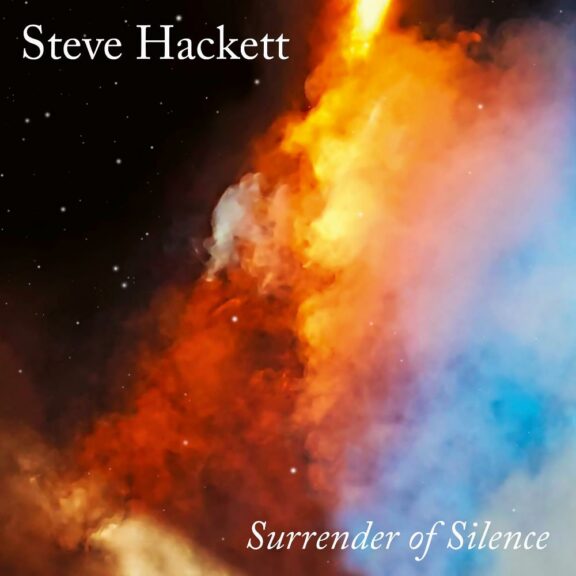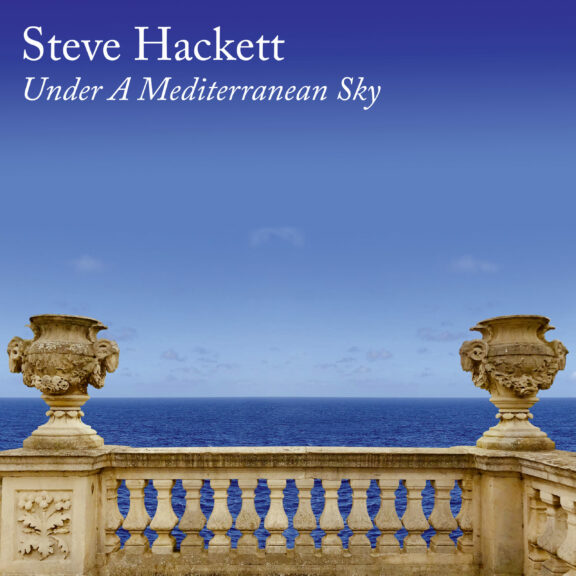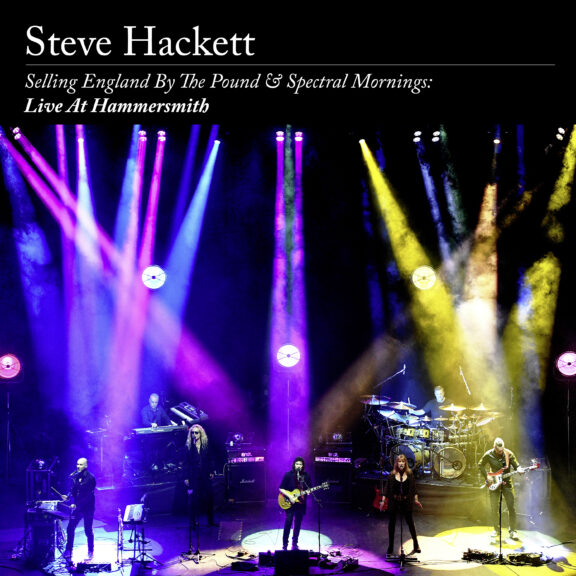Recensione: At The Edge Of Light

A quasi 69 anni l’ex chitarrista dei Genesis non sembra a corto d’ispirazione e la discreta attesa sollevata dall’uscita del suo nuovo disco (questo il suo ventiseiesimo in carriera) è la dimostrazione che la buona musica può anche sposare passato e presente. Dopo il valido The Night Siren, Steve Hackett (in veste di musicista e coproduttore) si avvale nuovamente del supporto di Roger King (al mixer e al mastering) e di un parterre di musicisti che non hanno bisogno di presentazioni, per realizzare, in circa 18 mesi (nel suo studio privato), un platter dalle mille sfaccettature sonore e che s’iscrive nella cornice variegata della world music (basti leggere l’elenco di strumenti etnici chiamati in causa) oltre che in quella del prog. rock. At the edge of light è un imaginative album che stupisce per inventiva, capacità di coinvolgimento emotivo dell’ascoltatore ma anche per alcuni momenti tirati (le parti acustiche non abbondano questa volta). L’artwork riflette la dicotomia tra luce e oscurità, in un periodo storico che vede riproporsi timori antichi, quelli legati alla chiusura rispetto all’esterno e alla diversità culturale. Siamo di fronte, infatti, a un platter che affronta le paure dell’uomo contemporaneo, da un’ottica cosmopolita e di cauto ottimismo, proponendo un abbraccio globale attraverso sonorità che vanno dall’India al nuovissimo continente. Vengono in mente i The Tangent di “The slow rust of forgotten machinery“, coraggioso full-length che tratta delle migrazioni in corso nel mondo, e saggi come “I muri che dividono il mondo” di Tim Marshall. Il tema è delicato, coinvolge al contempo mente e cuore dell’Uomo, il saggio artista a differenza del mediocre politico può diffondere un messaggio di speranza e dipingere un mondo ideale dove le differenze convergono per creare un mosaico euritmico invece che elidersi tra loro.
L’intro è di quelli più diretti mai composti da Hackett: “Fallen Walls And Pedestals” inizia con sonorità etniche, ma si rivela un crescendo maestoso con la 6-corde a ricamare sonorità floydiane. Un ottimo inizio, l’album si prospetta invitante e imprevedibile, come le armonie oscure all’avvio di “Beasts In Our Time”, traccia programmatica del full-length, con titolo che richiama l’espressione coniata nel 1938 dal poco lungimirante lord Chamberlain «Peace for our time», ma capovolta di senso: il monito homo homini lupus oggi purtroppo è tornato slogan attuale. Non a caso la voce di Hackett è pacata, tuttavia le parole dei testi sono taglienti e restituiscono un ritratto smagato del nostro tempo. All’interno del brano le note di tastiera e di sax creano una sinergia magnifica, così quelle di flauto e chitarra acustica; alcune trovate d’arrangiamento sono paragonabili a quelle di una colonna sonora e al quinto minuto il brano muta pelle e diventa puro prog. rock trascinante. Un’iniezione di positività che prosegue con la successiva “Under The Eye Of The Sun”, tra i momenti più riusciti del full-length, complice il basswork indiavolato di Jonas Reingold (The Flower Kings, Karmakanic). Così come l’occhio del sole ci ha riscaldato, in pochi secondi una nube vela il disco di Ra e ci ritroviamo per alcuni istanti in una dimensione esoterica, che si sostanzia in note arcane di didgeridoo e duduk. Inglobando questa breve sezione etnica, all’interno di un brano altrimenti fin troppo lineare e prevedibile, Hackett si rivela compositore geniale ed eclettico. E che dire del country e del gospel contenuti in “Underground Railroad”? Non siamo sui livelli di grazia della recente perla “Hold On To Love” di Jason Becker, ma resta musica davvero emozionante. Le voci femminili coinvolte appartengono addirittura a due sorelle che hanno registrato con i Pink Floyd, Durga e Lorelei McBroom.
A metà platter trova spazio la mini-suite “Those Golden Wings”, in cui emerge l’approccio orchestrale di Hackett. Si tratta di un viaggio sonoro che alterna strofe cantate sommessamente a sezioni maestose degne di un coro operistico. Le ali dorate messe in musica da Hackett confermano lo stato di grazia che sta vivendo il chitarrista inglese e la sua maturità espressiva. Difficile restare indifferenti di fronte a tanta creatività. Seguono cinque brevi tracce e le ultime tre vanno intese come a sé stanti. “Shadow And Flame” è un tripudio araboide con parti di sitar che dialogano con una base ritmica quadrata e la chitarra proteiforme di Hackett; per contrasto spicca poi la freschezza e semplicità di “Hungry Years”, ballad canonica con un grande assolo nel finale, tutto composto con una (apparente?) sprezzatura sopraffina. E arriviamo all’ultimo nucleo del platter. “Descent” è una traccia atipica, un lungo crescendo cadenzato dal ritmo marziale, un bolero martellante. Questa particolarità si spiega rifacendosi alle parole del mastermind, il quale ha deciso di chiudere l’album con una mini-trilogia che va dai toni cupi della discesa iniziale, al conflitto del secondo movimento (attimi strumentali concitati e angoscianti) per concludersi con la catartica “Peace”, un inno alla figlia di Zeus e Temi, di cui si sente la necessità più che mai in questo inizio di nuovo millennio.
Già dal primo ascolto At the edge of light merita i nostri applausi. Si sapeva che non sarebbe stato un album anodino, ma un piccolo capolavoro, c’erano le premesse più promettenti a riguardo. Il prog. per definizione vive di ibridazioni, Hackett è tra i maestri della contaminatio di generi e non sembra soffrire la propria età anagrafica. Il suo nuovo disco solista è un album organico, dove la priorità va all’architettura complessiva della tracklist, non alla singola hit. Il rischio di un’eccessiva dispersività dovuta alle tante sonorità presenti è stato evitato sapientemente, grazie alla capacità di Hackett di armonizzare con il suo stile inconfondibile i vari momenti musicali proposti. In definitiva At the edge of light è l’uscita prog. ideale per iniziare il nuovo anno, aspettando quelle di artisti più blasonati del roaster InsideOut.
Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)