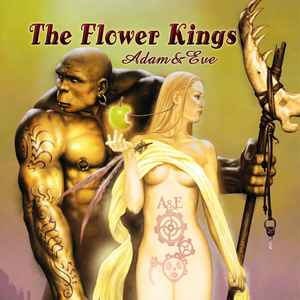Recensione: By Royal Decree

We can make it work together – The power of two
working out is twice as clever
We can make the world go round and around
The me’s and the you’s – all set for any weather
(da “We Can Make It Work”)
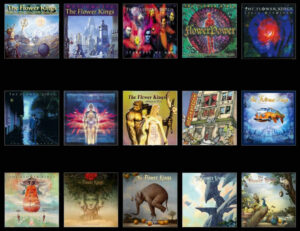
Dare uno sguardo all’immensa discografia dei The Flower Kings, che ora arriva al quindicesimo studio album, è qualcosa di proustiano. Scorrendo le colorate copertine dei loro dischi si ritorna giovani, ai mitici anni Novanta (periodo del debutto Back in the world of adventures e del magnum opus Flower Power); poi c’è l’infilata di capolavori che va da The Rainmaker a Paradox Hotel. La band di Roine Stolt è sopravvissuta inoltre allo iato tra 2007 e 2012, reinventandosi gradualmente. Dopo un ritorno sulle scene con qualche chiaroscuro (Banks of Eden e Desolation Rose) il gruppo scandinavo ha saputo riconfermare la propria classe con i recenti Waiting for miracles e Islands. Con By Royal Decree i nostri attingono, udite udite, perfino a materiale inedito che risale ai tempi delle origini dei Re del fiore. Afflato retrò, dunque, e autocitazionista, con la solita ricerca melodica, una vena beatlesiana e il ritorno in line-up di Michael Stolt (a fianco di Jonas Reingold al basso) e il percussionista di culto Hasse Bruniusson.
Dobbiamo aspettarci dunque un doppio album senza pretese di stupire, semmai composto da canzoni organiche che vogliono restituire l’immagine di una band intenta semplicemente a portar avanti la sua poetica musicale. Sono assenti, infatti, suite chilometriche e nessun brano spicca particolarmente, i novanta minuti composti da Stolt & Co. vanno assaporati nel loro complesso unitario, concedendosi il giusto tempo. L’artwork, come se non bastasse, è un bel biglietto da visita, il quadro di Kevin Sloan che raffigura pavoni sgargianti e volatili vari rappresenta al meglio il sound colorato e variegato dei TFK.
Il sipario si apre con “The Great Pretender“, sette minuti di rock scanzonato e suonato divinamente. La produzione è come sempre pulita, l’intesa Stolt–Fröberg alle voci si conferma al top, la parte ritmica non sbaglia un colpo (Mirkko DeMaio, erede di Jaime Salazar e Zoltan Csörsz, merita ancora tutti i nostri complimenti) e anche Zach Kamins inizia a divertirsi nelle vesti di nuovo key-wizard in pianta stabile. Un ottimo avvio, con buona ispirazione ed energia, vediamo come prosegue l’album. Ad attenderci è “World Gone Crazy”, un brano che cambia decisamente rotta e ci porta su lidi più dissonanti e sornioni. La seconda parte del pezzo richiama da vicino i TFK anni Novanta (specie nelle linee di basso) e molti fan ne saranno piacevolmente colpiti.
Ma è subito la volta di una coppia di brani che insieme arrivano al quarto d’ora abbondante. “Blinded” è un’avventura sonora che regala diverse soddisfazioni. Si va da alcuni buoni unisoni, agli inserti di sassofono (che non sono nuovi nel sound degli scandinavi), senza dimenticare l’immancabile vena pomposa e magniloquente che rende i nostri per certi versi gli eredi più convincenti degli Yes. In “A Million Stars” emerge tutto il talento del combo svedese, quello che ha permesso loro di ritagliarsi uno spazio nella scena prog. che conta. Senza forzature il brano si dipana su di un ritmo compassato che è il palcoscenico ideale per le trovate chitarristiche di Stolt, fino al lento finale, che in 180 secondi intesse un crescendo dalle dinamiche esilissime e magnetiche. “The Soldier” ha un buon tiro, è il pezzo giusto al momento giusto, potrebbe regalare emozioni in sede live. Se stessimo parlando di un disco dei Transatlantic probabilmente Mike Portnoy avrebbe infilato una dozzina di fill assurdi nelle parti di batteria, Mirkko DeMaio invece dosa sapientemente la propria tecnica e pur non tralasciando alcune finezze permette al brano di avere una sua coesione ben bilanciata.
L’accoppiata che segue è l’ennesimo esempio di eclettismo. “The Darkness in You”, infatti, è una ballad mesta e struggente (viene in mente “Mommy Leave the Light On”) con inserti jazz e la chitarra semiacustica di Stolt a versare lacrime d’argento; “We Can Make It Work”, all’opposto, è un divertissement cadenzato e circense che strappa più di un sorriso, complice un arrangiamento tutto da godersi. Mai come in questo caso Stolt riscopre il dettato dei Beatles, la cosiddetta mentalità anything goes, quando l’arte non è cerebralismo ma spontaneità…
Il primo disco di chiude con “Peacock on Parade” e “Revolution”. Prendiamo di nuovo la macchina del tempo e torniamo agli anni Novanta nel pezzo strumentale che si ricollega al pavone in copertina, del resto tutte le strumentali dei TFK hanno un quid di geniale. L’ultima traccia inizia con parti di rullante frizzanti salvo poi mutare pelle e rivelarsi il tipico brano di chiusura, con una sezione conclusiva dilatata. Da segnalare le seconde voci di Michael Stolt, molto coinvolto nell’interpetazione. Le liriche presentano testi a tratti visionari: «Found the greatest love in the microscopic pictures / the addictions – resurrections – from the wreckage / The complexity is endless / And as we monitor the million years of evolution / The Revolutions – A world once frozen – A world once frozen – Blossom fusion».
I primi 40 minuti di musica sono trascorsi senza picchi particolari, mantenendo un sound accogliente e spensierato. Ascoltare il secondo CD è doveroso, lo facciamo con sincera curiosità. “Time the Great Healer” è puro refrigerio: la prima parte è più cullante, la seconda ha una presenza più incisiva di chitarra elettrica. Le voci di Jannica Lund sono una trovata convincente, così come gl’inserti di fisarmonica nella breve e sbarazzina “Letter” (forse uno dei brani che resteranno più impressi nella memoria, come fu per “Tangerine” in Islands). Troviamo evidenti rimandi agli Yes nella successiva strumentale “Evolution”: i TFK riescono a rendere i tempi dispari una passeggiata e l’hammond una presenza metafisica. La capacità pittorica dei nostri ricompare nelle prime strofe di “Silent Ways”. I testi descrivono un sentimento oceanico dell’essere – «On a clear blue wave / on a distant ocean / In a state of grace / wide and deep emotions» – e non manca nemmeno una linea di basso fretless nell’ultima parte del brano. Si vira verso la mestizia più elegante con “Moth”, brano autunnale con testi elegiaci: “So fall fall the silver bridge / Sinking slowly”. Uno dei pezzi più intensi e curiosi (dal punto di vista dell’arrangiamento) degli ultimi TFK. Le ultime 4 composizioni scorrono come il resto della tracklist. Da segnalare l’assolo di Stolt con tremolo sul finale di “Open Your Heart”, il breve interludio pianistico “Shrine” e la conclusiva “Funeral Pyres”, con una coda innica che ha punti di contatto con certo dettato di casa Kaipa.
By Royal Decree regala un’ora e mezza di musica raffinata e cangiante, consigliata a tutti i fan dei TFK, che potranno apprezzare la nuova line-up bilanciata equamente tra passato e presente (gl’inserti di voce femminile sono una novità più che positiva). Siamo su livelli come sempre più che discreti, appena al di sotto di quanto proposto in Islands, album a tratti con maggiore mordente e inventiva. Questa volta Stolt ha voluto puntare su un flavour vintage, confezionando un’uscita da non perdere insieme a quella dei cugini Marillion.