Recensione: Celestial Extinction
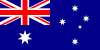

Se in ambito black metal le one-man band sono all’ordine del giorno, entrando nel reame del death il numero decresce esponenzialmente. Senza entrare nel merito del perché e percome questo accada, tale considerazione rende onore e merito all’australiano Chris Anning che, in solitudine, sotto il moniker Cryptivore, dà alle stampe il suo debut-album, “Celestial Extinction”.
Cryptivore che fondono l’old school death metal al grindcore ma soprattutto al death classico. Per un risultato certamente non originalissimo ma che si concretizza in uno stile ben disegnato, adulto, che non muta nel corso del tempo che intercorre da ‘Cocoon Hetacomb’ a ‘Celestial Extinction’. Il che rappresenta, di per sé, il primo obiettivo che ciascun musicista deve centrare.
Lo dimostra l’opener-track, la quale dopo un intro strumentale, dipana negli inferi il suo incendiario riff portante, per un’aggressione sonora assolutamente devastante. Anche qui, come da ortodossia, il focus si concentra sul lavoro della chitarra, terribilmente efficace in fase ritmica ma anche interessante quando sciorina con naturalezza la parte più propriamente solista. Poco da dire sul basso, mentre invece la batteria fa bella mostra di sé con un drumming estremamente vario, che abbraccia l’intervallo intercorrente fra gli slow tempo e i terribili blast-beats che innalzano all’inverosimile la potenza del suono.
Ed è proprio nelle sezioni spinte dai mid-tempo che si ritrova il flavour di certo grindcore della fine degli anni ottanta; flavour che odora un po’ dei leggendari e mai superati Stormtrooper Of Death (S.O.D.). Ovviamente non si tratta di una mera scopiazzatura bensì del riproponimento di tratteggi che meritano di vedere la luce del terzo millennio. Un’occhiata al passato, insomma, per rammentare come sia nato il death, partendo – in primis – dall’estremizzazione del thrash, e cioè dal ridetto grindcore.
Anning, oltreché abile con tutta la strumentazione, si rivela anche un buon interprete del growling. Anche questo adagiato su dettami ben noti agli appassionati. Mantenendo, cioè, un approccio equilibrato e in linea con l’andamento musicale, ottenuto premendo, senza esagerare, il diaframma e indurendo i muscoli della gola. Growling, quindi, da prendere come esempio nel caso si volesse sottolineare com’è che esso dovrebbe essere nel campo in ispecie. Specificamente quando si deve creare il mood del disco, fattore importante pure questo per dare vita a qualcosa di emotivamente profondo.
In ciò “Celestial Extinction” si mostra adeguato per esternare un umore mortifero, da cripta, che odora di decomposizione, come lascia intravedere la title-track; buio e tetro quale antitesi alle ridenti e assolate coste del continente australe.
Le canzoni sfruttano tutto quanto sopra esposto susseguendosi con scioltezza e naturalezza. Frutto, in sostanza, di un songwriting sufficiente a differenziale le une dalle altre. Niente di miracoloso, è bene rimarcarlo, giacché l’LP rimane in testa più per la sua globalità che per i singoli episodi, anche se brani come ‘Clandestine Ruination’ sono indicativi di una gustosa brutalità a tutto tondo.
Sintetizzando, non si può che apprezzare lo sforzo compiuto da Anning, autore coraggioso e indomito che non si cura di niente e di nessuno se non di se stesso. Approccio encomiabile poiché esente da mode e contaminazioni. “Celestial Extinction”, tuttavia, non può che essere un prodotto destinato al più tenebroso underground, cui si nasconde una ridda di famelici fan.
Per tutto questo, la sufficienza è garantita.
Daniele “dani66” D’Adamo

