Recensione: Citadel
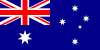
Se mi venisse chiesto qual è il miglior disco metal pubblicato dopo il 2010 non avrei esitazioni nel rispondere: “Portal of I dei Ne Obliviscaris”. Potrebbe forse giocarsela solamente con Parallax pt. II dei Between the Buried and Me. Ma Portal of I vince per una serie di elementi. Anzitutto il fatto che si tratta di un’opera prima. Questi australiani che dominano l’universo (cit.) due anni orsono hanno messo in piedi quello che si dice il debut perfetto, un album in grado di proiettarli in pochi mesi ai vertici del metal estremo, conquistando moltissimi fan in giro per il mondo. Ne è prova la loro campagna volta a raccogliere fondi per un tour attorno all’orbe. L’obbiettivo era di circa 25.000 Euro. È stato raggiunto in un solo giorno e doppiato prima della fine della campagna. Già questo fa capire di trovarsi innanzi ad una band fuori dal comune.
Ma la vera discriminante sta nel fatto che Portal of I ha rappresentato una piccola svolta nel modo di intendere la musica estrema combinata al progressive rock (almeno per me). Gruppi come gli Opeth e i già citati BTBAM hanno basato la loro proposta sul contrasto tra momenti di furor bianco e momenti di calma serena. I NeO invece hanno basato il loro stile sul divenire, la fluidità, il passaggio costante e graduale. Ma soprattutto sulla mescolanza di questi due elementi. Ciò è stato possibile anzitutto grazie all’incontro tra due artisti opposti tra loro. Senza voler sminuire gli altri componenti del sestetto, è fuori discussione che la differenza in questo gruppo viene fatta da Tim Charles, anima buona del gruppo, e Marc “Xenoyr” Cambell. Il primo in grado di donare armonia anche alle sezioni di blast beat più truculento grazie alla sua voce pulita ed al suo violino. Dall’altro lato Xen è l’anima poetica della band, pur essendo il growler. Suoi sono i testi, sue le cover, sua la poetica del gruppo. A questo si aggiunga la chitarra di Brendan Brown, capace di passare dal flamenco al djent con estrema naturalezza, ed il basso marcatamente prog di Daniel Presland. Chiude la formazione la sezione “ritmica,” vale a dire la chitarra di Matt Klavins e la batteria di Benjamin Baret.
Tornando a Xenoyr, si è detto che sue sono le cover e le lyriche, e questo elemento induce a supporre una stretta relazione tra musica e immagine. Ed effettivamente è così. La copertina di Portal of I era una colomba travestita da teschio, incorniciata da una miriade di colori. E così era anche l’album, vale a dire un miscuglio inestricabile di emozioni contrastanti, sorretto da un caleidoscopio di sfumature sonore. La cover di Citadel (che sia una citazione a Saint-Exupéry?) è simile, ma molto più cupa. Domina il blu profondo. Ripercussioni nella musica? Naturalmente sì. Evoluzione sonora? Certo, sebbene le caratteristiche guida risultino pressoché invariate. Da notare il fatto che Citadel sia un album dal minutaggio ridotto (48 minuti) a fronte di una scaletta composta da 3 supersuite (avente presente Close to the Edge per dirne uno? ) e tre brani molto più corti che sono a ben guardare prologo, epilogo ed interludio del disco. I nostri le fanno rientrare all’interno delle due composizioni più estenuanti, sicché alla fine l’opener Painters of the Storm viene a durare 22 minuti e la conclusiva Devour me, Colossus 15.
Malgrado queste premesse lascino desumere un appesantimento ed arricchimento del suono, tali supposizioni alla fine risulteranno confermate e ad un tempo contraddette. Il crepuscolare intro di piano a Whyrmholes conduce ad un ambiente umido e cavernoso, dal quale si dipana Triptych lux, vale a dire la suite vera e propria. E si nota fin da subito che la proposta dei NeO, pur restando fedele a se stessa, si è vestita di un’oscurità nuova. Il sound si è fatto molto più elettrico, e lo si intuisce dal primo riff spaccaossa. Impressioni confermate anche nei frangenti più quieti. E ce ne sono di fenomenali. Pur tuttavia sono spariti gli elementi più folkloristici, in favore di arpeggi decadenti che hanno fatto la fortuna – ancora – di BTBAM oppure dei nostri Novembre. Si nota poi come qui siano molto più frequenti i cambi di ritmo marcati ed improvvisi. Ne viene fuori un lavoro estenuante, eppure decisamente compatto ed unitario, con una grandissima coda, ancora dominata dal violino, accompagnato infine dalla chitarra acustica per formare Reveries from the stained Glass Whomb. Questa è stata Painters of the Storm, suite prog di rara tecnica e rara emotività. Uno di quei lavori di cui vorresti scrivere mentre ascolti perché hai bisogno di una guida a districarti in cotal cittadella sonora. Poi schiacci play e ti ritrovi a sentirla in loop, “perdendo” due ore della tua vita come fossero dieci minuti, ma soprattutto, restando inebetito ed incapace di scriver alcunché. Una canzone che ascolteremo a lungo, senza ironie al minutaggio.
Segue Phyrric, vale a dire la composizione “normale”. L’avevamo già sentita come pezzo di presentazione al disco. Otto minuti spaccati a metà. I primi cinque sono black nudo e puro, pressoché incorrotto se non dal ritornello pulito di Charles. Segue invece un’ascesa a spazi cosmici e siderali guidata, ancora, da violino e chitarre elettriche malinconiche, quasi ci si trovasse in Écailles de Lune degli Alcest, prima che Xen e batteria a mitraglia prendano di nuovo il controllo, a guidare l’ascoltatore ancora verso l’alto, fuor della tempesta.
Chiude Blakcholes, prima parte di Devour Me, Colossus. Si tratta del brano più fluido, dominato da quelle atmosfere in divenire di cui sopra. Una splendida sintesi tra prog, death e black, con alcuni estasianti duetti tra le due voci. Un pezzo che non raggiunge le vette epiche dell’altra supersuite, ma si segnala fuor di dubbio come il pezzo ostruito meglio. Sicché probabilmente, nell’affannosa ricerca d’emozioni forti, l’ascoltatore lascerà da parte questo brano in un primo momento, per poi tornarvi dopo un po’, rendendosi conto che forse è proprio qui la vera perla del disco.
Un disco che sacrifica un po’ delle soluzioni sonore e della fantasia compositiva del passato per ottenere un sound più compatto e forse anche un po’ più maturo. Teniamo però presente che Citadel non può contare sull’effetto sorpresa come il suo predecessore. Teniamo pure presente che al contrario questo disco veniva aspettato al varco da molti. Con l’ovvia speranza che quello squarcio nelle tenebre che era stato il debut non finisse per essere un episodio isolato. Altresì la speranza era che i Ne Obliviscaris non tentassero l’impervia carta del disco in fotocopia. Impervia perché quel debut risulta irreplicabile. E poi, in verità, in verità vi dico, non domini l’universo facendo dischi fotocopia.
Attesa, pressione, stress.
Gli australiani l’hanno sfangata egregiamente. Poche storie dunque. Citadel conferma l’immenso talento di questa band, mettendone in mostra la versatilità e le capacità di vestire un sound estremamente complesso con sfumature assai diverse. Ci troviamo davanti ad un gruppo che, a meno di terremoti e cataclismi, è agli inizi di una carriera lastricata di gloria.
Tiziano “Vlkodlak” Marasco
Sito del NeO




