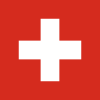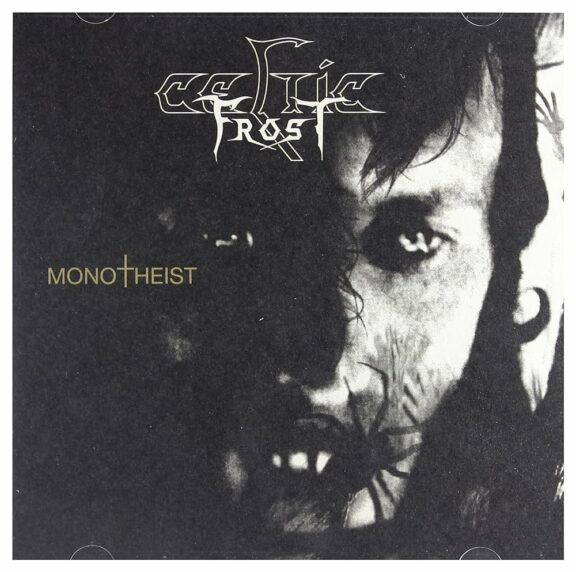Recensione: Cold Lake
The thing that should not be, avrebbe detto Lovecraft e altrettanto hanno sentenziato fiumi e fiumi di fan della band, di critici musicali e di ascoltatori di musica metal in generale. Tradimento, onta, disonore, raccapriccio, uno di quegli album totalmente “sbagliati” di cui la band dovrebbe persino vergognarsi, al pari ad esempio di “Risk” dei Megadeth, “Blackacidevil” dei Danzig, “Chameleon” degli Helloween, “Shadowlife” dei Dokken, “Illud Divinum Insanus” dei Morbid Angel, “Load“, “ReLoad“, St. Anger” dei Metallica (beh con loro l’elenco è lungo…), lavori nei quali le rispettive band derogano vistosamente da un sound riconosciuto e consolidato, magari pure con l’aggravante – è il caso dei Celtic Frost – di un cambio di look vistosissimo. E per vergognarsene Tom Warrior se ne è vergognato, a tal punto da non far ristampare l’album e rinnegarlo pubblicamente ogni qual volta un incauto intervistatore ha avuto l’ardire di rievocarlo. E’ opinione largamente maggioritaria che “Cold Lake” sia un disco orrendo e distruttivo per i Celtic Frost, qualcosa che ha minato l’integrità della band, autrice di perle nere come “Morbid Tales“, “Emperor’s Return” e “To Mega Therion“.
La cosa buffa è che io ho sempre visto i Frost in tutt’altro modo, sotto una lente diversa. Facendo un parallelo col mondo cinematografico, la band elvetica mi è sempre sembrata un po’ il corrispettivo di quei registi alla Stanley Kubrick (o, per rimanere in casa nostra, Fernando Di Leo o Sergio Martino), ovvero autori di grandissimo estro e talento, in grado di svariare liberamente tra generi diversi reinterpretandoli e reinventandoli a proprio modo. Kubrick ha diretto polizieschi, film in costume, di guerra, fantascienza, film drammatici con risvolti ora erotici ora orrorifici; allo stesso modo i Frost sono quella band che, partita da un proto black metal (“black” da intendersi alla maniera degli anni ’80) nel quale confluivano elementi metal, punk e thrash generosamente impregnati di rimandi letterari e atmosfere occulte, sepolcrali, nichiliste ed heroic fantasy, e financo preconizzazioni del death (gli Obituary forse oggi neppure esisterebbero senza i riff dei C.F.) e dell’odierno black appunto, si è poi trasfigurata in un album di avanguardia come “Into The Pandemonium“, totalmente inaspettato come successore di “To Mega Therion“. Progressioni musicali, ricerca, sperimentazione, languori goticheggianti, un cantato completamente ribaltato di 180 gradi, un autentico pugno in faccia alla propria fan-base, una sfida ad essere seguiti su territori completamente diversi ed avventurosi. L’indole della band rimane la stessa anche quando arriva “Cold Lake“. Se ci pensate bene è l’ennesima sfida, nuovamente vengono sparigliate le carte e stavolta la band si orienta verso ambiti sleaze/glam/hard rock, cimentandosi con sonorità assai distanti da quelle di origine (…anche se “I Won’t Dance” una minima avvisaglia l’aveva data).
Nel metal vige una terribile regola non scritta secondo la quale se indurisci il sound sei un figo pazzesco ma se invece lo alleggerisci sei un “venduto”, lo fai per la grana o comunque, nella migliore delle ipotesi, ti sei rammollito. A questo severissimo dogma non sfuggono nemmeno i Celtic Frost, immediatamente battezzati come traditori. Non aiuta la foto sul retrocopertina, di una bruttezza estetica senza rivali. Cotonati, truccati, col petto di fuori, le bretelle e i pantaloni sbottonati, la posa dei Frost pare quella di una variopinta ciurma qualsiasi del Sunset Boulevard. Magari si poteva anche prendere la cosa con un filo di ironia, ma il metallaro è bestia strana e si stizzisce pesantemente del cambio di look. Qualcuno ha direttamente chiuso lì il suo rapporto col disco, senza neppure ascoltarlo e bollandolo tout court come spazzatura. Scorrendo i titoli in scaletta si ha proprio l’impressione di avere per le mani un album glam (“Seduce Me Tonight“, “Cherry Orchards“, “Dance Sleazy“, etc.), il cromatismo violaceo evocato dalla copertina marmorea e dal continuo riferimento a velluti e preziosità amene convince sempre di più del fatto che punte chiodate ed aggressione belluina siano state ipocritamente edulcorate ed addomesticate (chissà…qualcuno avrà magari anche pensato che i Frost avessero in testa di insidiare Wham e Duran Duran in classifica).
Tutte considerazioni comprensibili, legittime e apparecchiate sulla tavola, dodpodiché (finalmente) viene la musica e si comincia a capire di che pasta sono fatti “Cold Lake” e i Celtic Frost del 1988. Scrostate le fette di prosciutto da occhi e orecchi, e predisposti – quanto più possibile liberamente – all’ascolto dell’album, si fa davvero fatica a comprendere come si possa giudicare “Cold Lake” un lavoro mediocre. I gusti sono gusti e quindi metto tranquillamente in conto che possa non piacere, esattamente come ad altri magari possano non piacere gli esordi più grezzi della band, il funky metal, gli Overkill calmierati di “I Hear Black“, i Saxon americanizzati di “Destiny” (o, di contro, quelli “tedeschi” a cavallo tra anni ’90 e 2000), oppure ancora gli Iron Maiden mattonati dei dischi post reunion con Dickinson. Quello che francamente disturba è l’accanimento pregiudiziale su di una band che, per aver pubblicato in carriera album come “Empreror’s Return” e “To Mega Therion“, o che prim’ancora rispondeva al monicker di Hellhammer (sotto il quale aveva seminato blasfemie e virulenza sanguinaria), non poteva permettersi in alcun modo di andare a parare su lidi così “scioccanti”… assai più dello pseudo satanismo giovanile, verrebbe da dire. All’epoca, quando Warrior non si vergonava ma difendeva a spada tratta l’album, i Frost ripetevano incessantemente che “Cold Lake” non intendeva essere un album glam o hard rock, bensì la personale rilettura dei Frost di quel genere, che evidentemente non era quello di appartenenza. Ovvero un’esplorazione di territori stranieri che, in qualche misura, stimolavano la curiosità artistica di Warrior e compagni. E dato che la band non difettava di creatività ed inventiva, anche quell’ennesimo azzardo poteva rivelarsi un’incursione assai sorprendente (cosa che per me infatti è stata). “Seduce Me Tonight“, “Petty Obsession” “(Once) They Were Eagles“, “Cherry Orchards“, “Juices Like Wine“, “Downtown Hanoi” sono canzoni assolutamente notevoli, valide, più heavy che hard, ammiccanti ma mai zuccherose, talvolta anzi fin troppo squadrate e spigolose per essere gradite Oltreoceano (con quel cantato poi….). Il punto è che “Cold Lake” è il disco giusto pubblicato nel momento sbagliato dalla band sbagliata.
Gli svizzeri ci metteranno due anni per correre ai ripari, pubblicando sempre sotto Noise il solidissimo e più sobrio “Vanity/Nemesis“, parziale ravvedimento che comunque non soddisferà i fan integralisti della prima ora, ma che perlomeno cancellerà l’insopportabile spettacolo visivo di una band conciata come una parata di travestiti su sfondo rosa. La botta comunque non verrà mai completamente riassorbita, portando i Frost dritti dritti verso la chiusura del primo tempo della loro carriera, tra malumori, pentimenti e amarezze. A distanza di anni, “Cold Lake” rimane un disco unicamente reperibile (usato) su vinile o come prima stampa in compact disc (o bootlegato), un titolo sempre grandemente controverso, perlopiù denigrato ed usato come pietra di paragone per il tipico “passo falso” che una band non dovrebbe mai fare. Warrior ne parla come del figlio scemo che si cerca sempre di tenere chiuso in camera quando i genitori invitano persone a cena; cantilena che ha ripreso corpo quando, alla vigilia dell’uscita di “Monotheist“, i Frost dovettero rifarsi una verginità immolando “Cold Lake” sull’altare sacrificale. Io sono stato e rimango un fan oltranzista dei Celtic Frost e credo che tanto “Into The Pandemonium” (che fa figo), quanto “Cold Lake” e “Vanity/Nemesis” (che non fanno figo), siano stati passi del tutto fisiologici in una storia artistica fatta di costante evoluzione ed avanscoperta. Una linea retta che paradossalmente si è interrotta proprio con l’acclamatissimo comeback album “Monotheist“, boccata d’ossigeno per tutti quei fan che erano rimasti al 1985, nonché lavoro senz’altro notevole, ma che tuttavia ho letto come un ripiegamento pavido e un po’ strategico su sonorità “sicure” (ancorché debitamente riviste ed aggiornate alla contemporaneità). Con “Monotheist” i Celtic Frost hanno dato al proprio pubblico esattamente l’album che quel pubblico voleva sentire ed esigeva; nessun rischio, ed una espunzione (piuttosto sgradevole) di mezza discografia dal proprio curriculum, come se i Celtic Frost non fossero stati – anche – quelli di “Cold Lake” o “Vanity/Nemesis“, album “diversi” ma non per questo inadeguati.
Marco Tripodi