Recensione: Covered in Colours
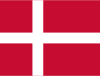
Nel 1993 usciva uno degli album che ancora oggi custodisco più gelosamente: al secolo Cerebral Implosion degli italiani Alligator. Un ottimo lavoro che nei suoi meandri, incidentalmente, conteneva anche una cover: niente meno che “Help” dei Beatles. Animato da amichevoli propositi di inclusione (sebbene accecato dall’ingenuità degli anni verdi di ragazzo) la proposi con entusiasmo a un amico, fan di lungo corso dei Fab Four. Il responso non lasciò alcun dubbio: «È sicuramente la peggior cosa che io abbia mai sentito!» (ho volutamente usato il termine “cosa” al posto di quello originale, ben più colorito).
Benvenuti, dunque, nel vasto e colorito mondo delle cover!
Le cover rappresentano un terreno familiare a tutti. Da quelli che: «Senti “Nothing Else Matters” fatta da Marco Masini!» a tutti coloro che tra di noi, almeno una volta nella vita, hanno deciso di imbracciare una chitarra o brandire un paio di bacchette, con la velleità di sentirsi come rockstar e, solo un passo più in là, diventare la next-big-thing che il mondo ancora ignorava… In realtà, man mano che si sale di livello e di piano, il terreno diviene molto più accidentato, se non addirittura ostile: sono davvero pochi gli esempi di artisti in grado di donare nuova linfa a pezzi più o meno conosciuti o di convincere con una chiave di lettura intrigante, senza cadere nel grottesco.
Diversamente da quanto si potrebbe pensare, i problemi maggiori non derivano dalla padronanza tecnico-esecutiva o dalla validità intrinseca dei musicisti; per ottenere un risultato credibile è soprattutto necessario aver presente lo spirito del tempo, il contesto, il significato del pezzo e il mood dell’artista creatore de pezzo.
E non basta riproporlo fedelmente, occorre anche regalare qualcosa di nuovo, aggiungere un tocco personale che, a livello di carisma, solo alcuni (e peraltro in un momento di grazia) sono in grado di conferire. Il rischio dell’inutile, infine, è dietro l’angolo.
D’altra parte va riconosciuto che un gruppo che decida di mettersi in gioco, spendendo credibilità nel cimentarsi in un’attività infida e dai risultati incerti, se non addirittura controproducenti, svolge l’importante funzione di diffusione di cultura musicale tra le generazioni più giovani, che per motivi vari, possono aver mancato appuntamenti fondamentali.
L’ultimo lavoro dei prog-metaller danesi Anubis Gates va probabilmente interpretato in questo senso: un collage di esperienze di vita musicale importanti per la band, che i membri hanno voluto condividere con l’ascoltatore. Il disco, composto da ben 14 cover, arriva esattamente tre anni dopo Covered in Black; se lì era il nero a trionfare, qui la copertina raffigura un coloratissimo mandala che preannuncia la volontà di “rivestire” le canzoni che hanno ispirato il gruppo nel proprio periodo formativo.
L’opera rispecchia un percorso personale già nell’ordine dei brani, strutturato secondo precise cadenze in quattro sezioni: Starters, The Beautiful Ones, The Eighties Corner, No They Didn’t. Vediamole nello specifico.
“Still Life in Mobile Homes” è tratto da Tin Drum del 1981, quinto e ultimo album in studio del gruppo musicale britannico Japan. Il sapore new-romantic della versione originale sfuma a favore di un approccio inequivocabilmente prog. metal. La trasposizione è briosa e solida; ciò che si differenzia maggiormente è il timbro della voce che, di tanto in tanto, rimanda ad atmosfere lacustri di reminiscenza Yes. Affiora subito lo scoglio principale della produzione di cover di brani di anni ‘80, con l’inevitabile scostamento vocale tra passato e presente. Direttamente dall’omonimo album in studio del 1974 dei King Crimson, il secondo pezzo proposto è “Red”. Al cospetto dei mostri sacri, il combo danese tiene bene botta, proponendo una versione attuale, ma decisamente aderente all’originale. Il riff portante è inspessito da una sonorità greve e più scura, stemperato dagli interventi del sintetizzatore, mentre la sezione ritmica vira su toni decisamente metal.
Si passa a “Plantage”, un brano del 2002 del gruppo danese sperimentale Under Byen: i movimenti di stampo onirico vengono mantenuti, ma le sonorità sono più pesanti. Non mancano all’appello anche i visionari Voivod, omaggiati con “Experiment”, song tratta dal fortunato Dimension Hatröss (1988). Addolcita inizialmente dalla scelta di non ricorrere alla distorsione di chitarra a beneficio del clean e riducendo i bpm ritmici, annovera anche un intervento del piano ad arricchire l’arrangiamento. La chiosa è energetica e riporta allo stile più convulso del gruppo. In quinta posizione troviamo la famosa “Chromazone”, che chiude l’album Time in Place (1988) del virtuoso della chitarra jazz–fusion Mike Stern. Nella versione originale, sulla complessa architettura ritmica svetta un Michael Brecker in stato di grazia. La cover è piacevole e, nonostante una chord progression in versione metal, il feeling da improvvisazione jazz è ben delineato. Uno dei momenti migliori dell’intero disco.
Una complessa progressione di accordi caratterizza anche “Glamour Profession” (Gaucho 1980 – Steely Dan): in questo frangente una voce femminile completa in chorus. Lo sforzo per ricreare il tessuto armonico è notevole, ma il risultato non è immediato, pur essendo presenti spunti molto interessanti. Esperimento questa volta poco riuscito. È la volta, dunque, di “Entangled”, tratta dal celeberrimo A Trick of the Tail dei Genesis (1977). Non si incontrano sobbalzi nello sviluppo del pezzo: la versione è ben eseguita, ma a lungo andare l’impressione è quella di stanchezza.
“Atlas” è un pezzo dei Coldplay, assurto agli onori delle cronache più che altro in quanto facente parte della colonna sonora del film “Hunger Games: La ragazza di fuoco” del 2013. Apprezzabili le ritmiche sincopate, che tentano di arricchire un pezzo che di per sé non passerà agli annali della musica. Francamente evitabile. Di altra caratura “To France”, canzone del 1984 di Mike Oldfield, uno dei pezzi più coverizzati in passato (ad esempio dai Blind Guardian, per restare in ambito metal). Ben si adatta ad essere trasposta in un contesto power/prog. Inevitabilmente più pesante dell’originale, funziona. L’iconica “Fade to Grey” dei Visage è caratterizzata invece da un’atmosfera claustrofobica, oppressiva. Realizzare una cover di un pezzo simile, a distanza di quarant’anni suonati (anche per noi), per di più trasponendola in un genere “alieno”, sarebbe stato proibitivo per chiunque. Il pezzo non è nemmeno malaccio, però si avverte la mancanza dello zeitgeist che ha sancito l’imprimatur primigenio della traccia.
Siamo arrivati agli ultimi 4 brani in tracklist. S’inizia niente meno che con “S.A.T.O.”: i nostri vanno a “scomodare” un’altra coppia di mostri sacri, quali Ozzy Osbourne e il leggendario Randy Rhoads che, in questo pezzo, ci delizia con uno dei suoi assoli più rappresentativi. Il rifacimento non si discosta sostanzialmente dall’originale e tempi e struttura del brano sono riproposti abbastanza fedelmente. La voce di Ozzy – nel bene e nel male – è di per sé fortemente caratterizzante: qualsiasi cantante che vi si accosti, seppur dotato dal punto di vista tecnico, dovrà pagare il fio di un lavoro improbo per reggere il paragone con la Storia.
Direttamente dal primo EP Haunting the Chapel del 1984 degli Slayer arriva “Aggressive Perfector”. Le dinamiche frenetiche del thrash primordiale cedono il passo ad un’atmosfera rarefatta nello stile delle ballad più classiche. Proprio così, avete capito bene! Curiosamente l’inizio è tratto da South of Heaven, altro cavallo di battaglia della band di Lombardo e Araya. La cover/mash-up si discosta in modo drammatico dalla versione originale, con tanto di cori monastici in stile medievale. Le chitarre distorte e la batteria arrivano sul finire del pezzo, che volge al termine con una lunga cavalcata che strizza l’occhio al maestro Morricone. Il pezzo è convincente, ma sconsiglio calorosamente qualsiasi tentativo di somministrazione ai puristi degli Slayer o del thrash old school in genere!
È il turno, infine, dell’inno con cui tutti noi strimpellatori prima o poi abbiamo riempito cantine e fatto disperare i vicini di casa: “Back in Black” degli AC/DC. Garantisco che non l’avete mai suonata in questo modo! È uno dei momenti più riusciti dell’album. Non ha nulla a che fare con la versione originale e quando dico nulla significa davvero nulla. Anzi. Non fosse stato per il testo sarebbe difficile riconoscerla. L’atmosfera è futuristica/pink floydiana e introduce una ritmica cadenzata che rimanda a “One of These Days”. Il basso mugghia incessante il suo bordone, la voce convince e anche un synth/moog fa capolino per aggiungere echi della PFM di “È festa”. Dialoghi sparsi completano la narrazione. Un’insolita satura lanx che personalmente mi ha deliziato ma, di sicuro, non è per tutti i palati.
E si chiude con “Strawberry Fields Forever” dei già citati Beatles. L’inizio si dipana in modo classico, fino ad evolversi in arrangiamenti in stile Depeche Mode; entra poi l’apparato progressivo d’ordinanza a conferire oscurità e cadenza al tutto. Sebbene il risultato sia tutto sommato piacevole, forse non sarebbe stato fuori luogo qualche coraggioso atto dimostrativo. Resta il fatto che sette minuti e mezzo sono davvero tanti; si interrompono improvvisamente, ricordando l’arroganza e la supremazia dei primi Dream Theater.
In conclusione, per un ascoltatore onnivoro sicuramente vale la pena concedere un ascolto a Covered in Colours: i pezzi sono mediamente buoni e non mancano spunti interessanti. Il tributo che la band danese riserva alle proprie fonti di ispirazione è sincero e svolto in modo professionale. Certamente non siamo al cospetto di un’opera destinata a sconvolgere le coscienze progressive, ma il valore dei musicisti c’è e si scorge in modo nitido. In alcuni casi la scelta è stata quella di optare per un approccio tradizionale, mentre in altri l’evoluzione è irriconoscibile: una scelta coraggiosa che non mancherà di suscitare sdegno nei puristi della prima ora. In ogni caso il marchio di fabbrica è coerente e l’idea di divertimento si ripropone in tutti i capitoli. Un punto di forza risiede nelle piacevoli citazioni di King Crimson, Genesis e Mike Stern. È sempre molto difficile coniugare fedeltà e innovazione ma gli Anubis Gate ci sono riusciti e senza scadere nel grottesco più becero.


