Recensione: Distant is the Sun
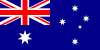
Quinto album in studio, dopo ben sette anni di attesa, per i Vanishing Point, gruppo del Nuovissimo Continente, connazionali di Eyefear, Ne Obliviscaris e Voyager. La band, originaria di Melbourne per la precisione, è attiva dal 1995 e vanta membri d’origine italiana (basti ricordare l’intro di “Hope among the heartless”, brano del precedente “The Fourth Season”). Il combo australiano ha raggiunto il proprio apice all’inizio del nuovo millennio con l’album “Tangled in Dream”, che gli valse la partecipazione al Wacken del 2000, e l’affiancamento, come gruppo spalla, a mostri sacri come Helloween e Gamma Ray. Successivamente hanno aperto concerti anche per Nightwish e Sonata Arctica. Nel 2010 il co-fondatore e chitarrista Tommy Vucur lascia la band, così il bassista Adrian Alimic. Porcianko e Massaro restano, dunque, la colonna portante della band, affiancati da Christina Nativo, batterista subentrato nel 2007.
Il sound degli australiani è sempre stato contraddistinto da una grande ricerca melodica e virtuosismi centellinati, ma con l’ennesimo cambio di formazione la loro proposta musicale si fa ancora più distante dagli album d’esordio. La copertina (un po’ anime) realizzata dalla giovane artista polacca Anna Bastrzyk non è all’insegna dell’happy metal, e nemmeno il titolo “Distant is the sun”: non facciamoci, tuttavia, influenzare dall’artwork e consideriamo la vera protagonista, la musica.
Dopo un canonico intro strumentale, “King of Empty Promises” attacca in modo supponente e pare di ascoltare gli Epica. Appena Massaro inizia a cantare (il suo timbro ricorda quello di Andreas Novak, cantante degli svedesi Mind’s Eye), il sound perde in cattiveria e il brano prosegue cristallino tra bridge e refrain melodici. Da menzionare la buona prova delle tastiere, intese in chiave pseudo-sinfonica (chissà perché chi le suona non figura nemmeno in line-up…), e un breve ma sapido assolo di chitarra. Opener in definitiva godibile, un po’anodino, però, per lasciare il segno.
La title-track evoca i migliori Stratovarius anni ’90; peccato che la furia metal si smorzi di colpo, per lasciare spazio a un inquietante respiro affannato di sfondo, in riferimento ai testi apocalittici della canzone. Ancora un ritornello orecchiabile, cui segue il main-theme su tappeto di pianoforte. Nella parte centrale compare un timido accenno in tremolo picking, ma il guitarwork non osa mai in quanto a tecnica.
Gustoso l’incipit pentatonico (con accenti sui tempi deboli) di “When Tuth lies”, per il resto un brano anonimo, che ripropone il solito trademark dei Vanishing Point, imbottito di “iper-melodia”. Massaro tenta un acuto appena più prolungato (quello nel finale di “Surreal” resta, però, irraggiungibile), ma la sua prova non è delle più brillanti; nel finale la doppia cassa è libera di scorrazzare e si avverte come un senso di libertà.
Special guest in “Circle of Fire” Tony Kakko (non va dimenticato che i Sonata Arctica hanno coverizzato, nell’EP “Don’t Say a word”, “Two Minds One Soul”, di certo non uno dei migliori brani di “Tangled in dream”). Il cantante finlandese, con la sua voce caratteristica, non potentissima, ma decisamente melodica (perché né Lucassen, né Sammet lo hanno mai coinvolto nei loro progetti?) dona un tocco di originalità alla composizione, che regala anche qualche finezza nelle parti di batteria.
“Let the river run” prende avvio a cappella e prosegue con patenti debiti AOR. Se ci fosse Jørn Lande al microfono sarebbe un pezzo memorabile, anche per un buon assolo ispirato e una delicata coda di pianoforte nel finale.
Nel prosieguo del platter si avverte della monotonia: “Denied Deliverance”, con doppia cassa terzinata, è poco più di un filler; “Story of misery” ha un incipit nostalgico-atmosferico e la melodia portante ricorda “Into the blue” dei Cain’s Offering.
Si dimostra una composizione migliore “Era zero”, con un attacco fulminante, che non stonerebbe in un album folk metal (Equilibrium su tutti) e un ritornello catchy, tra i migliori dell’album, da cantare a squarciagola.
Le successive quattro canzoni tornano su lidi stereotipati e non lasciano il segno. “Pillars of Sand” attacca con una voce tonitruante che scandisce «There’s no salvation»; ancora echi stratovariusiani e tanta doppia cassa. Il solo di chitarra alza i ritmi, ma solo per pochi secondi, lasciando una sensazione d’inappagamento.
“As December Fades” ha un titolo suggestivo, cui si ricollega un inizio artico, con tanto di synth d’arpa (un richiamo a “Before the Winter” di Tolkki & Co.?); “Handful of Hope” (e non “of pain” come per gli Helloween di “Better than raw”) è un’altra canzone fotocopia, che concede qualche spazio in più alle linee di basso, ma nulla più. Siamo agli sgoccioli e “Walls of Silence” prende avvio come una strumentale dei Nightwish, tra abbellimenti vari e incedere in crescendo.
Un poco contrariati arriviamo all’ultima traccia, che si rivela un finale a sorpresa e insperato. “April”, infatti è una delicata ballad strumentale acustica, tra i momenti migliori del platter, con tinte fiabesche e flebili. Felice epilogo di un album che poteva regalare ben più emozioni.
Ripercorrendo l’ora trascorsa nell’ascolto di “Distant is the sun”, si può dire che il nuovo album targato Vanishing Point è un disco curato e coeso, ma pecca per inventiva e idee messe in campo. Un minutaggio eccessivo e brani troppo simili tra loro ne pregiudicano la qualità generale. E dire che prese separatamente le tracce sarebbero tutte più o meno godibili! Se la produzione migliora rispetto a “The fourth season” e il sound complessivamente perde in velocità, ma guadagna in incisività, non resta molto, invece, dell’eclettismo di “Tangled in Dreams”. L’inflazionata ricerca melodica della band (che li avvicina al sound dei Mind’s Eye, Leverage e Dignity) non trova, inoltre, in Massaro un degno interprete delle linee vocali (stesso discorso si potrebbe fare per Bernhard Weiss degli Axxis). Va meglio la batteria di Christina Nativo, che non si risparmia in quanto a doppia cassa, ma non lesina neppure qualche preziosismo. Le chitarre si adeguano a una forma canzone standard e offrono brevi assoli fotocopia, che rifuggono tanto dal tremolo picking degli Helloween quanto dai barocchismi stratovariusiani. Tra i brani più convincenti, “Cicles of Fire” (giusto per il cameo di Kakko), “Era zero” e l’isolata “April”.
Il combo australiano, per concludere, pare intenzionato, o non riesce oggettivamente, a superare il punto di fuga che li mantiene nella sfera della mediocrità e impedisce loro di decollare nella stratosfera della grande musica.
Discutine sul forum nella sezione Power!

