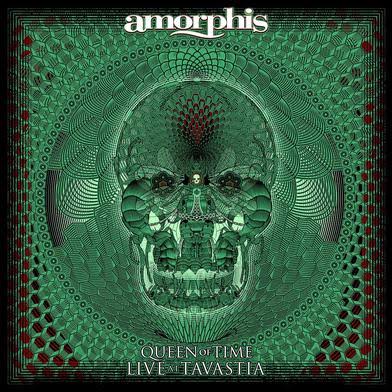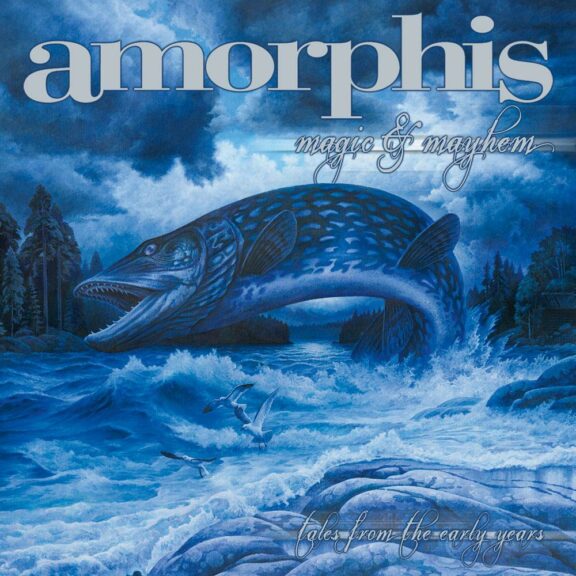Recensione: Eclipse
Tenendo fede al nome che ormai li accompagna da una abbondante quindicina d’anni, gli Amorphis fanno ingresso nel loro 2006 contando nuove e profonde mutazioni sia in termini di line-up che di sonorità. Separatisi dal loro storico cantante Pasi Koskinen con un comunicato che ha colpito la scena come un fulmine colpisce una carica di dinamite, i cinque finlandesi hanno assoldato il semisconosciuto Tomi Joutsonen, il quale ha dovuto affrontare l’oneroso compito di guidare il vascello di una delle band più influenti del panorama musicale finlandese e nord-europeo. Quasi immuni a ogni genere di critica, gli Amorphis hanno veleggiato tra il death e il doom, il folk e l’hard rock, il prog e l’elettronico piazzando di quando in quando quei capolavori dei loro album passati, ormai riconosciuti dalla quasi unanimità dalla critica, sempre spiazzata dagli informi ed efficaci cambi di direzione che portavano sempre un misto di delusione e successivo riavvicinameno a quei fans che speravano nella fedeltà a un certo tipo di sonorità.
Eppure, per quanto abbiano cambiato faccia innumerevoli volte, la scintilla Amorphis non si è mai sopita. A ogni giro di chitarra – e soprattutto di tastiera – si finisce sempre per annuire e pensare “sì, questo è proprio tipico degli Amorphis”, anche se si pongono a paragone canzoni diametralmente opposte come Black Winter Day e Smithereens, o My Kantele e Brother Moon.
Da dove derivi tutta questa idiosincrasia è presto detto: l’amore per alcuni temi fissi tradizionali ha sempre mantenuto il tono intellettuale di un certo livello, mentre la costante attenzione per i particolari, spesso modellati da mostri sacri come i Pink Floyd (per i quali Holopainen non ha mai nascosto una certa devozione), ha dato alle loro strutture melodiche quella marcia in più.
Eclipse esce da un sentiero reso tortuoso a causa di quel Far From the Sun che nella sua fiacchezza aveva un po’ annoiato buona parte dei fans, che pure avevano giudicato l’album come un prodotto di indiscussa qualità.
Infatti, fin dal packaging si vede il passaggio di testimone verso qualcosa di più rifinito: digipak di due materiali differenti, immagine di copertina finemente cesellata e libretto sicuramente più elaborato rispetto a quello bicolore di Far From the Sun. Unica pecca è la sua collocazione, incollato barbaramente al retro di a copertina. Ma se la copertina lascia ben presagire, il contenuto del disco è ancora più rassicurante.
Gli Amorphis sono tornati in grande spolvero, agitando la loro bandiera multiforme fatta di frammenti di Elegy, Tuonela e Am Universum insieme a quell’ingrediente X in grado di scrivere un nuovo capitolo della loro storia, piuttosto che ripeterne uno già vissuto.
E Joutsen? Come ha reagito al pressante stimolo di far parte di una band come gli Amorphis? Perfettamente direi, e questo è un gran sollievo per tutti. Voce profonda, ben strutturata e modellata su un tono leggermente gutturale, alla Vintersorg per intenderci, e passaggi in growl (sentire “Leaves Scar” per credere) di grande impatto che allontanano gli spettri di un’eventuale inadeguatezza nell’affrontare le canzoni più vecchie in sede live.
Il disco è tutto un fluire di trovate dinamiche la cui ricchezza si può solo ascrivere agli album più eclettici della loro carriera, come Am Universum ed Elegy, dalle cui linee melodiche trae la maggior parte della linfa vitale.
L’inizio psicadelico di “Two Moons” riporta in mente un prog-rock di memoria anche settantiana, se non fosse per le chitarre grasse e corpose e la sempre martellante percussione di un ispirato Jan Rechberger che riportano la mente ai capitoli più felici dell’evoluzione della band sul finire degli anni ’90. Le canzoni, tutte abbastanza brevi, si basano su dei riff decisamente catchy, di media velocità, che vengono immediatamente riscaldati e messi in moto dall’ottima voce del nuovo vocalist, la quale li arricchisce e li spinge verso quell’optimum che non erano riusciti a catturare con il precedente album, probabilmente influenzato da un Koskinen ormai spossato e proiettato verso i suoi progetti laterali come gli Ajattara e gli Shape of Despair.
Sia “House of Sleep” che la decadente “Born from Fire” sono esempi perfetti di come un semplice riff riesca a condurre una canzone in tutti i suoi stage più canonici fino a coinvolgere emozionalmente l’ascoltatore, una qualità che dovrebbe avere ogni canzone che si definisca ben fatta. Gli inserti di tastiera e di pianoforte a corollario delle chitarre sempre aggressive, notevoli nella malinconica “Under a Soil and Black Stone” (dove i fans più smaliziati riconosceranno un emozionante omaggio a “Moon & Sun Part I”), sono sempre in perfetto stile Amorphis, il che significa che sono pregni di un’eco vagamente orientaleggiante, qui non tanto marcato ma invece imperante nell’interludio doom-death di “Perkele (The God of Fire)“, il cui inizio ci trascina in un cubicolo persiano in perfetto stile Samael/Nile.
Le maestose melodie non cessano di stupire nel passaggio a canzoni anche un po’ più scontate come “The Smoke“, che ci ricordano come in Finlandia gli Amorphis abbiano fama anche nel mondo della musica più leggera, che facilmente digerisce strutture melodiche così abbordabili, pur non accettandole interamente a causa del pesante growl che infesta – e talvolta aggrazia – tracce altrimenti adatte anche a un pubblico più disomogeneo. Come contrappasso, è impossibile non parlare della gemma, e mia preferita di tutto l’album, “Brother Moon“, che fa suoi ritmi folk scandinavi, chitarre sordide e un cantato ispiratissimo, quasi commosso, che ricorda i momenti più felici di Elegy, dal quale si distacca solo grazie a una struttura compositiva ancor più complessa e appagante della media dell’acclamato album del 1995.
Interessante, anche se non particolarmente brillante, la conclusiva “Stone Woman“, forse la più antica tra tutte le canzoni, tanto che figurerebbe senza problemi nel singolo di My Kantele o – perché no – in Tuonela.
Concettualmente parlando, il ritorno in gran carriera ai temi del Kalevala è un altro marchio di fabbrica degli Amorphis, che questa volta hanno incentrato l’intero excursus dell’album sulla leggenda di Kullervo, lo sfortunato figlio di Kalervo, venduto come schiavo al fabbro Illmarinen e causa della morte della moglie dello stesso, uccisa in un gesto di collera tramutandole le mucche che era solita mungere in orsi famelici.
La qualità dell’album è indiscussa, e ora solo una domanda è legittima: sopravviverà all’impietoso passare del tempo?
Beh, sicuramente più del precedente. Eclipse è solido, vario e ben strutturato. Le canzoni prendono velocemente, e forse per questo potrebbero essere talmente ben assimilate da diventare presto un po’ ridondanti. Non sono canzoni fatte per headbangare o per immergersi in fiumi d’adrenalina: la musica degli Amorphis è diventata quasi intellettuale, lontana dagli ingenui schianti di Tales from the Thousand lakes, e questa è un’arma a doppio taglio.
Un death-folk-doom-heavy-prog per intenditori, come un buon vino d’annata in edizione limitata. Una vetrata cesellata, non un animale da palcoscenico, e dunque dev’essere inteso in questa maniera. Probabilmente in questo Eclipse rimane un’eredità del compassatissimo ex-cantante Pasi Koskinen, che amava interpretare le canzoni in sede live rimanendo spesso in una postura immobile, fulminando e gelando l’audience con lo sguardo bieco e distruggendo con la potenza delle sue corde vocali.
Vedremo cosa succederà quando la band si evolverà ancora una volta: scopriremo magari che certe canzoni hanno un potenziale sconvolgente se affrontate fuori dai canoni tipici della band.
Sia ciò che sia, lasciatemi comunque dire “bentornati Amorphis – fate come se foste a casa vostra”.
TRACKLIST:
1 – Two Moons
2 – House Of Sleep
3 – Leaves Scar
4 – Born From Fire
5 – Under A Soil And Black Stone
6 – Perkele (The God Of Fire)
7 – Smoke, The
8 – Same Flesh
9 – Brother Moon
10 – Empty Opening
11 – Stone Woman