Recensione: Fatigue
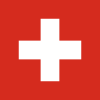
Coraggiosi, molto coraggiosi, i Life’s December.
A distanza di pochi mesi dal debut-album “Colder” gli svizzeri escono nuovamente sul mercato con un altro full-length, “Fatigue”. L’ardire non è però questo, cioè quello di proporsi con tanto materiale in poco tempo, rischiando di saturare la postazione. È un altro: quello di modificare il proprio stile in maniera netta, decisa, tagliente. In più, non verso la direzione della facile assimilazione ma, fatto piuttosto raro in generale, in quella contraria.
“Fatigue”, a parte la title-track, melodica, sì, ma non catchy da classifica benché sia presente la female vocalist di turno, è un disco assai introspettivo. Certamente, il sound è al solito duro, massiccio, roccioso. Accompagnato da inserti ambient e sonorizzazioni di completamento come sempre più spesso accade al deathcore moderno. Sound basato ora più che mai sul volutamente esagerato ricorso ai micidiali breakdown che la formazione di Wattwil è in grado di produrre in quantità industriale, e sui quali basa gran parte delle song. Ma, sempre e comunque, è presente una violenta, per intensità, vena di tristezza, di malinconia, di cupo languore. Tanto da far venire in mente, a chi scrive, il termine depressive deathcore. Per porre l’accento sull’anima martoriata posseduta dai Life’s December che, con bravura eccezionale, riescono a trasfondere nel loro “Fatigue”.
Un tormento che il bravissimo Rico Bamert riesce a esprimere con grande trasporto, emotività, tragicità; parendo, a volte (‘O Dulce Nomen Obitus’) il vocalist di un progetto di suicidal depressive black metal. Così non è, e quindi i Life’s December riescono ad azzeccare uno stile sostanzialmente unico. Sintomo evidente di grande capacità a livello di composizione, oltre che a quella tecnica (si rinomina ‘O Dulce Nomen Obitus’ quale esempio di adulta e matura abilità strumentale).
Occorre tuttavia parecchio tempo per entrare in sintonia con Fatigue”. Anzi, addirittura, agli inizi, lo sconcerto per il classico «ma che cosa stanno facendo?» è rilevante, poiché, dopo i primi passaggi, non si riescono a mettere assieme gli indizi che, in maniera forse un po’ troppo accentuata, sono diluiti fra le dodici song del CD. Indizi che, sommati, formano al contrario prova inoppugnabile di quel coraggio di cui si scriveva all’inizio.
La ridetta, lunghissima suite finale ‘O Dulce Nomen Obitus’, inoltre, è una sorta di prova di coraggio nella prova di coraggio. Il brano è assai articolato, complesso. Dà la sensazione di perdersi nello spazio e nel tempo. Ma, con bravura, i Nostri ce la fanno, a non perdere la bussola e a viaggiare precisi e decisi nell’immaginazione di una mente melanconica, solitaria e incline alla depressione.
Un atteggiamento artistico che va sicuramente premiato, poiché esulante dai soliti cliché che ammorbano il metal estremo in generale e il deathcore in particolare.
Avanti così!
Daniele D’Adamo


