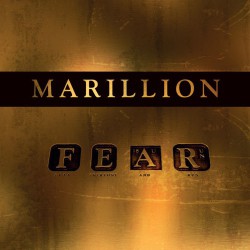Recensione: FEAR (Fuck Everyone And Run)

… But in England,
although nothing really changes,
the weather always does
I Marillion sono la prova vivente che la buona musica serve all’anima. Li ascoltiamo oggi, li riascolteremo quando saremo senescenti. Quasi quarant’anni di carriera, l’era Fish ormai lontana, l’istrionismo di Steve Hogarth quale traghettatore dalla creatività mai doma, insieme al fondatore Steve Rothery e i compagni di viaggio Trewavas, Kelly e Mosley… La line-up è stabile da più di un quarto di secolo, il produttore Mike Hunter ormai ha preso le veci dello storico Dave Meegan, la base di fan resta affidabile (ancora una volta il combo inglese si è poggiato a una campagna di crowfunding per pubblicare l’album), tutte premesse per proseguire in un cammino sonoro che sembra inarrestabile.
FEAR si presenta in modo ruvido: copertina monocroma color oro e un acronimo al limite del cattivo gusto. Poteva intitolarsi semplicemente GOLD, ma è bene leggere quanto asserito dal cantante:
Il titolo non è stato scelto con rabbia o con l’intenzione di scioccare. È stato scelto e cantato (nel pezzo “New Kings”) teneramente, in uno stato di tristezza e rassegnazione da un inglese, e da un mondo, che funziona sempre più basandosi su una filosofia in cui ciascuno pensa per sé. Non vi annoierò con esempi, sono tutti sui giornali, ogni giorno.
C’è un senso di presentimento che permea parecchie parti di questo album. Ho la sensazione che stiamo assistendo a una specie di cambiamento nel mondo, una burrasca irreversibile sul piano politico, finanziario, umanitario e ambientale. Spero di sbagliarmi. Spero che la mia PAURA circa quanto sembra alle porte sia solo un presentimento, e non la PAURA di ciò che a dire il vero sta per accadere.
Il tema profetico, intriso di critica all’egoismo e un sano contemptus divitiarum, è il fil rouge che lega i brani di FEAR, album coeso ma che non può dirsi un concept album se non in senso lato. L’acronimo, dunque, è il correlativo oggettivo delle tinte sconfortanti dei nostri tempi e dello squallore che deriva dall’attaccamento al denaro (Hogarth è fissato con il tema del lusso, ricordiamo i testi di Brave). Adesso tutto torna, il trademark alla Marillion è stato rispettato.
I sedici minuti di “El Dorado” iniziano in modo decisamente rilassante, con un giro di chitarra acustica che ricorda quello di “Beneath the Surface” dei Dream Theater (da sempre fan dei Marillion). Alla fine di primi centoventi secondi i synth di Kelly e i tasti d’avorio regalano armonie da sentimento oceanico dell’essere e la psichedelica prevale. I primi sussulti si hanno nel prosieguo. “The Gold” è un movimento malinconico e smagato, i Marillion vivono soprattuto di accostamenti arditi fra testi e musica (“The gold took more lives than Uranium…2). Rothery non ha perso il suo tocco magico alla chitarra elettrica e i suoi assoli ci accompagnano come un leitmotiv lungo l’ora abbondante di minutaggio. L’effetto “disco rovinato” all’inizio del quarto movimento è un filo disturbante (ritotnerà più volte), le liriche sono feroci: “And the madmen all say they hear voices/God tells them what to do/The wars are all about money”. Uno dei momenti, perciò, più ruvidi del disco, vicino al dettato sonoro dei connazionali Porcupine Tree, cui segue una calma dopo la tempesta, con puzza di zolfo in un’aria post-bellica: “We are the grandchildren of apes, not angels/But only we are gifted with the eyes to see”. In definitiva “El Dorado” è una suite memorabile, tutta incentrata sul significato connotativo del termine gold, la dea pecunia che pare immortale e rinfocola l’egoismo umano.
“Living in Fear”, primo dei due brani dalla durata “canonica”, invece, non è una hit memorabile, c’è troppa rabbia, però l’ultima strofa, assieme a un momento pseudo-gospel, presenta testi significativi, con tanto di azzardo poliglotta: “What a waste of time/The Great Wall of China/What a waste of time The Maginot line/The Great Wall of China/Что за трата времени/Берлинская стена (What a waste of time Die Berliner Mauer)”.
“The Leavers”, traccia più lunga in scaletta (quasi venti minuti), cerca di dare un ritratto degli artisti d’oggi, raminghi, sradicati. Nel primo movimento “Wake up in music” i controtempi di Mosley sono una bella trovata, le tinte soffuse richiamano, invece, il lato meno estremo dei già citati Porcupine Tree. L’artista saltimbanco di fine Ottocento sembra essere tornato una realtà attualissima.
Dopo la breve sezione “The remainers”, con tanto di autocitazione (“Like gypsies at fairs/We will meet someone new somewhere else”), “Vapour Trails in the Sky” regala momenti sospesi nel tempo che ricordano le atmosfere ondivaghe di “Ocean Cloud” in Marbles, ma anche l’impressionismo di Happiness is the road. I testi toccano vette alate: “We are the Leavers/And the world turns beneath us/We’re somewhere above you”. Forse una citazione baudelairiana?
Il contrasto tra leavers (gli eletti?) e remainers (la gente comune?) continua nella “confusione dei giorni”, i minuti passano, non ci si accorge che il tempo trascorre, siamo immersi in una dimensione parallela… Sul finire del quindicesimo minuto le parti ritmiche ricordano gli Yes che furono; il finale di suite, “One night”, è più spedito e rockeggiante. Resta il fatto che dopo un intero ascolto di The Leavers si esce in uno stato di grazia esaltante, è avvenuta una catarsi liberatoria. Prima del gran finale, “White Paper”, ballad struggente, vive di testi incentrati sul tema dei cromatismi emotivi dell’io lirico narrante: “The different shades of white/Are in my head tonight/What happened to the colours of fire?/What happened to the colours?”. Una confessione delle proprie paure più intime, su tappeti armonici da brividi, un brano memorabile.
“The new kings”, infine, s’avvia intriso di pathos: Kelly è da applausi, Hogarth scandisce l’acronimo che dà titolo all’album con un falsetto che ne depotenzia il significato provocatorio. In “Russia’s Locked Doors” la chitarra di Rothery diventa così minimalista da sembrare eterea, un toccasana. I testi, invece, restano caustici (“On your knees, peasant, and kiss this ring”), l’alternanza del finale di verso “We’re too big to fall/to fail” sintetizza tutta la superbia della filosofia del self made man votato all’accumulo sterile. Dopo lo sfogo luddista in “A scarty sky (“they can do anything with computers these days”), la conclusione di suite è affidata a “Why Is Nothing Ever True?”, movimento più ruvido e patriottico (“Remember a time when you thought that you mattered,/Believed in the school song, die for your country”).
“Tomorrow’s New Country” è solo una breve coda voce-pianoforte in calce.
FEAR in definitiva è un album sfaccettato, d’atmosfera, merita più di un ascolto attento e sa avvolgere chi gli dedica tempo. La produzione è pulita, pochi i virtuosismi, il valore aggiunto dei Marillion resta la dissociazione tra testi e musica, che rende ancora più icastico il contenuto delle liriche. Diamo merito a questa grande band, che è riuscita a reinventarsi più volte nel corso della sua storia e oggi taglia il traguardo dei diciotto studio album e lo fa ancora una volta non deludendo.