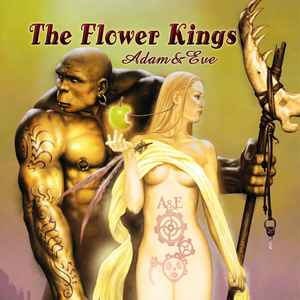Recensione: Flower Power

Flower Power è il quarto studio album dei The Flower Kings, nonché l’ultimo con la line-up storica che prevedeva la coppia ritmica composta da Michael Stolt, fratello del mastermind Roine, e Jaimie Salazar. Quarto album, dicevamo, per di più in quattro anni, 1994-’99: la prolificità del combo svedese si ripresenta prepotente, con un doppio album, ma questa volta il risultato è inferiore al precedente Stardust We Are, ormai classico neoprogressive. Siamo sul finire della prima era dei TFK, quella più scanzonata, genuina e rockettara. Il successivo Space Revolver vedrà una svolta verso lidi più concisi, ma non meno progressive.
Flower Power, già dal titolo parlante in omoteleuto, è forse il lavoro più arduo da digerire degli scandinavi, due ore di prog. rock lisergico e insano, degno erede del dettato falotico dei Seventies. Volendo paragonare il platter a un romanzo, si potrebbe citare un mattone che non si riesce mai a leggere/reggere fino in fondo, magari Guerra e Pace, magari L’adolescente di Dostoevsky.
Il sottotitolo del full-length è già un programma: “A journey to the hidden corners of your mind”: l’opener, che occupa in sostanza il primo disco, “Garden of Dreams”, è la descrizione di un anelito verso un nuovo Eden, la Gates of Delirium anni Novanta, con Stolt quasi sempre al microfono e frequenti divagazioni strumentali.
Le danze iniziano con suoni d’accordatura sinfonica, poi un crescendo inconfondibilmente TFK. La voce di Stolt è calda e ammaliante, fa sentire a proprio agio, chiunque potrebbe cantare “Simple song”. Dall’alba edenica si passa ai ritmi più eclettici di “Business Vamp“, brano cadenzato con arrangiamenti di pianoforte e le percussioni di Bruniusson in gran spolvero; Bodin ai sintetizzatori è un mito vivente, ma quello che colpisce è la ricchezza variegata del sound degli svedesi, saturo e gratificante.
Ballad passabile la seguente “All You Can Save”, con un refrain retrò commovente: «Bye, it’s no use to cry / You’re feeling so sad, but you don’t know why / You’re leaving home and you’re leaving alone», rovinato da una coda smielata: «All you can save is the love that we made / when you’re lost in the shades again». Un inno all’amore cosmico, dunque, ma trova spazio pure un assolo bluesy. Stolt convince, il suo stile chitarristico è unico, tra bending ispirati e volute asperità che mettono la tecnica a servizio del pathos.
Brusco cambio di ritmo e “Attack Of The Monster Briefcase” porta una ventata di follia prog. dove le percussioni e la batteria regnano incontrastate. Ritorna il tema iniziale di tastiera, la suite è lunga e servono questi richiami intertestuali. La breve “Mr. Hope Goes To Wall Street” è una chicca circense con un basso indiavolato, fischi, versi ornitologici e affini. Incredibile come gli svedesi riescano a riempire due minuti scarsi di trovate notevoli.
Dall’allegria proggish a una nuova mestizia, “Did I tell you?” procede lenta e smagata. Seguono due ottimi pezzi, agli antipodi tra loro. “Garden Of Dreams” è un interludio senza chitarre cantato da Fröberg. Si ritorna nell’Eden primigenio: «Fingers of green from a world unseen / Grab my head in this magic dream». Finale fatato, poi un accordo abrasivo di chitarra e attacca “Don’t let the devil in”, una delle migliori canzoni rock tout court mai composte dagli svedesi. Siamo catapultati in un megadrome infernale, tra mindless slayers e nuclear tanks: un groove trascinante, ascoltare per credere.
Dopo alcuni secondi allucinati, con voci urlanti e percussioni da manicomio, “Love Is The Word” incede spigliata e calma in parte le acque. Bella la parentesi semiacustica a metà brano, ascoltare i fratelli Stolt all’opera è sempre un piacere per le orecchie.
Magicamente le atmofere si colorano di un’altra sfumatura. “There’s No Such Night” è una rivincita della luce sulle tenebre: «Look inside, you’ll find it glowing in the dark / Seed of life, the mouth of evil couldn’t chew that spark tonight». Stolt si spinge su acuti impegnativi e non delude. Senza soluzione di continuità è la volta di uno tra i momenti più lisergici e sperimentali del disco, con organo e voce tenorile, seguiti da una sezione che potremmo definire latamente space rock onirica. Non sappiamo dove andremo a finire, il concetto di necessità è dissolto. Una nuova esplosione rock, oppure una parentesi strumentale prog? Niente di tutto questo, dopo la criptica “The Mean Machine“, “Dungeon of the Deep” continua su binari mistici, tra voci bianche e canto gregoriano. All’inizio del quarto minuto come trattenere un brivido nel crescendo dei cori e l’inizio di una pioggia torrenziale? Un brano degno dei migliori IQ, che resta impresso nei ricordi dell’album insieme alla suggessiva “Indian Summer”, ballad tristissima dai testi poetici: «Days getting shorter, nights turning cold / Last days of summer, tales being told». Un brano voce-pianoforte con inserti di violoncello e una seconda parte in crescendo. Impossibile non commuoversi sentento Stolt scandire i testi… Consigliato l’ascolto il giorno del proprio compleanno, finite feste e affini, per riflettere sulla caducità e la bellezza della vita.
Ultimo quarto d’ora della suite. “Sunny Lane”, come la futura “Fast Lane”, è un brano ottimistico, in questo caso strumentale. Si sente che i musicisti chiamati in causa hanno una grande esperienza alle spalle, suonano in scioltezza senza strafare, ma trasmettendo emozioni con idee spesso semplici. Basta un synth adatto al caso, un fraseggio en passant, un gioco di richiami tra strumenti.
“Garden Revisited” lascia più spazio solistico a Roine Stolt, “Shadowlands” è un’altra strumentale, pleonastica, ma tanto i TFK non sanno cosa significhi il termine concisione. “The Final Deal” rappresenta un finale fin troppo sguaiato, con testi al limite del culto hippy più sfegatato. Dalle tenebre si torna alla luce del sole: «In Love we trust, we’re home at last».
Ci siamo lasciati alle spalle un’ora di rock progressivo pirotecnico, da lasciare frastornati. Tutto potrebbe concludersi qui e invece il primo disco termina con tre brevi strumentali, due divertissement da pochi secondi e “Astral Dog”, grande pezzo di bravura chitarristica.
Il secondo cd è comunque notevole, unico difetto è la solita prolissità degli svedesi. Si consiglia caldamente il suo ascolto non in sequenza con il primo platter, il rischio d’overdose è concreto!
“Deaf, Numb and Blind” è un opener caledoscopica, con repentini cambi di tempo e atmosfera: i primi tre minuti sono pura goduria. “Stupid Girl” (inserita con altri arrangiamenti nel best of del 2007, The Road Back Home) a mio avviso è tra i migliori brani corti mai scritti dagli svedesi. Chitarre rockeggianti, testi misogini e arrangiamenti di tastiera geniali. Un hit memorabile che meriterebbe più di un passaggio in radio. Lo stacco al min. 4:40 è orgasmo puro, con basso in primo piano e Roine Stolt a dipingere svolazzi chitarristici. L’affiatamento tra i musicisti è totale.
Percussioni a gogò in “Corruption”, brano atipico, su ritmi lenti, quasi reggae. Può non convincere, personalmente conservo un buon ricordo del pezzo. “Power Of Kindness” è un highlight, opera di Bodin nelle vesti di organista sullo scorcio del millennio. Si prosegue come se l’album durasse all’infinito. “Psychedelic Postcard” inizia con la voce di Stolt filtrata per risultare acida (ma senza raggiungere le vette istrioniche di “Bavarian Skies”): la componente circense del loro sound resta imprescindibile.
I ritmi rallentano di colpo: “Hudson River Sirens Call 1998” è un brano strumentale crimsoniano, con voce lirica in lontananza e un finale allucinato con tanto di Miserere cantato da voci bianche. Una ballad è quello che ci vuole dopo un brano interlocutorio: detto, fatto, Hasse Fröberg ruba la scena a Stolt e canta in “Magic Pie”, di cui ha scritto anche i testi. Bello l’assolo di clavicembalo nella seconda parte del brano, ma tutto è troppo edulcorato.
“Painter”, invece, è un ottimo pezzo, ma resta anonimo nella lunga tracklist. Peccato, perché il refrain corale con tanto di campane è un tripudio di gioia e ambizione. Dopo un’altra ora di musica si è sfiniti e “Calling Home” dura più di dieci minuti: gli scandinavi vogliono vederci morire per eccesso di belle canzoni… Un lungo crescendo, poi, dopo cinque minuti, i ritmi si fanno più scoppiettanti, tra citazioni natalizie, bonghi e testi apolitici. Un brano prolisso, proprio sul finire di scaletta, superarlo è difficile. Per i pochi sopravvissuti c’è l’aldilà: “Afterlife”, strumentale che riecheggia i meandri appena percorsi.
Il doppio album è stato ristampato nel 2010 e contiene alcune bonus track, non sono ironico!
Di certo Flower Power è un album ambizioso, di quelli che lasciano il segno, un po’ come Tales from topographic oceans degli Yes, ovviamente con le dovute differenze. Dopo averlo ascoltato nella sua interezza si ha l’impressione di essere “cresciuti” non solo a livello di gnosi musicale.
Non si può essere troppo generosi nel dare un voto, perché c’è musica per almeno tre album stipata in uno solo. La suite “Garden of dreams” contiene alcuni momenti strumentali pleonastici, il secondo cd manca di coesione e vive della giustapposizione di alcuni buoni brani e altri mediocri.
Per chi è cresciuto con la musica dei TFK, il loro quarto album resta indimenticabile, per chi deve ancora approcciarvisi il consiglio è di alzare al massimo il livello delle presupposizioni musicali. Non resta che augurare a tutti semplicemente un buon ascolto.
Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)