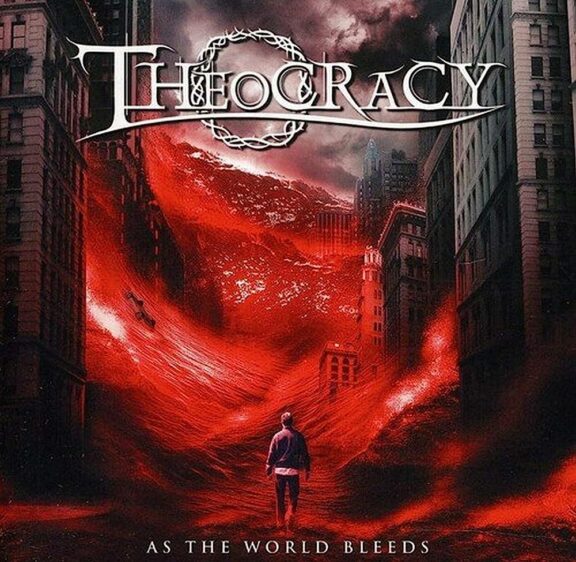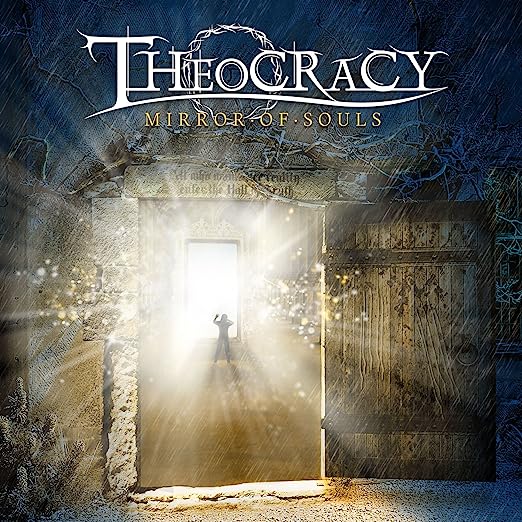Recensione: Ghost Ship
Quarto album per i Theocracy, che con questo “Ghost Ship” donano un successore al già più che buono “As the World Bleeds”. Per chi non li conoscesse, i Theocracy sono un gruppo di baldanzosi ragazzotti americani dediti ad un christian metal molto vicino alla scena power europea, caratterizzato da cori possenti, ritmiche corpose e dosi di melodia abbondanti ma sempre ben dosate, senza mai scadere (o comunque mai troppo) nel temutissimo metal-là-là-là. Niente di nuovo sotto il sole, naturalmente, ma ammetto che già dal primo ascolto di questo “Ghost Ship” sono rimasto molto impressionato: le canzoni sono lineari e, volendo essere cattivi, anche abbastanza prevedibili, ma il tutto è confezionato con un tale equilibrio che i piccoli difetti di cui sopra scompaiono come un vassoio di tramezzini ad un buffet aziendale. Tutto in quest’album è esattamente dove ci si aspetta che sia, dai solo, ai cori, alle parti più aggressive fino ai rallentamenti più groove, ma ogni singolo elemento nell’economia finale di questo lavoro è così perfettamente bilanciato che, ascoltandolo, non si può fare altro che mettere il cervello in folle, rilassarsi e godersi il viaggio sulla nave fantasma. Non so come, ma l’ascolto di quest’album ha il potere di mettermi subito di buonumore: l’ultima volta che mi è successa una cosa del genere è stato quando un mio amico mi ha fatto sentire per la prima volta “The Winter Wake” degli Elvenking, ma non divaghiamo. Mi farete sapere nei commenti, se vorrete, se anche a voi ha fatto lo stesso effetto.
L’inizio è, com’era lecito aspettarsi, arrembante: “Paper Tiger” svolge appieno il suo compito di opener dispensando entusiasmo e trionfalismo a manciate, avvolgendo la voce di Matt con suoni potenti e corposi ma senza affossarla sotto ondate di tastiere. Buona anche la sezione strumentale della seconda metà, poco prima dell’alzata di tono finale. Si prosegue più o meno sulla stessa rotta con la title-track, introdotta da un riff corpacciuto a sua volta sorretto da melodie più inquietanti che si sciolgono al sole con l’ingresso in scena di Matt. Il brano mantiene ritmi piuttosto agili, lanciandosi a vele spiegate in corrispondenza del ritornello corale, e trova anche il tempo di rallentare in un paio di occasioni per imbeccare, in vista della sua sicura riproposizione dal vivo, un breve botta e risposta col pubblico. “The Wonder of It All” parte a spron battuto, con ritmiche coatte e riff grassi lanciati a velocità più consone a certo speed metal. La carica del pezzo prosegue fino all’entrata in scena della voce e soprattutto dei cori, che innalzano il trionfalismo del pezzo diluendone in parte l’aggressività. La canzone, della durata complessiva di poco meno di sette minuti, balzella continuamente tra sfuriate speed e momenti più melodici, con la componente trionfale che alla fine prevale. Tastieroni sontuosi introducono la successiva “Wishing Well”, dall’approccio iniziale più ritmato ed anthemico ma anche piuttosto banale. Non tutto il male vien per nuocere, poiché procedendo con l’ascolto il brano si incattivisce, riguadagnando punti grazie ad un lavoro di chitarre preciso e funzionale. Ottimo il ritornello: sebbene anche qui ci sia ben poco di originale, le linee melodiche sono azzeccatissime e incredibilmente coinvolgenti.
Melodie delicate da carillon e il ticchettio di un vecchio orologio spianano la strada alla più rock-oriented “Around the World and Back”: tutta la canzone è giocata su tempi scanditi, cori zuccherosi e qualche breve ed innocua schitarrata di tanto in tanto; molti di voi, leggendo quanto appena scritto, si saranno sentiti accapponare la pelle in vista di una traccia inutile e fin troppo mielosa, ma vi assicuro che anche qui, nonostante l’impressione da sigla dei cartoni animati, tutto funziona così bene che in un batter d’occhio vi ritroverete a canticchiare il ritornello dell’ennesima traccia decisamente coinvolgente. Un riff aggressivo spezza l’incanto da “pace e amore” che si era creato con la taccia precedente e ci introduce “Stir the Embers”, canzone diretta che, però, tra un riff stoppato e una breve melodia quasi horror gettata lì come per caso, torna ad esibire un approccio più solare nel ritornello, ripiegando sull’aggressività solo in un paio di occasioni prima del finale (tra cui il bell’assolo). La successiva “A Call to Arms” parte con un riff tipicamente rockeggiante e si sviluppa, poi, ricorrendo a tempi tendenzialmente scanditi squarciati da brevi accelerazioni, salvo poi esplodere in un ritornello incredibilmente accattivante e dalle melodie anche qui azzeccatissime, seppur non troppo originali. Il leggero ispessimento del suono in corrispondenza del ritornello è solo un breve fuoco di paglia, visto che prima del finale si ritorna alle melodie che, di certo, dal vivo mieteranno più di una vittima nonostante una certa zuccherosità. “Currency in a Bankrupt World” permette ai Theocracy di approcciarsi al brano in modo leggermente diverso da quanto fatto finora, iniziandolo come la classica ballata da classifica ruffiana e melodica e sviluppandolo, sorpresa, come la classica ballata da classifica ruffiana e melodica. Anche qui, come altrove, ogni elemento è esattamente dove ci si aspetta che sia, compreso il rallentamento più compassato e narrativo, il ritornello carico di emotività ed il breve stop prima dell’improvvisa alzata di tono in vista del finale, rigorosamente sfumato; anche qui, come altrove, le cose funzionano a dovere ed il brano, pur essendo uno dei meno riusciti dell’album per via di alcune scelte stavolta davvero troppo scontate, evita di scadere nell’inutile pacchianeria e porta a casa il risultato.
Arriviamo ora alle battute finali. La penultima traccia, “Castaway”, torna ai ritmi più rapidi e briosi che già abbiamo incontrato miscelando riff robusti alle solite melodie solari, ma alla fine non fa che riproporre (seppur molto bene) quanto già sentito nella prima metà dell’album, mentre è con la conclusiva “Easter” che i Theocracy si giocano il tutto per tutto. Introdotta da un arpeggio lento e contemplativo, la canzone (della durata di dieci minuti abbondanti) aggiunge al suono del gruppo elementi più solenni e dal sapore cinematografico, i quali si mescolano ai riff decisi e alle melodie del combo americano per creare un unicum che, nonostante il minutaggio, si lascia ascoltare senza mai stancare. Il finale è giustamente trionfale, e corona perfettamente un ottimo album chiudendolo con un climax adeguato.
Prima di concludere mi si permetta un appunto alla copertina dell’album che, nonostante sia curata dal prezzemolino Felipe Machado (di cui non amo particolarmente lo stile, per me troppo freddo) mi ha piacevolmente colpito per il suo gusto un po’ retrò.
Con questo “Ghost Ship” i Theocracy ci spiegano come confezionare un album convincente, godibile e soprattutto coinvolgente senza dover suonare originali a tutti i costi, bilanciando con gusto gli elementi della propria proposta fino a creare un prodotto finale superiore alla somma delle sue parti.
Ottimo lavoro, ragazzi.