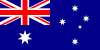Recensione: Handmade Cities
Un ragazzo poco più che ventenne scrive qualche pezzo alla chitarra, lo registra nella sua cameretta e lo pubblica su Youtube. È così che ha iniziato Plini, chitarrista di Sidney che in pochissimi anni è passato dal suonare in casa ad aprire i concerti per gruppi del calibro degli Animals as Leaders, dei Tesseract, o dei Cynic. Quello che gli ha permesso di distinguersi tra la moltitudine dei cosiddetti “bedroom players” è una notevole qualità nei pezzi, che riescono a essere moderni senza esagerare nel seguire le mode, insieme un grande gusto melodico, il tutto supportato da una tecnica eccellente. Dopo aver pubblicato tre EP, uno più bello dell’altro, e aver riscosso un discreto successo su Youtube, il musicista australiano si è sentito pronto per pubblicare il suo primo vero album, questa volta accompagnato da Troy Wright alla batteria e Simon Grove al basso, due ottimi musicisti che sembrano essere entrati nella band in pianta stabile. Ecco quindi arrivare Handmade Cities.
La musica di Plini è interamente strumentale, e possiamo definirla a grandi linee come un incrocio tra fusion e progressive metal, con un pizzico di djent. Le influenze vengono quindi da chitarristi come Guthrie Govan, Allan Holdsworth, John Petrucci, Steve Vai o da band come Animals as Leaders e Periphery, anche se il sound non è mai violento come in questi ultimi. Al contrario, già nel primo brano, “Electric Sunrise” ci si può rendere conto che l’atmosfera è molto positiva: il riff in tapping, la ritmica possente e le numerose parti di tastiera (leggermente in secondo piano ma sempre presenti) rendono il pezzo trascinante e solare al tempo stesso. La title track con la sua ritmica quasi funk si spinge ancora di più in questa direzione, e risulta forse il pezzo più allegro di tutto l’album. Bellissimi i fraseggi della chitarra, che alternano spesso le dinamiche e i volumi in un gioco di pieni e vuoti con gli altri strumenti. Più complessa la successiva “Inhale”: l’introduzione procede lenta e soffusa per poi arrivare un’esplosione di riff, accordi e orchestrazioni, fino all’ultimo, spettacolare, assolo. Di nuovo le sezioni veloci e quelle lente sono dosate con cura e, anche qui, le tastiere aiutano molto, rendendo il brano epico o dolce a seconda dei momenti. Si arriva poi a una sorta di ballata, “Every Piece Matters” che, sul finale, si distingue grazie a un coro che riprende il tema principale. Nella prima parte di “Pasteurs” esce tutta l’influenza del già citato Allan Holdsworth, non come una copia ma piuttosto come una piacevole somiglianza, sempre interpretata nello stile di Plini. Nella seconda parte del brano troviamo invece un crescendo che comincia con un arpeggio intrecciato poi con un riff sbilenco della chitarra per arrivare al climax sull’assolo. “Here We Are, Again” è la traccia più breve, un’altra ballata nella quale spiccano gli archi, e prepara il terreno per “Cascade”, il pezzo conclusivo. Qui si può sentire il meglio del chitarrista australiano: riff e assoli ci travolgono proprio come la cascata del titolo, ma nel modo più gradevole possibile, sprigionando passione fino all’ultima nota, senza mai un virtuosismo fastidioso o fuori luogo, nonostante l’elevato livello tecnico. Il brano inoltre mescola in modo eccelso i generi cui si accennava, con un risultato omogeneo e naturale.
Che dire, per essere un album d’esordio Handmade Cities è molto maturo, e convince dopo pochi ascolti. Un disco breve, come si usava una volta, perché non è obbligatorio raggiungere i sessanta minuti in ogni album. Anzi, nel progressive a volte si rischia di essere ridondanti, mentre una durata leggermente ridotta gioverebbe a più di un disco. Ma quel che colpisce di più è il modo in cui Plini sia già riuscito ad amalgamare le sue diverse influenze per creare uno stile personale e riconoscibile. La sua musica suona moderna ma sa anche quando e cosa riprendere dai musicisti delle generazioni precedenti. A questo punto non vediamo l’ora di sentire il suo prossimo lavoro, perché l’inizio promette davvero bene.