Recensione: Holy War
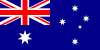
Giunti al terzo album, “Holy War”, i Thy Art Is Murder rappresentano la tipica anomalia intrinseca a un insieme altrimenti omogeneo e compatto. Nel caso in esame la famiglia è quella del deathcore, anche se la spaventosa furia devastatrice del combo australiano può comprendere anche quella, più allineata all’ortodossia, del brutal death metal.
Anomalia poiché, al contrario di altri ensemble che praticano più o meno lo stesso genere (Heaven Shall Burn, Neaera, Cattle Decapitation), i cinque musicisti di Blacktown hanno sempre diviso gusti e critica. Troppo aggressivi per il deathcore che, spesso, non dimentica di inserire in sé certe melodie più o meno accattivanti; troppo lontani dai classici cliché del death metal, per via delle notevoli interferenze *-core e della ‘troppa modernità’.
E ciò, se ci si riflette un attimo, è sintomatico comunque di una personalità che vuole esulare da catalogazioni e classificazioni. Un punto a favore per i Nostri, insomma. Che, alla fine, cercando la propria identità, pare abbiano scelto di seguire, seppur parzialmente, i Behemoth e il loro caratteristico ‘blackened death metal’ (“Holy War”, “Coffin Dragger”). Incupendo, cioè, il caratteristico sound tagliente e brillante del deathcore con passaggi tetri, oscuri, caratterizzati da un pessimo se non misantropico umore.
È altrettanto chiaro ed evidente che, nonostante questa ricerca volta a rendere più profondo un suono a volte esageratamente scolastico, prevedibile, i Thy Art Is Murder restino una delle più poderose macchine da guerra del globo terracqueo. L’interpretazione ai limiti della sopportazione umana di CJ McMahon è sicuramente insuperabile o quasi, in termini di rovesciamento di bile sul microfono. Così come (“Fur And Claw”) gli spaventosi, agghiaccianti, stop’n’go da squartamento delle membra, il cui gradiente energetico tocca i più alti picchi attualmente esistenti. Sommati alle incredibili accelerazioni oltre la sfera dei blast-beats operate da Lee Stanton. E, naturalmente, all’immenso riffing Andy Marsh e Sean Delander, volto a mettere assieme i mattoni di un muro di suono cui non si vede mai la fine.
Se sin’ora molte delle osservazioni negative al quintetto australe si concentravano sulle song, intrappolate in una tecnica soffocante e nella sua stessa forza attrattiva, con questa voglia di emotività (“Emptiness”) i Thy Art Is Murder varcano il proprio limite compositivo. Probabilmente non in modo definitivo. Anzi, è facile che “Holy War” identifichi un momento di transizione fra la brutalità assoluta e qualcosa di più ragionato, maggiormente centrato sulla complessità e ricchezza dei sentimenti umani, anche se osservato dal versante negativo della faccenda. Com’è giusto che sia, giacché per attitudine primigenia i Thy Art Is Murder non sarebbero presumibilmente a proprio agio, né tantomeno credibili, a narrare di party, ragazze e sbronze in compagnia.
Allora, è il caso di mettere da parte i pregiudizi e magari le analisi affrettate per dare merito ai Thy Art Is Murder di averci voluto provare, con “Holy War”. La loro bravura, fra l’altro, è esorbitante per cui, senza impegno, si può sperare in altro tassello evolutivo per il prossimo capitolo della saga.
Daniele “dani66” D’Adamo



