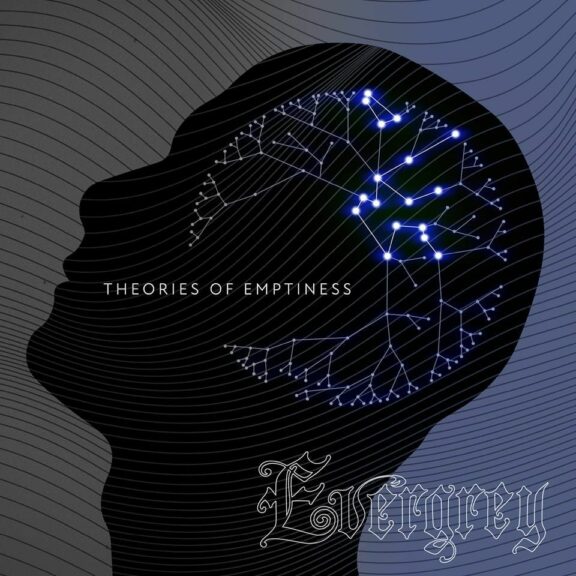Recensione: Hymns For The Broken
Dice una regola della cosiddetta Legge di Jante: “Non credere di valere quanto noi”. La possente musica degli Evergrey sembra il manifesto di questa pseudo-massima scandinava, personificata, più specificamente, nella figura colossale (vedere per credere, è alto quasi due metri!) del cantante e mastermind Tom Englund.
Il gruppo svedese, però, è da tempo un gigante dai piedi d’argilla che è riuscito a stento ad arrivare ai tre lustri di carriera. Dopo il dittico, oscuro a dir poco, di fine anni Novanta, composto da The Dark Discovery e Solitude Dominance Tragedy, il capolavoro indiscusso della band resta l’indimenticato In Search of Truth del 2001. Seguono due buoni, ma leggermente imperfetti, album prog. metal come Recreation Day e Inner Circle, quindi il passo falso di Monday Morning Apocalypse. Torn ripropone gli Evergrey su livelli meritori, l’ultimo Glorious Collision, anche, ma ormai la line-up originaria si è sfaldata e resiste solo l’accoppiata Englund-Zander. Senza contare il clamoroso furto avvenuto a Roma nel maggio 2010, dopo un concerto, che costò al combo scandinavo circa trentamila euro in strumenti musicali e merchandise.
È quasi un miracolo, dunque, la qualità del nuovo e nono studio album Hymns for the Broken, che vede il rientro del chitarrista storico Henrik Danhage e del batterista Jonas Ekdahl, affiancato, alla base ritmica, dal bassista Johan Niemann (ex-Therion, ex-Mind’s Eye).
Il leader Englund ha pensato più volte di gettare la spugna e sciogliere il gruppo, non tanto per aridità creativa, quanto per il business che soffoca il mondo della musica; solo il ritorno dei due ex-membri della band ha dato la carica e il giusto ottimismo per andare oltre ogni piccineria commerciale. Il cantante si è detto, perciò, ispirato nelle fasi di creazione del platter, con testi scritti da subito in forma cantabile e musica suonata rigorosamente in studio con la formazione al completo.
Hymns for the broken è un disco incentrato sul binomio “rage and melancholy”, un concept sui generis che narra di guerre e rivoluzioni (proprio nell’anno del centenario della Grande Guerra), senza connotazioni politiche, ma focalizzato sulla fatica del vivere umano, leitimotiv dell’intera discografia evergreyana. Efficace, in tal senso, l’artwork, su tinte scure (quasi manifesto propagandistico), meglio realizzato rispetto all’algida copertina di Glorious Collision. Il messaggio del full-length è, altresì, di rivelare quanto tutti noi siamo diversi da quello che crediamo di essere e che per vivere bisogna vincere la solitudine che ci schiaccia. Le parole di Englund valgono mille discorsi: «I think we’ve used our music as a forum for people who feel the same way we do about things, to make people feel less alone in some way». (“Penso che ci siamo serviti della nostra musica come un punto di riferimento per chi si pone come noi nei confronti della vita, per far sentire, in qualche modo, le persone meno sole”).
Lasciamo che sia la musica, ora, ad avverare l’auspicio del cantante svedese.
L’intro è oscuro e dipana un’atmosfera sonora lugubre. Dopo un cupo ruotare di pale d’elicottero, una voce tremante e un pianoforte rompono gl’indugi: “The Awakening” è un risveglio ancora denso di ombre («In the end you’ll never arrive»).
“King Of Errors” (di cui val la pena citare il video sull’Eriksberg im quel di Göteborg) attacca finalmente marziale e potente, con hi-hat in evidenza, riffing in tremolo sui tempi deboli e un grande pathos al microfono. Lo storico tastierista Rikard Zander conferisce ricercatezza e originalità al pezzo, che al terzo minuto rallenta per pochi attimi, per poi ripresentare un sound dalla produzione cristallina (merito di Jacob Hansen, già attivo con Volbeat, Amaranthe e Primal Fear), non privo di virtuosismi (si ascolti il solo di chitarra all’inizio del quarto minuto). Le plettrata di Henrik Danhage ci riporta ai tempi d’oro di In Search of Truth e il gruppo svedese pare come rinato: difficile immaginare un opener migliore.
Incipit cattivo quello di “A New Dawn”, con chitarre droppate che fanno molto anni Dieci (del XXI secolo ovviamente), drumwork spietato (Jonas Ekdahl non è Portnoy, ma al min. 1:06 regala una finezza notevole) e synth “complementari” nella loro carica eterea. Le ritmiche granitiche rievocano le trovate geniali di Recreation Day, ma il gruppo si presenta più maturo a dieci anni di distanza.
Avvio tastieristico per “Wake A Change”, con inserti d’elettronica, e apporto empatico vicino ai grandi Opeth che furono. Sul finire del secondo minuto si segnalano alcune linee vocali impegnative per Englund, che resta il mattatore e vera incarnazione degli Evergrey. Hanno, d’altra parte, qualcosa di magico i semplici accordi di pianoforte che accompagnano il brano: la forza degli scandinavi passa anche di qui.
“Archaic Rage” sfoggia un titolo magniloquente, che riassume il leitmotiv del platter: l’aggressività è una dimensione imprescindibile dell’essere umano (anche prima della cacciata dall’Eden?), Freud ha scoperto un’ovvietà. Non c’è però rabbia primeva nel brano, un mid-tempo che appesantisce il minutaggio del disco. Belli i sample prog. sul finire del brano, con tanto di lacrime profuse, ma tutto sa di già sentito.
Vera sorpresa del disco, “Barricades” attacca con un giro bluesy di chitarra, che dona spessore eclettico alla proposta monolitica degli svedesi. La voce affettata di Englund non è delle migliori, mentre, invece, l’assolo tra terzo e quarto minuto è geniale e proggish, tra i momenti imperdibili del full-length. Un ottimo pezzo che riscatta l’anodina “Archaic Rage”.
“Black Undertow” è una risacca nera che trascina in un gorgo depressivo e, infine, salva l’ascoltatore, mercé un ritornello ficcante. Ancora sample marziali, ritmiche dirette e aperture melodiche sorprendenti da parte del cantante. Al quarto minuto l’atmosfera si fa come d’aria rarefatta per alcuni attimi. Un brano dalla struttura semplice, ma decisamente catchy.
Dopo una nota terribilmente cupa di pianoforte, il thrash iniziale di “The Fire” si fa terremotante con il basso di Johan Niemann in prima linea. La canzone alterna cori di voci bianche a cadenze severe, oltre che armonie dal retrogusto oscuro e una doppia cassa volutamente limitata. Il cammino è già stato lungo, ma dopo otto tracce è la volta della titletrack, con inserti acustici. Il ritornello è ripetuto fin troppe volte e inficia la qualità del pezzo, per niente prog., che termina con una sorta di lacerto di musica sacra in fade out. Brano più corto (escluso l’intro) “Missing You” (chi ricorda il capolavoro omonimo degli Ark?) si regge sull’accoppiata magica Englund-Zander, i veterani del combo svedese. Una ballad da brivido, peccato solo così effimera.
Finale d’album con due pezzi dal minutaggio medio-alto. “The Grand Collapse” prevede palm mute a iosa e dei crescendo, che innescano, in pochi istanti, un rinnovato e poderoso furore metal di stampo thrash/heavy: le ritmiche sono sempre state marchio di fabbrica degli svedesi, eccone un’ulteriore prova. Dopo voci maschili e femminili dall’afflato demoniaco, a metà del quinto minuto si snoda una sezione strumentale cacofonica. “The Aftermath” è diretta conseguenza dei precedenti cinquanta minuti del platter, che ora volge al termine. L’intro è vellutato, il brano procede poi con inserti suggestivi e armonie ariose. Un degno epilogo (vicino per certi versi ad Awake dei Dream Theater) di un full-length che rilancia una band troppo sottovalutata.
In conclusione, un pregevole disco permeato da un’aria di mestizia (s)confortante, con tastiere eteree accostate a chitarre taglienti. Un “inno per chi è senza speranza”, che non sfugge dal pericolo di una qualche ripetitività, difetto compensato, però, dalla tanta ispirazione profusa e da un’ottima produzione. Era difficile pronosticare che gli Evergrey arrivassero in forma smagliante al nono studio album, ma così è stato. Chissà se anche il decimo full-length non mancherà di stupire, sono poche le band che arrivano alla doppia cifra senza sentire il peso degli anni.
Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)
Discutine sul forum, nel topic degli Evergrey