Recensione: Köld
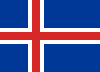
“Non so se vi è mai capitato di attraversare un brutto periodo, di cadere in depressione. Alcuni si riprendono, altri no. È successo ad un nostro amico, che qualche anno fa ha deciso di lasciarci. Questa canzone, che viene dall’album Köld, è per lui.”
Con queste parole Aðalbjörn Tryggvason, cantante dei Sólstafir, introdusse Necrologue al concerto dello scorso 22 maggio all’Akropolis. Incuriosito, un po’ spinto dalla mia affinità caratteriale, ma anche dal piglio grunge, “alla Nirvana” del pezzo, dopo il concerto bloccai Sæþór Maríus Sæþórsson, chitarrista, per chiedergli il titolo della canzone. In un inglese traballante e umido di birra mi disse: “Ah, non mi ricordo… è un titolo lungo che inizia per N… scusa, non sono in condizione, molto… ehehehe…”.
E fu così che, dopo aver adorato “Svartir Sándar” e “Ótta”, e dopo essere rimasto piuttosto indifferente a “Masterpiece of Bitterness”, mi decisi ed iniziai ad ascoltare Köld, opera terza degli islandesi. La canzone, scoprii, era “Necrologue” (alla faccia del titolo lungo), ma va sottolineato che l’ascolto di “Köld” sciolse molti dei miei dilemmi circa la band islandese.
Cos’era successo ai Sölstafir, che avevano esordito come uno dei tanti gruppi viking e si sono evoluti nel corso del tempo in una delle più originali realtà della scena metal? Come era avvenuta quell’evoluzione? Ecco, la risposta va probabilmente cercata in quella dedica. Tra il 2005 e il 2009, anni che coincidono alle uscite di “Masterpiece of Bitterness” e dell’album di cui oggi, i nostri hanno subito uno shock personale. Evidentemente, il trauma della perdita di un amico deve aver inciso sulle esistenze dei quattro.
Sicché, alla prova dell’ascolto, emerge che quella dei Sólstafir non è tanto un’evoluzione quanto una decisa svolta. “Köld” infatti non assomiglia al suo predecessore, al contrario presenta tutti i semi che sarebbero germogliati ed avrebbero costituito il sound della band che tutti conosciamo oggi.
Moltissimi elementi furono presi da grunge e indie, generi più propensi all’introspezione e più adatti ai testi che i nostri scrissero in quel periodo. Ancora, diverse forme e strutture vennero dal post rock, dando vita ad un sound desertico, scarno, fatto di chitarre distorte eppure scarne e brulle. I testi, tutti in inglese, title track esclusa, risultano molto intellegibili e, dal primo all’ultimo, pregni di un senso di perdita e di vuoto. Emblematico, infine, anche l’artwork.
A livello musicale, ugualmente, si sente il cambiamento fin dalla prima canzone, “78 days in the desert”: una cavalcata strumentale con accelerazioni pazzesche e scariche di adrenalina continue, ideale per guidare a 200 all’ora nel nulla della notte islandese. Inizio fulminante, segue un rallentamento, la title track ha infatti un incedere lento e un’impostazione drammatica, quasi depressa, ed è l’unica canzone in islandese del lotto.
E così è: “Köld”, un album grezzo e brutale, ma anche lento e intimista. Risulta impressionante che i Sölstafir abbiano cambiato, così di colpo e così radicalmente il loro sound. Risulta anche impressionante che l’album che ne è venuto fuori sia così compatto e immediato, con un sound omogeneo e e carico di personalità.
Ciò nonostante apre orecchie e cuore ad una gamma di emozioni così disparate… se il grigiore desertico, infatti, pervade tutto l’album, le sensazioni percepite variano da traccia a traccia. Dall’adrenalina di 78 Days in the Desert e Goddess of the Ages fino alla mesta introspezione di Necrologue e She destroys again, pezzo brullo ed effettivamente indie, dalla drammaticità ineluttabile della title track o di “Pale rider” (quanta sofferenza) fino alla cavalcata, ottimo singolo peraltro, di “Love is the Devil”. Ma in ultimo, bisogna ammetterlo, gran parte del pathos di questo disco è dato dall’interpretazione vocale – lancinante – offerta da Tryggvason, che proprio in questo album inizia a definire in modo chiaro il suo nuovo stile vocale, sofferente, drammatico, eppure spesso anche mesto e profondo. Ma, ormai è chiaro, la sofferenza viene dal profondo.
E così deve essere, perché un vera band sa reagire. Perché una grande band, sottoposta a pressioni emotive intense, origina album dalle grandi emozioni. Così fu per gli Anathema con “Judgement”, così dev’esser stato per i Sóstafir con questo album.
Un album che, teniamo a ripetere, chiudendo il cerchio, è la netta linea di demarcazione tra ciò che era stato e ciò che sarebbe stato per questi islansdesi. Così fu che i Sólstafir si trasformarono da una band viking e in una delle più originali realtà del metal attuale. Una band che di metal, a dirla tutta, non ha più molto, a meno che non li si intenda nel senso più avantgarde del termine. Ma non ha molto neppure dell’indie o del post rock. Semplicemente, è qualcosa che sta nel mezzo, con una grazia rara. Semplicemente, i Sólstafir da quel 2008 divennero i Sólstafir. Ed è per quello che, a otto anni di distanza, continuano a dominare l’universo.






