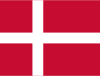Recensione: Maledictus Eris
Non c’è nulla di più esilarante che inserire un disco nell’impianto stereo e sentirsi immediatamente a casa. Sono sufficienti le quattro chiacchiere concitate tra le battute d’apertura della caotica intro di Maledictus Eris per ritrovarsi con un sorriso tra i baffi e la consapevolezza che i prossimi 40 minuti saranno di puro, fottuto folk-death brutale senza ricami e ammennicoli. Perché gli Svartsot non sono la solita band di ragazzini/ragazzine tra dolmen e caprette che fanno ciao, con troppo amore per gli arzigogolii celtici e poca voglia di sporcarsi mani e piedi e farsi una bella bevuta nella bettola più rivoltante della Danimarca.
Perché gli Svartsot sono nati come un gruppo di vecchi balordi, cavalcando l’onda del vecchio folk metal senza calcarne i passi piu’ epici di Vintersorg o più balordi di Finntroll o Korpiklaani, ma al contrario creando un proprio folk metal iniettato di growl urticante, riff brutali e ritmi da ultima festa prima della fine del mondo, tirata fino al mattino nelle profondità di una nave pirata o in un pub fetido e umido, dove a cantare sono boccali di legno frammisti a bohdran martellanti, flauti e mandolini al galoppo più furioso.
Klaus Gnudtzmann in particolare fu un gran propugnatore del “fuck-ye-all suoniamo come ci pare”-metal, ma dopo la lite del 2008 e lo smembramento quasi totale della line-up, il timore di perdere lo spirito pestifero degli Svartsot aveva aggrottato le fronti e reso torvo lo sguardo dei folk-metaller di vecchia data.
Dobbiamo ringraziare l’unico superstite della grande diaspora, Cris Frederiksen, se i neo-Svartsot non solo si sono confermati degni successori della band originaria, ma sono diventati – se possibile – ancora piu’ violenti, volgari e diretti dei precedenti.
Maledictus Eris consacra la tendenza del folk scando-baltico a raccontare gli aspetti più brutali della storia e della mitologia come morte, guerra, fame, carestie e pestilenze tramite una fitta rete di canzoni che contrappongono l’incedere apparentemente allegro e gioviale a testi di una tragicità semplice e al tempo stesso glaciale, un ossimoro artistico con pochi pari nel mondo della musica. L’intrigante espediente narrativo/musicale già aveva colpito duro ai tempi di Visor om Slutet dei Finntroll, la cui canzone-trademark, “Försvinn du som Lyser”, celava dietro un’apparente gioia e tripudio una sequela di tre strofe disperate e brutalmente amare.
Come gli estoni Metsatöll continuano da 12 anni a nascondere tra le atmosfere apparentemente gioviali dei loro album uno spirito bellico a dir poco apocalittico, così gli Svartsot celebrano la tragedia paneuropea della peste nera nell’unico modo in cui si può contrastare l’orrore strisciante di una piaga che marcisce ogni angolo del paese in un raggio di migliaia di chilometri: stappando una l’ultima birra maledetta e cantando il trionfo dei corvi che banchettano sui cadaveri putrescenti di migliaia di danesi in un’alba incolore del 1348.
Tra i brontolii dell’eccellente Thor Bagel si percepisce la pestilenza che avanza in “Farsot Kom” e la brutale danza dei morti di “Dødedansen”: riff puri e semplici, melodie catchy e trascinanti costantemente immerse in un tappeto di sonorità death-brutal, come improvvisati nuovi Cannibal Corpse dell’epoca vichinga.
Certo, come impone il sacro libro del buon folk metal, al brutal cavernoso si alternano striduli passaggi che ammiccano al black-folk, nulla che non sia già stato esplorato, per esempio, dagli Amon Amarth di Once Sent from the Golden Hall. Il mirino è sempre e comunque puntato sulla melodia e diverse tracce certificano la maestria di questi vecchi danesi nel replicare e far proprio il classico stile del folk metal: “Kunsten At Dø” e “Den Nidske Gud” renderanno felici tutti i folkster che vogliono respirare un po’ di old school alla Einherjer e alla Thyrfing, variazioni sul tema che dipingono un album semplice senza essere semplicistico e complesso senza essere complicato. Unendo armoniosamente furia e allegria, gli Svartsot proseguono per la strada più consona a chi ha fin troppi inverni sulle spalle per continuare a danzare attorno all’albero della cuccagna. Eppure, agli ascoltatori occasionali risulterà estremamente difficile immergersi in uno scenario dove tutto è pianto e stridore di denti mentre gli strumenti continuano indisturbati a compiere evoluzioni da sagra di paese, ma è proprio questa la meraviglia di una musica dalle molteplici chiavi di lettura. Non c’è nulla di più struggente dell’ultima risata di un moribondo o di un quartetto d’archi che suona con dolcezza un “Nearer, my God, to thee” mentre 1500 disperati esalano l’ultimo respiro tra i resti gorgoglianti del Titanic che affonda con un iceberg piantato sul fianco.
Album solido, potente e visionario ma dannatamente di mestiere, che di certo non reinventa la ruota ma che fa girare dannatamente bene quella già costruita da un ventennio di folk metal europeo. Un deciso passo in avanti rispetto al rigore schematico di Mulmets Viser e una dichiarazione di intenti che lascia ben presagire per il futuro: altri dieci album come questo sarebbero una garanzia di anni di headbanging… fino alla comparsa dei primi sintomi di peste bubbonica.
Daniele “Fenrir” Balestrieri
Discutine sul forum nel topic apposito!
TRACKLIST:
1. Staden…
2. Gud giv det varer ved!
3. Dødedansen
4. Farsoten kom
5. Holdt ned af en Tjørn
6. Den forgængelige Tro
7. Om jeg lever kveg
8. Kunsten at dø
9. Den nidske Gud
10. Spigrene
11. Og Landet ligger så øde hen