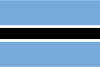Recensione: Okavangu Tulupulu
Che bomba! Non mi sarei mai aspettato di recensire un demo di un gruppo del Botswana (!) ma ancora meno mi sarei aspettato di trovarmi davanti a un album di vero, tenace heavy metal, ricco di idee e spunti originali. Perché questo sono gli uKhahlamba: una metal band coraggiosa e matura, in grado di formulare una proposta innovatrice e personale nonostante sia nata in una cultura musicalmente arretrata per quanto riguarda la tradizione del nostro genere preferito (senza offesa per gli altri). Purtroppo il promo in nostro possesso non contiene note biografiche, quindi passiamo direttamente alla musica.
Difficile se non impossibile definire il genere suonato dalla band di Gaborone, visto che varia moltissimo da traccia a traccia e spesso cambia più volte anche nel corso del medesimo brano. Tutti i testi sono in lingua rigorosamente tswana, a testimoniare il grande attaccamento alle proprie radici di questi ragazzi. Per fortuna sul retro della musicassetta (evidentemente la band non aveva i fondi per incidere un CD) sono riportati almeno i titoli in inglese, altrimenti non si caperebbe una benemerita fava. Ma la più grande peculiarità del gruppo è quella di schierare nella propria formazione ben due batteristi (anche se uno dei due in effetti si occupa perlopiù delle percussioni), entrambi preparatissimi tecnicamente e pronti a mettere alla prova i compagni tenendo tempi diversi durante le stesse canzoni.
Il lato A si apre con l’intro Dumela (“Intro”, appunto), una overture sinfonica che riporta alla memoria i fasti di Ira Tenax dall’esordio dei Rhapsody. All’apice del crescendo si aggancia la title-track Okavangu Tulupulu (“Okavangu’s Fury”), una cavalcata che parte veloce con un riffing maideniano tiratissimo e finisce velocissima, con sfuriate ritmiche al limite del blast-beat e vocals graffianti che ricordano il miglior Glenn Benton. La varietà di stili esibita dalla band potrebbe sorprendere, ma tenetevi forte perché non avete ancora sentito nulla. La successiva Mfekane (“Bloody Massacre In The Name Of The Ancient Gods”) insiste sul lato estremo e sperimentale degli uKhahlamba, proponendo un ibrido di doom e grindcore che riporta alla mente il primo demo degli austriaci Visceral Evisceration, con un ritornello melodico che è un mezzo plagio di The Final Cuntdown. Ancora sperimentazione estrema con GA.KE.BATLE (“DO.NOT.WANT”), anche se questa volta lo stile sembra propendere con decisione per un black metal minimale ma precisissimo, in cui spiccano le ritmiche tribali affiancate da un riffing marcio e mefistofelico. Si torna su coordinate più classiche col mid-tempo Shaka A O Ya Ko O Flanku! (“Shaka Fuck You!”), forse il vero capolavoro dell’album. Il provocatorio titolo, ripetuto a oltranza nel refrain, si riferisce probabilmente alla figura del famoso condottiero Zulu, responsabile di efferati massacri fra le popolazioni locali all’inizio del diciannovesimo secolo. La traccia si apre con un riffing epico e cadenzato che porta a un coro di quelli che si stampano subito nella mente, tanto da spingervi a cantarlo anche se non capite le parole. Al centro del brano è collocata la sub-track Basuto Ke Kulu (“Basuto’s Revenge”), in pratica una lunga digressione strumentale in cui si mescolano influenze folk sudafricane e virtuosismi in stile Dream Theater: il pezzo è forse un po’ prolisso ed è l’unico nella tracklist che personalmente avrei tolto. La chiusura del lato A spetta all’outro Sala Sentle (manco a farlo apposta, “Outro”), una breve strumentale dominata da un synth zanzaroso e da uno strano strumento a fiato (credo) di cui non conosco il nome. Prima della fine c’è ancora tempo per una sorpresa: gli uKhahlamba concedono un inaspettato colpo di coda con la ghost track Ke A Leboga (l’unica non tradotta), un’estemporanea scorribanda smooth jazz della durata di pochi secondi.
Il lato B, decisamente più breve, contiene tre cover. La qualità di registrazione molto bassa fa pensare che si tratti di materiale tratto dalle primissime incisioni della band. Si (ri)parte con il classico Pleasure Slave dei Manowar, qui riportato con un titolo sbagliato (“Woman Be My Slave”), ma arricchito dalla solita doppia batteria e da campionamenti (spero) di grida di terrore femminili. Fa seguito una versione velocizzata di Relapse Refusing U.N. Weapons Inspectors: due secondi e mezzo di puro odio made in Agoraphobic Nosebleed che confermano il notevole eclettismo della band. Il gran finale è dedicato all’epica Fatshe Leno La Rona (“Blessed Be This Noble Land”), che altro non è se non l’inno nazionale del Botswana, qui riarrangiato in chiave rock.
C’è chi dice che il metal sia finito, c’è chi dice che l’originalità sia morta, c’è chi dice che non ci sia più nulla di nuovo da dire. Io non sono d’accordo. Non importa quanto a lungo dovremo cercare, non importa se dovremo spingerci fino all’oscurità impentrabile dell’Africa Nera: finché vivranno band audaci e oltranziste come gli uKhahlamba possiamo stare certi che il nostro genere preferito non morirà mai. Speriamo solo che una label li noti e si decida a scritturarli. Emo e poser stiano alla larga, questa è roba per veri metallers.
Angelo Angelini
SideA:
1. Dumela (0:42)
2. Okuvangu Tulupulu (3:13)
3. Mfekane (3:21)
4. GA.KE.BATLE (5:55)
5. Shaka A O Ya Ko O Flanku! [incl. Basuto Ke Kulu] (7:47)
6. Sala Sentle (0:33)
– Ke A Leboga (ghost track, 0:07)
Side B:
1. Woman Be My Slave (Manowar cover, 5:38)
2. Relapse Refusing U.N. Weapons Inspectors (Agoraphobic Nosebleed cover, 0:02)
3. Fatshe Leno La Rona (1:18)