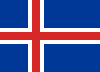Recensione: Opus: Decay [EP]
Islanda.
Dal terrificante contrasto fra la lava dei giganteschi vulcani e il ghiaccio degli estesissimi nevai perenni, si sprigionano chilometriche colonne di vapore ustionante, che disegnano superbamente e definitivamente, all’isola antartica, le vestigia dell’inferno terrestre.
Uno scenario alla fine grigio, buio, oscuro, dal quale emergono quattro figuri ancora più tetri. Alfreð Þór (voce e basso), Óskar Þór (chitarra, voc), Kristinn Rafn (chitarra) e Þórir Hólm (batteria). Cioè, gli Abominor. Nati a Reykjavík nel 2008 e autori, sin’ora, di un demo (“Source Of Chaos”, 2010), e di questo dischetto, “Opus: Decay”.
“Opus: Decay” che è composto da due sole song, “474” e “Opus: Decay”, per una durata di ventun minuti circa. Non molti, certo, ma più che sufficienti per avere un’idea precisa del black metal proposto dai Nostri, che pare aver assorbito in sé tutte le caratteristiche della terra natia per una restituzione timbrica dalla profondità abissale, probabilmente centrata in qualcuna delle camere di carico lavico del Grímsvötn o del tremendo Hvannadalshnjúkur.
Profondità, sì, ma anche furibonda velocità. Gli Abominor partono quasi in sordina, con l’incipit ambient di “474” ma, senza nemmeno aspettare troppo, si gettano in una violentissima cavalcata nel Regno delle Tenebre alla velocità della luce; con le schioccanti scudisciate dei vertiginosi blast-beats a lacerare le carni, ad approfondire la solitudine e il dolore. In certi momenti, anche, emergono dagli orridi vigorose folate di lisergico doom, marchiato da un insopportabile odore di zolfo.
Il dinamismo complessivo della matrice musicale di “Opus: Decay” ha un qualcosa di unico, maligno e coinvolgente che non è dato trovare altrove, almeno a un sommario inventario mentale. Le due suite che lo compongono, grazie a questo movimento caoticamente sussultorio, non danno adito ad alcun appiglio per la noia. L’accordatura fra musica e natura è talmente riuscita che l’armonia regna sovrana, benché le condizioni ambientali siano improponibili per la vita umana e la melodia assente.
Condannando eternamente, così, l’incauto viandante/ascoltatore a una misantropica esistenza destinata a durare eoni e eoni; perduta nello spazio e nel tempo.
Daniele D’Adamo

![Opus: Decay [EP]](/data/thumbs/7/5/4/7ac639299ee99578a47c8d788077d1d8c.jpg)