Recensione: Parasomnia

Per analizzare il nuovo album dei Dream Theater Truemetal propone una doppia recensione. A chi volesse maggiori informazioni sul concept consigliamo la seconda review, che si sofferma maggiormente sulle liriche delle canzoni. Il voto finale è la media delle due valutazioni dei recensori. Buona lettura a tutti!
Recensione di Roberto Gelmi
Finalmente possiamo ascoltare Parasomnia, il nuovo e sedicesimo full-length dei Dream Theater, disco di ritorno alla line-up storica con Mike Portnoy alla batteria. Ne sono successe di cose nei tredici anni (2010-2023) in cui ha preso il suo posto Mangini e Mike ha tentato altre strade (qui trovate un approfondimento), cerchiamo di fare in breve il punto sulla situazione della storica band di Long Island.
Portnoy ha lasciato la band dopo l’uscita di Black Clouds and Silver Linings, album che riscosse buon successo di pubblico (è il disco che contiene l’ottima “The Count of Tuscany”, ma anche un bonus disk con cover di band come Queen e Iron Maiden). La band ha poi continuato a comporre musica concludendo il quintetto di album per Roadrunner Records, iniziato con Systematic Chaos nel 2007 e terminato con il concept album The Astonishing nel 2016. Di lì in poi è iniziata l’era InsideOut che ha visto la nascita di due dischi più che discreti, come Distance Over Time e A View from the Top of the World, uscito nel 2021.
Il livello di visibilità della band è rimasto sempre su buoni livelli: hanno vinto un Grammy Award per l’opener “The alien”; John Petrucci resta uno shredder di rilievo, figura di culto della chitarra elettrica e ha recentemente festeggiato il decimo anniversario della signature Majesty; Jordan Rudess porta avanti la tradizione dei suoi dischi solisti e ha riscoperto il suo interesse anche per la sei corde. John Myung sembra affaticato dagli anni che passano, ma non molla un colpo; per quanto James LaBrie, invece, continua a valere quanto detto a più riprese, le sue prestazioni sono quelle che sono (basti ascoltare il recente Rock in Rio) ma continua a credere nel progetto musicale di cui fa parte.
Ad alzare il livello di hype per l’uscita di Parasomnia è la figura di Portnoy, il ritorno del grande batterista che ha contribuito, con la sua passione per la musica e la sua maniacalità, al successo del marchio DT. È stato bello vederlo di nuovo on stage per il tour che quest’anno festeggerà i 40 anni della band (ab ovo nota come Majesty) e ritrovarlo a fare promozione rispolverando anche vecchi cavalli di battaglia.
Come rivelato in alcune interviste la decisione della reunion è stata dettata dal buon senso. Riuscire a proporre uno show tecnicamente impegnativo a quasi sessant’anni non è da tutti, se non fossero tornati insieme probabilmente non avrebbero potuto farlo tra un decennio per mere questioni di tenuta fisica. Lo dovevano ai fan, ai loro concerti compaiono infatti almeno tre generazioni di suppoter, che oggi vogliono ascoltare il nuovo album in attesa di rivedere i propri eroi nella seconda parte del tour mondiale, con incluse tappe in Italia da non perdere.
***
Fatta questa premessa veniamo a Parasomnia. È un concept album solo in senso lato, i pezzi sono legati al tema del linguaggio onirico e all’angoscia che si manifesta nella dimensione notturna (aspetto già trattato nei testi dei DT, insieme a quello della follia). Compaiono suoni di sveglie, pendole, carillon, note di organo, sussurri e sospiri: le atmosfere sono oscure e il lato metal non manca. La copertina di Hugh Syme, in tal senso, rende l’idea di “mistero tetro” proponendo una versione dark della camera con il soffitto che confina col cielo di Images and words.
Veniamo ora alla scaletta del nuovo album.
L’intro strumentale “In the arms of Morpheus“, con un lungo incipit cinematografico e alcuni echi stile Symphony X, ci proietta in una dimensione oscura ma al contempo progressive. Bene, insomma, ma non benissimo come overture, perché tutto finisce troppo presto, ma fortunatamente non come in “False Awakening Suite”. Purtroppo i nostri non azzeccano una vera strumentale dai tempi di “Raw Dog”, era il 2010. Ritroviamo comunque sia il Portnoy potente di “A Nightmare to remember”, con doppia cassa in bella vista, meno perizia tecnica rispetto a Mangini, ma più cuore.
Il primo singolo, “Night Terror”, necessita di diversi ascolti per essere apprezzato, è una song tipicamente theateriana, che vuole valorizzare il drumming di Portnoy e riproporre la sintesi del progressive concepito e affinato negli anni dalla band statunitense. Il cambio di ritmo repentino a metà brano potrebbe far storcere il naso, ma la sezione strumentale risulta petrucciana come non mai. In definitiva un bell’opener, non sui livelli della velocissima “The enemy inside” o l’intricata “The alien”, ma comunque dignitoso. In sede live non ha sfigurato in setlist.
“A broken man” è il secondo singolo (con liriche di LaBrie), tratta dei problemi mentali di un reduce dalla guerra, tema meritorio, ma il brano in sé è stato criticato per via dell’intro troppo pesante e dell’assolo anodino di Rudess. In realtà è un pezzo discreto per gli standard dei DT attuali, con buona ricerca melodica, Petrucci che si concede qualche sortita blues e proprio l’intro “opethiano” è il suo valore aggiunto. Sorvoliamo invece sul video generato con AI.
“Dead Asleep” è il secondo brano più lungo in scaletta. Il ritornello pur non eccezionale si memorizza subito; non mancano la potenza delle ritmiche heavy, gli octoban di Portnoy e le tastiere prog di Rudess insieme alle note di pianoforte. Forse è tra i momenti meno incisivi dell’album, ma la strada verso la suite finale è ancora lunga, inutile rammaricarsi. Consoliamoci alzando al massimo il volume all’inizio del pezzo per carpire gli spezzoni audio in cui si sente parlare in italiano.
I testi di “Midnight Messiah” sono di Portnoy e non a caso parliamo di uno dei pezzi thrash più veloci e aggressivi composti da Petrucci & Co; supera sia “Constant Motion”, sia la più recente “Behind the veil” in termini di potenza e affilatezza. Un brano di questo tipo in un disco di settanta minuti ci può stare, non è un problema nemmeno il fatto che i testi indulgano in un po’ di sano autocitazionismo (non siamo, per intenderci, sui livelli degli Helloween di “Pumpkins united”). Proposta in questi giorni dal vivo inizia già a fare alzare il livello di adrenalina dei fan.
Dopo il piacevole intermezzo “Are we dreaming?”, “Bend the clock” è tra le sorprese più apprezzabili di Parasomnia. Nel booklet interno è curioso vedere un orologio liquido, che si riferisce ai testi. Si tratta di una ballad dignitosa con testo di LaBrie e un assolo finale di Petrucci in stato di grazia. A differenza del precedente studio album, la voglia dei DT di proporre un brano che punta sull’emotività riesce nell’intento di regalare un instant classic. Sicuramente è tra i pezzi di Parasomnia che verranno maggiormente riascoltati.
E siamo infine alla suite che tutti aspettavano. I newyorchesi difficilmente deludono nei pezzi composti da più movimenti, anche nell’era Mangini ricordiamo grandi composizioni come “Illumination Theory”. Vediamo se siamo sullo stesso livello, oppure no. L’inizio di “The shadow man incident” accosta sonorità che richiamano “A view from the top of the world” e gli accordi saturi di “Overture 1928”, ma la canzone complessivamente risulta un ibrido delle sonorità contenute in “Octavarium” e “In the presence of enemies”. I primi cinque minuti sono un viaggio strumentale da ascoltare più volte per attraversare le varie atmosfere proposte e godersi tutte le sfumature. Dopo una sezione non priva di qualche concessione psichedelica torna l’headbanging all’ottavo minuto, così le affinità sonore con i già citati Symphony X. Portnoy martella costantemente la sua Tama, sfoderando tutti i cliché del caso; a stupire però è il pianoforte di Rudess e gli unisoni con Petrucci. Jordan si diverte con i tasti d’avorio (anche in una sua inedita versione latineggiante), Petrucci a momenti replica il virtuosismo di “The Ytse Jam” e sciorina un numero di note impressionante (ormai il confine tra umano e disumano quando parliamo di John è stato superato). La suite raggiunge vette strumentali notevoli, l’alchimia della band è tornata quella di una volta; se al tutto aggiungiamo rimandi a Lovecraft nei testi, stiamo parlando di un finale pirotecnico per un disco che si chiude senza ombra di cedimenti.
Il lungo viaggio onirico di Parasomnia è al termine. Difficile dire su due piedi quale sarà il valore di questo album di fronte alla prova del tempo.
Come le formiche che compaiono furtive nell’artwork dei singoli, i Dream Theater riprendono l’alacre pomposità di Systematic caos e Black clouds and silver linings, dando alla luce quello che, dal punto di vista cromatico, potremmo considerare il loro terzo black album dopo Awake e Train of Thought. Il disco in sé rilancia il trademark dei Dream Theater storici e riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il decimo full-length. Non ha senso chiedere chissà quali novità al gruppo newyorchese, ormai sappiamo cosa aspettarci da loro ed è giusto valutarli in base a quanto restano fedeli al loro sound.
Per quanto riguarda Portnoy, va ricordato che questa volta non è anche coproduttore insieme a Petrucci, ma il suo tocco si sente anche per quanto riguarda l’impostazione dei brani, che tornano alla tipica quadratura ritmica pre-Mangini. Il mixing di Andy Sneap è accettabile, si poteva fare meglio nei suoni della batteria (specie il rullante) e per il basso, ma sono dettagli.
Godetevi, dunque, la deluxe edition con tanto di benda per dormire, acchiappasogni e mega booklet da collezione se avete qualche risparmio da parte. Puntiamo, inoltre, a goderci il prossimo live dvd celebrativo del quarantennale, magari con “The Best of times” finalmente proposta dal vivo. Chissà se questa line-up arriverà anche al traguardo delle nozze d’oro, ormai quella del Teatro del Sogno è Storia.
Voto: 79/100
Recensione di Paolo Fagioli d’Antona
Parasomnia si rivela alle nostre orecchie come un vero e proprio ritorno a casa per i titani del progressive metal statunitensi, non solo per il tanto atteso ritorno all’ovile di Mike Portnoy dai tempi di Black Clouds & Silver Linings del 2009, ma soprattutto per un disco che dissemina nostalgia a palate, a partire dai numerosi “easter eggs” presenti nelle liriche, ad alcuni effetti sonori (ne parleremo…), passando per la copertina, per non parlare della musica in sé.
Parasomnia rappresenta tanto altro oltre al fattore “nostalgia”, rivelandosi allo stesso tempo un disco ambizioso, dove l’idea centrale del secondo disco di Six Degrees Of Inner Turbulence del 2002, viene ripreso dandogli un “twist” più dark e sinistro. Se nel suddetto secondo disco ogni canzone parlava di un differente disturbo della psiche, qui in Parasomnia ogni brano ruota attorno a uno specifico disturbo del sonno – si va dalla paralisi notturna, al sonnambulismo, agli incubi notturni, agli effetti devastanti del PTSD sul sonno – Parasomnia non è quindi un vero e proprio concept album, quanto un album a tema, dove la copertina è un perfetto esempio di come i Dream Theater in questo album ci vogliono far immergere in quel sentimento di nostalgia, ma allo stesso tempo creare un mondo nuovo, più oscuro ed enigmatico, dove sviscerare tutto il loro potenziale espressivo.

E parlando della copertina, non può non venire in mente un immediato parallelismo con quella di Images & Words. In questo caso appare una donna in camicia da notte (la versione adulta della bambina apparsa sulla copertina dello stesso Images & Words di trentatré anni fa?), con una stanza e un letto che rimandano senz’altro a quella copertina storica, dandogli però una deriva dark e inquietante, quasi come se questa rappresentasse un flashforward in un mondo parallelo infestato da demoni del sonno ed atmosfere spettrali.
Musicalmente, a nostro avviso, Parasomnia è un disco meno cervellotico e ipertecnico rispetto al precedente A View From The Top Of The World. La band ha sicuramente dato un leggero freno a quell’aspetto del sound riuscendo a concentrarsi di più sull’atmosfera e sulla “cinematicità” dell’opera. L’apporto di Jordan Rudess in particolare, lo troviamo molto significativo nell’economia del sound del platter, per un musicista meno immedesimato nei suoi classici virtuosismi di tastiera, ma al contrario, molto importante nel rendere questo disco cinematico, grandioso, ma allo stesso tempo oscuro ed enigmatico, per delle atmosfere che a tratti ci riportano indietro a dischi come Systematic Chaos nei suoi momenti più plumbei, ma anche a Black Coulds & Silver Linings nelle sue aperture più solenni. La produzione affidata a John Petrucci è ottima, probabilmente una delle migliori di sempre dei Dream Theater, con un sound corposo e allo stesso tempo cristallino e un mixaggio affidato ad Andy Sneap che poteva senz’altro valorizzare meglio il basso di John Myung, troppo spesso sepolto nel mix e che riesce a far capolino in maniera preponderante in pochi momenti del disco. Da questo punto di vista senz’altro il precedente A View From The Top Of The World valorizzava maggiormente il talento di un musicista straordinario come il bassista dei Dream Theater.
Il disco si apre in maniera fantastica con “In The Arms Of Morpheus” (Morfeo è ovviamente il dio dei sogni nella mitologia greca) che ci immerge subito nel concept attraverso dei rumori di strada, i passi di una persona e delle atmosfere misteriose e da sogno (o forse meglio dire da incubo?). Il ticchettio di un orologio ed un delicato arpeggio di Petrucci sorreggono dei suoni ad arco molto “creepy” (direi quasi alla Danny Elfman), prima che delle sezioni di tastiera alquanto minacciose facciano salire la tensione, in un crescendo che esplode nel suono di una sveglia che spezza in maniera estremamente brusca lo stato di torpore in cui ci si trova. Ed è proprio in quel momento che la band entra in gioco. Un’introduzione davvero d’effetto, su cui Portnoy ricama uno dopo l’altro dei fill di batteria che sono ormai iconici e riconoscibilissimi, mentre i riff granitici di Petrucci donano quella componente muscolare al sound. Rudess si fa subito protagonista con dei suoni di tastiera prima ariosi e cinematici, per poi esplodere in un assolo di Moog irrefrenabile. Ma è Petrucci che subito dopo ci inonda con uno dei suoi classici assoli melodici, pregni di espressività e di pathos che ci riportano indietro ad un disco come Scenes From A Memory, per una traccia che offre davvero una rappresentazione e una visione ben definita di quello che sarà a livello sonoro questo disco e che allo stesso tempo introduce alcuni dei temi musicali portanti del platter che verranno sviluppati e ripresi nei seguenti brani. Insomma, una intro strumentale davvero di ottima fattura.

“Night Terror”, la conosciamo già tutti, abbiamo avuto modo di sentirla live e rimane per quanto ci riguarda uno degli episodi migliori del lavoro, dotato di uno dei groove di chitarra più efficaci del disco per un brano che si addentra ancora di più nel “vibe” dark e spettrale dell’album, rappresentando molto bene gli incubi notturni di cui parla la canzone. Anche il buon LaBrie in questo brano convince, portando a casa uno dei ritornelli migliori del lotto, per un frontman che in tutte le sue limitazioni odierne riesce a essere quantomeno altalenante nella sua prestazione nel corso del disco, ma quasi mai lo affossa. Se una volta James era la ciliegina sulla torta di una band stratosferica, oggi come oggi si ha l’impressione che le sue linee vocali vengano costruite ad hoc, di modo da rientrare nella sua “comfort zone”, anche se va puntualizzato come James riesca comunque a proporre un approccio abbastanza vario nel suo cantato, senza però sforzare mai eccessivamente sulle sue corde vocali con parti troppo abrasive (insomma niente scream forsennati alla The Glass Prison per intenderci).
Un James che si trova molto a suo agio nei momenti più morbidi come la bella “Bend The Clock”, l’unica vera ballad o semi-ballad del disco, per un titolo molto d’impatto che rappresenta in toto il messaggio della canzone che narra di una persona afflitta da conflitti o incubi notturni che si manifestano sempre a una precisa ora della notte. Il desiderio quindi di “distorcere” o “piegare l’orologio” (più che l’orologio, il tempo), sta nel poter fare in modo che lui stesso possa eludere il corso temporale degli eventi in quei terribili momenti cuciti attorno alla mezzanotte (“no more paralyzing dreams or midnight screams always haunting me”). Veramente emozionante e ben trasposto in musica quel “sinking further every day” scandito dallo stesso LaBrie e sulla parola “sinking” Petrucci parte con un assolo che mima proprio “l’affondamento” di qualcosa, dando quella sensazione di essere sovrastato emotivamente dal peso dei propri incubi. È lo stesso Petrucci che chiude il pezzo con un assolo in fade-out di gran livello, per un altro brano da novanta del disco.
Dove la qualità dell’album scende è nella parte centrale. “A Broken Man” è un brano interessante, dove il tema del PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) che affligge tanti veterani al ritorno dai loro conflitti, viene esplorato nuovamente come era già stato fatto in War Inside My Head (Six Degrees) e in The Enemy Inside. Qui, però, il contesto è quello degli incubi notturni e come i ricordi e i traumi legati alla guerra riaffiorino nel momento di coricarsi, con, tra l’altro, l’uso di voci e suoni nel mix della canzone che riportano in vita i traumi di una vita passata. Musicalmente il brano è roccioso e piuttosto spinto, con delle aperture da parte di Rudess e le suddette voci parlate che ci riportano nel mezzo del conflitto interiore di quest’uomo. LaBrie entra prepotentemente nel mix stavolta con la sua vocalità più nasale e distorta che non ci ha mai fatto impazzire e che affossa un pochino quella sezione particolare del brano. Sono proprio le linee vocali di questo pezzo che ci convincono meno, peccato perché strumentalmente questo brano non è affatto male, in particolare la sezione solista del pezzo.
La composizione meno riuscita dell’album rimane la successiva “Dead Asleep”, che ancora una volta affronta una tematica legata al sonno molto interessante, ma allo stesso tempo inquietante, tratta tra l’altro da una storia vera, ossia quella di un uomo che soffriva di sonnambulismo e che nel sonno ha ucciso la moglie. Dietro le liriche c’è tutto l’aspetto della colpa e del processo che ne seguì, chiedendosi quanto un uomo protagonista di un delitto del genere sia effettivamente colpevole quando il gesto che ha compiuto non è stato eseguito di proposito, ma nel sonno. “Dead Asleep” ci mostra James LaBrie intento a raccontare questa storia, quasi come ci stesse narrando l’evolversi di un giallo, trasportandoci per mano in maniera estremamente letterale attraverso le vicissitudini di quest’uomo. Nulla di metaforico, ma una storia raccontata in maniera lineare e passionale un po’ come accadeva con “A Nightmare To Remember” o “The Count Of Tuscany”. Ancora una volta le linee vocali, specialmente quelle del ritornello non ci convincono granché ma il pezzo rimane comunque interessante per via del gran lavoro degli altri quattro musicisti. C’è da segnalare una intricata sezione solista di Jordan Rudess, sorretta da un riffing granitico e ripetitivo di Petrucci e ancora una volta non mancano le aperture cinematiche e oscure dello stesso Rudess che ci hanno davvero riportato alla mente gli Avenged Sevenfold di Nightmare. Da notare alla fine dell’assolo di Jordan, una magnifica sezione che dà un senso di “spirale discendente”, quasi a rappresentare una vorticosa caduta nell’oblio degli incubi della mente umana. Insomma, un brano con i suoi punti forti senz’altro, ma che a nostro avviso si protrae per troppo tempo nei suoi undici minuti di durata.

“Midnight Messiah” è un pezzo senz’altro più diretto, però allo stesso tempo oscuro, che non fa gridare al miracolo, ma che nell’economia del disco è ben posizionato, dando quel senso di abrasività specialmente nel ritornello diretto e “in your face”. Ancora una volta gran groove chitarristico di Petrucci.
Ma il meglio arriva con la conclusiva suite da diciannove minuti “The Shadow Man Incident”, che si apre con quel suo sound quasi a “effetto carillon”, prima che il brano prenda forma ancora una volta grazie al groove sorretto da Petrucci. Il brano ci mette qualche minuto a prender quota con la sua marcia militaristica sorretta dal tappeto di orchestrazioni sinfoniche di Rudess che tanto ci ricordano un brano come “Overture 1928” (ma anche la precedente suite della band “A View From The Top Of The World”). Eppure quando il brano esplode lo fa alla grande. Le minacciose voci narrate – che ricordano molto, come tono, la narrazione presente nell’ultimo platter degli Opeth, The Last Will And Testament –, coadiuvate da un’improvvisa e intensa sezione sorretta dalla band stessa, dà il via a uno dei segmenti musicali più entusiasmanti del disco, dove sul finale Rudess e Petrucci si alternano in un botta e risposta di assoli di gran livello. Una vera e propria epopea virtuosa da parte dei due che sembra non voler finire mai, ma che allo stesso tempo ci lascia con il fiato sospeso, in totale ammirazione d’innanzi a ogni passaggio suonato. Jordan ripropone il suo sound di tastiera più classico (quello più vicino al suono di un pianoforte), per alcune sezioni che si ricollegano ai fasti di “The Dance Of Eternity”, almeno puramente a livello di stile. Da segnalare anche il ritornello di questo brano che per quanto ci riguarda è probabilmente il meglio riuscito dell’album, per un LaBrie che emoziona e che chiude il platter con un gran acuto e una sentita prestazione vocale, prima che Petrucci riabbracci nuovamente la sette corde per un assolo melodico e di gran gusto. Negli ultimi secondi della canzone, una sveglia suona e una voce ripete: “Wake up!”. L’incubo si spezza, l’ascoltatore viene risvegliato dall’aura in cui è stato avvolto in questo lungo viaggio sonoro, ma soprattutto questo finale ha un’eco che rimanda ancora una volta a Scenes From A Memory, con quella frase improvvisa che chiude il disco regalandoci le stesse sensazioni dell’ iconica -“Open Your Eyes, Nicholas!”- che a sua volta a sorpresa chiudeva l’iconico concept album dei Dream Theater del 1999.
In conclusione Parasomnia è un disco contrastante, fatto di nostalgia e quel senso di ritorno al passato che i fan dei Dream Theater stavano aspettando, ma che allo stesso modo esplora nuove dimensioni e nuove strade avvincenti per un disco tematico, dove è evidente che la band non si è limitata a eseguire “il compitino”, ma ha creato un avvincente mondo parallelo, sinistro, cupo e cinematico. L’atmosfera è importante quanto il virtuosismo e le sezioni soliste; l’ascoltatore viene immerso in un viaggio che grazie alla musica, agli effetti sonori e alle sezioni narrate, riesce a ricreare un’esperienza evocativa e affascinante.
Questo disco non diventerà un classico della band, ma per quanto ci riguarda si accosta alle migliori produzioni dell’epoca Mangini a livello di qualità (A Dramatic Turn Of Events su tutti), lasciandosi alle spalle i dischi meno riusciti dell’ultima era. Insomma, giunti al sedicesimo album in studio, la band di Petrucci e Portnoy continua a macinare dischi di un certo rilievo e questo non è qualcosa da prendere per scontato.
Voto: 75/100



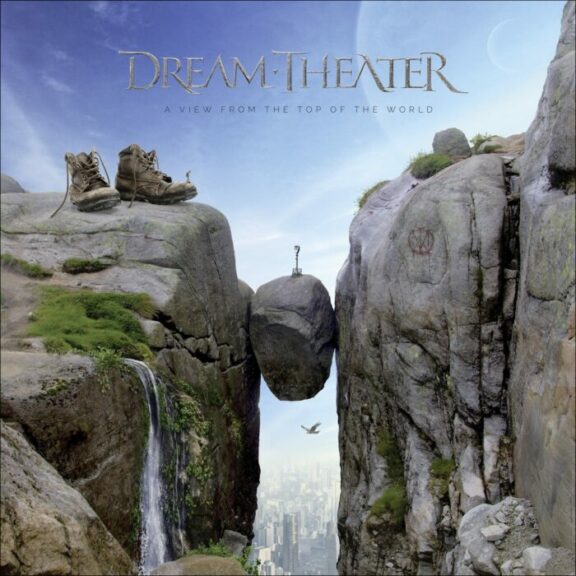
![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)


![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)
![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)
