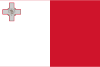Recensione: Pentateuch
Bel periodo per il doom metal, questo: oltre al ritorno in pompa magna dei Sorcerer, anche i maltesi Forsaken tornano sulle scene con la loro quinta fatica (se si escludono demo, EP e split), il possente “Pentateuch”. Ma cosa si nasconde dietro questo titolo biblicamente impegnativo? Beh, ve lo dico subito: un doom epico e ammaliante, che ha nel gran lavoro di chitarre e in una resa vocale sinuosa e declamatoria i suoi punti di forza. In un’oretta scarsa, infatti, i nostri snocciolano melodie possenti e guerrafondaie, riff spessi e pesanti come macigni e una sezione ritmica giustamente opprimente (sebbene la batteria tenda a sparire di tanto in tanto, soverchiata dallo strapotere di chitarre e voce) senza perdere però una certa agilità: il tutto contribuisce a creare architetture sonore compattissime ma che in più di un’occasione si permettono il lusso di svariare in territori che oserei definire progressivi. Aggiungete assoli cangianti, dal sapore quasi settantiano, e una voce che, pur esprimendo la giusta sofferenza, punta maggiormente sul terreno della maestosità, e capirete che qui di ciccia ce n’è parecchia.
Dopo la breve intro strumentale si inizia a picchiare con la monolitica “Serpent Bride”, opener che deflagra subito affiancando a un inizio quasi seducente uno sviluppo più carico di toni minacciosi, acquisendo corposità ma senza perdere la tipica inesorabilità del doom, resa ancor più incalzante nel finale. La successiva “The Banishment” è una brevissima traccia interlocutoria in cui l’ammaliante voce femminile funge da sottofondo atmosferico (ed in seguito da contrappunto) all’intervento narrativo di Leo prima di sfociare nella tellurica “Primal Wound”, in cui si torna a dispensare colate di metallo fuso pronto ad essere sagomato dalle sapienti martellate dei nostri maltesi. L’afflato epico acquista qui un notevole peso, sorretto da una sezione ritmica insistente e un incedere più aggressivo delle melodie, mentre con “The Dove and the Raven” si sprofonda in un baratro di riff sulfurei e fumosi, tempi rallentati e cupi in cui la speranza è un pallido ricordo. Solo ogni tanto qualche sprazzo di melodia sembra intaccare per un attimo le pareti rocciose di questa disperazione sonora veterotestamentaria, ma tutto si traduce in un fuoco di paglia che sprofonda di nuovo nell’ossessiva pesantezza dei maltesi e che anche il solo centrale non fa che enfatizzare, consegnandoci una delle tracce più oscure dell’album. Di simile avviso sembrerebbe anche la successiva “Decalogue”, che però fa dell’avanzata marziale e rigorosa la sua bandiera, scandita da una sezione ritmica tetragona e granitica che solo raramente viene scalfita da sprazzi di melodia meno che ostili. Anche qui, l’assolo sembra aprire spiragli nella corazza impenetrabile del gruppo, ma solo per concedere all’ascoltatore una falsa speranza, infranta sul nascere dal ritorno ai tempi più scanditi che lo accompagnano fino al termine del brano. Con “Sabaoth (The Law Giver)”, dominata da riff aggressivi e un andamento decisamente ritmato, ci si avvicina più a un classico e massiccio heavy di vecchia scuola, soprattutto grazie a Leo che carica la voce di foga battagliera e Sean che giocherella, ogni tanto, con linee chitarristiche più ipnotiche di quanto sarebbe lecito aspettarsi. Nella parte centrale la carica minacciosa della traccia si impenna prima di aprire a un assolo dal sapore di hard rock, mentre nel finale si torna alla consueta pesante compattezza screziata, però, di cupa solennità grazie all’entrata in scena di cori che profumano di gregorian. Chiude l’album “Apocryphal Winds”, lunga suite di quasi sedici minuti introdotta da un arpeggio oscuro a cui si accompagna un cantato lamentoso e crudele. I ritmi si mantengono volutamente lenti, blandi e sofferti, con le chitarre che restano in secondo piano per dare spazio alla voce e alla sezione ritmica, salvo poi salire in cattedra con riff plumbei e melodie malate che solo di tanto in tanto pigiano sul pedale per spezzare di poco la disperata e cantilenante cadenza iniziale. Nella seconda metà il brano rallenta ulteriormente, passando da un breve intermezzo carico di tensione a un solo di reminiscenze classiche che sfuma, infine, in un altro passaggio rallentato. Si riparte, infine, con una nuova vitalità che trasforma la suite in una trottata minacciosa in cui la voce e i cori ci guidano all’ultima sezione strumentale che chiude una traccia forse un po’ troppo prolissa ma di sicuro impatto.
“Pentateuch” è sicuramente un album poderoso, un mausoleo sonoro incombente e ricchissimo di giochi di luce e ombra ma, ciononostante, è anche piuttosto digeribile. Forse il suo principale limite (se di limiti si può parlare, naturalmente) è il suo continuo giocare con le diverse sfaccettature della stessa atmosfera: mi rendo conto che questa possa essere una scelta voluta, anche alla luce di una produzione pastosa e densa, ma gli ascoltatori meno smaliziati potrebbero, alla lunga, soffrire questa (presunta) monotematicità.
Ad ogni modo, un album notevole.