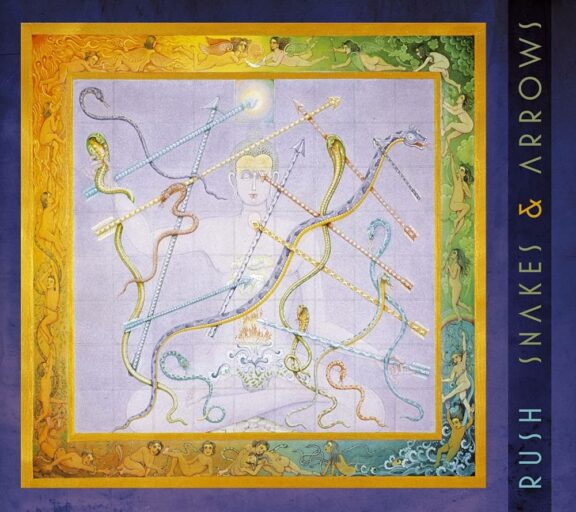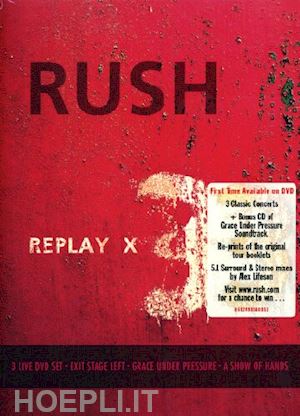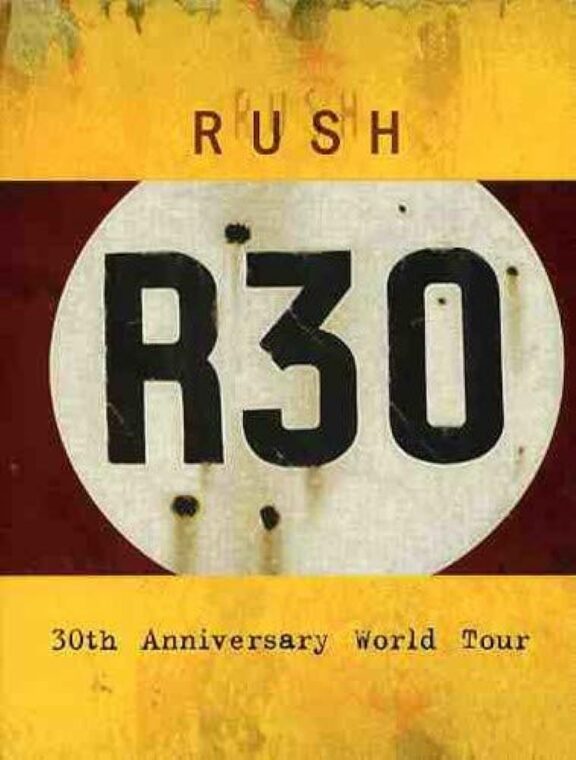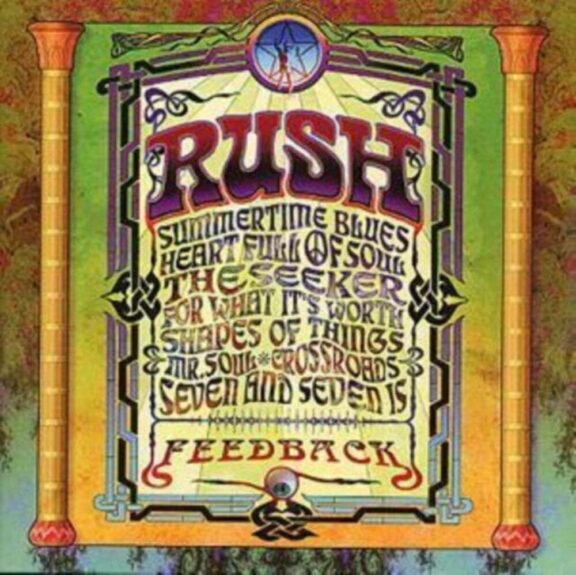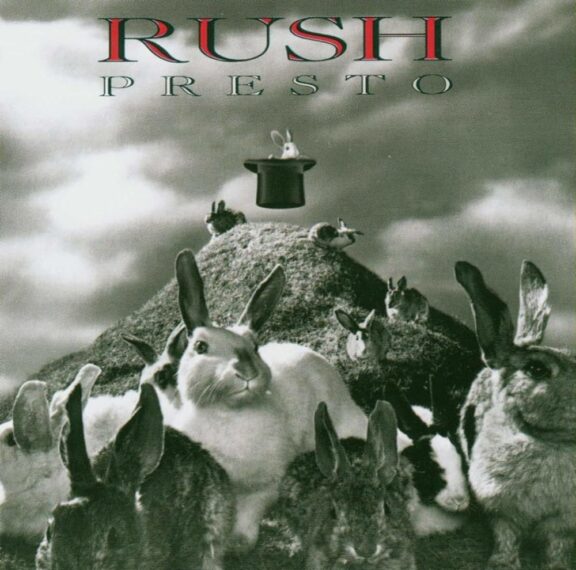Recensione: Power Windows
Per chi scrive, il disco dei Rush che più di tutti dimostra l’attitudine progressiva e fortemente evolutiva è paradossalmente Power Windows. Il sound della band canadese è in continuo divenire, riuscendo a toccare con la semplicità di sempre le sponde dei generi più disparati. Stavolta è il turno di visitare lidi quasi pomp/AOR, non a caso è stato definito da molti come il disco di gran lunga più commerciale mai prodotto da Peart e compari. Come non mai, tuttavia, è risoluto e sfrontato il messaggio lirico dei pezzi: politica, potere, sogni ed emozioni vengono gettati come carne al fuoco nel calderone delle polemiche dal paroliere di sempre, Neil Peart, e i canoni compositivi del passato vengono ancora rivisitati, quando non espressamente stravolti: l’amalgama tra i diversi stili assunti dai Rush finisce col tempo per caratterizzare il Rush-sound, nella sua eccentrica ed inconfondibile personalità.
Si parte con una delle hit commerciali del disco, “Big Money”, incentrata su temi battutissimi come il (Dio n.d.r.) denaro che governa il mondo grazie alla corruzione. L’impatto è immediato e il messaggio arriva a destinazione diretto come un treno, sorretto dal vincente binario costituito dalla chitarra guida di Lifeson e dagli scintillanti synth di Geddy Lee. Questi ultimi occupano in Power Windows un piano spesso di dettaglio, per usare un termine cinematografico, a dimostrazione del fatto che se da una parte viene proseguito il vivo interesse dei Rush per il digitale e le nuove tecnologie già esternato con il precedente Grace Under Pressure, dall’altra le tastiere costituiscono il mezzo più efficace nell’esortare l’orecchio dell’ascoltatore al coinvolgimento sonoro dei trainanti ritornelli.
E’, infatti, ancora la magia pomposa dei synth che introduce “Grand Designs”, presto rinforzata dai powerchord di Lifeson, più cristallini che in passato. Il soggetto è qui abbastanza ermetico, anche se mi permetterei di avventurarmi nella supposizione, peraltro generalizzabile, di un’accusa alla modernità, tutta forma e niente sostanza, o anche alla sua scarsa integrità morale…
Peart sfoggia il suo amore per la letteratura (fanta)scientifica con “Manhattan Project”, una song sulle origini della bomba atomica: grande intensità emotiva per un argomento davvero scottante, in un periodo in cui la guerra fredda era tutt’altro che terminata. Su comincia proprio con le percussioni simil-militari di Peart e un guitar riffing ridotto all’osso per concentrare l’attenzione sul lirismo epico dell’argomento. Uno dei miei brani preferiti dell’album.
Perseveranza e concentrazione sono i temi affrontati in “Marathon”, allegoria della vita umana, descritta come una gara di resistenza da questo incalzante up tempo. Spiazzante, ma ormai non ce ne stupiamo più, il breve intermezzo centrale, preparatorio al crescendo incandescente con cui si chiude la song.
Eccitante la successiva “Territories”, pezzo celebrativo della diversità razziale, a dispetto di quanti accusavano i Rush di xenofobia (ma a dar retta a chi ne sa quanto o meno di noi facciamo sempre male, la colpa è nostra, n.d.r.!). Si parla anche della storia dell’Asia, della stupidità del patriottismo preferito all’individualismo. I toni polemici e provocatori vengono esaltati ancora dal brillante lavoro di chitarra e synth, sempre a braccetto nel disegnare potenti e trascinanti armonie; le tendenze anti-nazionaliste della song mi hanno ricordato molto le disquisizioni sociologiche in Star Treck, saga a cui Peart è molto affezionato.
“Middletown Dreams” parla di sogni irrealizzati e della loro capacità di tenere vive le persone. La chitarra di Lifeson lascia la scena a vantaggio degli invadenti synth di Lee, per un risultato più rilassato, che potrebbe fare il paio, quanto a contenuti, con “Losing It”, ascoltata su Signals tre anni prima.
Si sale ancora, nell’eterea melodia di “Emotion Detector”, e Lee canta di emozioni umane, con un’intonazione contemplativa che stupisce – quante volte ancora? – nel tentativo di esplorare in tre sole sezioni liriche un argomento troppo ampio.
Chiude il sipario “Mystic Rhythms”, e non potrebbe essere altrimenti, visto il climax lirico che dal pragmatico e materilistico subject ci ha condotti all’astratto e quasi metafisico argomento della traccia conclusiva: il messaggio (qualcosa a che fare con il fascino dell’ignoto) è sublime, direi criptico, e la song è la più tecnica del lotto, con Lifeson che torna a dettare legge in un solo impressionante, mentre la performance di Peart è talmente straordinaria che la song verrà usata come drum solo nei live show.
Se su Signals e Grace Under Pressure si poteva parlare solo di esperimenti, qui i Rush hanno (ri)scoperto il modo di catturare l’attenzione e rendere memorabili le proprie idee alla maniera che tanto andava in voga negli ’80: melodie orecchiabili, tastiere al limite del pomp, impatto sonoro assicurato dalle nuove tecnologie digitali. Il tutto, scusate se è poco, nella geniale capacità, tutta Rush, di sorprendere ad ogni battuta, e di accaparrarsi nuovi fan grazie alla superficialità di tanti addetti ai lavori, che all’epoca bocciarono Power Windows additandolo come la svolta pop del trio canadese. Probabilmente fecero l’errore dal quale io oggi, dopo quasi vent’anni, metto in guardia voi: non vi fermate al primo ascolto!
Tracklist:
- The Big Money
- Grand Designs
- Manhattan Project
- Marathon
- Territories
- Middletown Dreams
- Emotion Detector
- Mystic Rhythms