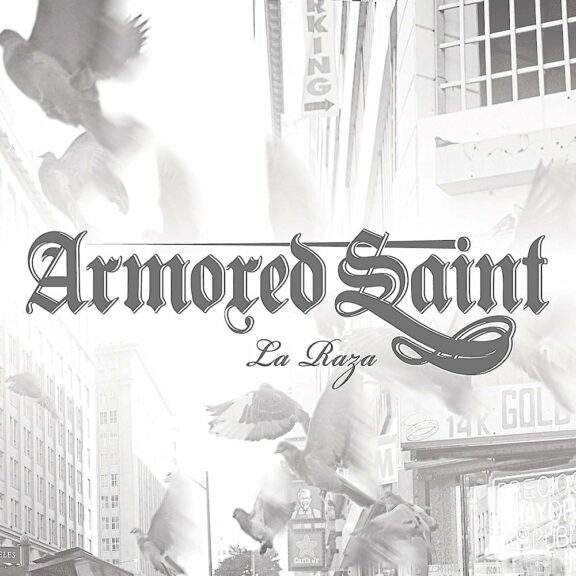Recensione: Punching the Sky

Gli Armored Saint non hanno bisogno di presentazioni, vero? Alfieri dell’heavy metal nella sua accezione più classica, i nostri baldi californiani hanno attraversato gli ultimi 38 anni con alterne fortune, raccogliendo spesso (almeno per come la vedo io) assai meno di quanto meritassero. Al di là delle mie considerazioni da vecchietto davanti a un cantiere, il motivo per cui siamo qui oggi è che fra meno di una settimana uscirà il nuovo lavoro dei losangelini, “Punching the Sky”, che arriva a cinque anni dal precedente “Win Hands Down” e a tre dal live “Carpe Noctum”. Per l’occasione, i nostri fanno il punto della situazione con un album a cavallo tra il passato del gruppo e la stretta attualità musicale, mescolando un po’ le carte con l’inserimento di elementi accostabili all’hard rock e strumenti meno convenzionali per il quintetto americano (si vedano le cornamuse che aprono l’album, o i flauti dei nativi americani che compaiono nella conclusiva “Never You Fret”). Se devo essere completamente sincero, durante i primi ascolti non ero rimasto particolarmente convinto dal risultato, e avevo inizialmente giudicato “Punching the Sky” un lavoro diretto ma dispersivo, seppur dotato di canzoni niente male. Per fortuna, la botta in testa che avevo preso si è pian piano riassorbita e il mio indice di gradimento dell’album è aumentato sempre più, consegnandomi alla fine un album di gusto, affilato e croccante e dotato anche della giusta dose di rombante potenza. Rispetto a “Win Hands Down” le canzoni si fanno un po’ più corte, dirette e concentrate, mantenendo in un modo o nell’altro, però, tutti gli elementi distintivi del Santo Corazzato. In altre parole: riff secchi e di facile assimilazione, sgroppate ritmiche e melodie al tempo stesso maschie ed accattivanti, il tutto sormontato dalla voce imperiosa e stradaiola di John Bush, impeccabile come sempre e vera arma in più del combo losangelino.
Un inizio che, grazie alle cornamuse cui accennavo prima, sembra preso di peso da un album di Loreena McKennitt introduce “Standing on the Shoulders of Giants”; l’arpeggio sostenuto dal ritmo tribale che si impossessa del pezzo poco dopo ci guida all’interno di una bella opener, rockeggiante e diretta, che ha in un andamento da viaggio una solida base su cui innestare il ritornello pieno, ideale punto-luce della canzone. Con “End of the Attention Span” si comincia a fare sul serio: la traccia, dopo una schitarrata minacciosa, si sviluppa attraverso riff cafoni e sempre improntati ad un bell’heavy rock di quelli fatti bene, mentre John sbraita arcigno iniettando la giusta verve stradaiola nel pezzo. Bello anche il lavoro delle chitarre, ma è tutto il gruppo che svolge perfettamente il suo compito, pompando dinamismo e sfrontatezza con la giusta classe senza scadere nella pacchianeria. Un riff duro e classicissimo introduce “Bubble”, traccia scandita e smaccatamente heavy in cui, ad un tratto, si fa largo anche un’impennata di melodia per consentire al ritornello di assestare una piccola zampata. “My Jurisdiction” inizia in modo più compassato, caricandosi pian piano su un giro di basso bene in evidenza per poi esplodere con una classica tracotanza heavy. Anche qui si seguono ritmi blandi, mentre i cori aggiungono carica anthemica al pezzo che, però, nonostante un bell’intermezzo e un assolo interessante non mi ha del tutto convinto, forse per via di un andamento a mio avviso un po’ arrancante. “Do Wrong to None” torna alla sfacciataggine rock snocciolando riff agguerriti e suoni distorti, pompando le giuste melodie durante il ritornello ma solo quando serve. C’è tempo anche per una piccola citazione, un’eco dal precedente lavoro piazzata subito prima dell’apertura minacciosa di “Lone Wolf”, che poi si dipana su ritmi quadrati e notturni intervallati da arpeggi più distesi, rilassati, che si caricano di una certa verve durante il ritornello.
“Missile to Gun” parte enfatica, maestosa, salvo poi farsi agguerrita e arrogante: la traccia si sviluppa su riff dinamici e stradaioli, senza dimenticare una bella carica trionfale di sottofondo che dona al tutto un bel tiro. “Fly in the Ointment” rallenta di colpo, mantenendo però la maestà della frustata precedente per incedere come una sorta di power ballad eroica fatta di melodie sfaccettate e power chord rombanti. “Bark, no Bite” torna a dispensare sfacciataggine e dinamicità heavy rock, ma nonostante una resa piena e vigorosa non mi ha preso più di tanto, tanto che in alcuni punti mi è sembrata un po’ buttata lì per far caciara. Di tutt’altra pasta la successiva “Unfair”, che già dall’incipit compassato e serpeggiante fa presagire qualcosa di sfizioso. La canzone si mantiene dimessa, inquieta, mescolando melodie cariche di pathos a passaggi dilatati ma al tempo stesso tesi, prendendo corpo lentamente fino a sfociare in un assolo carico di feeling e spegnendosi poi all’improvviso. Il suono dei flauti apre “Never You Fret”, classica scudisciata heavy dal taglio perfetto, dinamico e corale, ottima per apporre il sigillo su un album passionale e sanguigno.
“Punching the Sky” è un prodotto decisamente superiore alla media, onesto e vigoroso. Cosa ancor più importante, è ancora un lavoro smaccatamente Armored Saint, nonostante qualche passaggio un po’ diverso dal solito che, a fronte di un primo ascolto traballante (ma qui ammetto che è stata tutta colpa mia) e un paio di episodi che non mi hanno fatto impazzire, cresce con l’andar del tempo e si conferma come un album da pollice altissimo, ennesima cecchinata da parte di una band sempre sugli scudi.
Ottimo lavoro, signori.