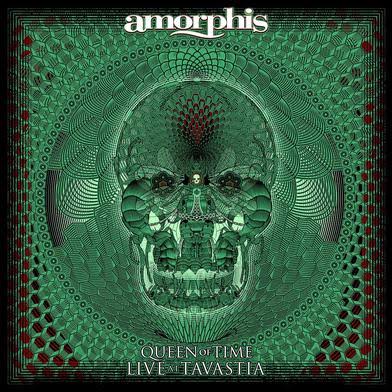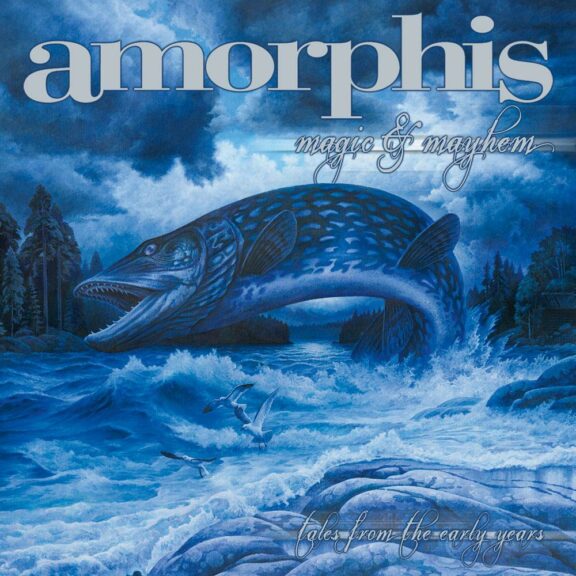Recensione: Queen of Time
“The Bee” voleva essere molto probabilmente un singolo-sorpresa. E, in effetti, ha sorpreso. Un riff assassino, a tutti gli effetti di una semplicità Tuonelianamente devastante – e che non si sentiva da molto tempo – uniti a un Tomi Joutsen incazzoso come non mai avevano lasciato parecchi a bocca. La sorpresa aveva anche lasciato in secondo piano il fatto che le parti melodiche erano quanto di più Amorphisiano si potesse concepire, ma tant’è. Le aspettative erano salite a mille per il nuovo parto dei sei finlandesi, che hanno per inciso hanno salutato il bassista Niklaas Etelavuori e si sono ripresi Olli-Pekka Laine a voler ribadire che la band ormai funziona quasi come una famiglia.
Aspettative, dicevamo, ma di che cosa? Amorphis più incazzati? Qualche elemento di novità? A chi scrive sarebbe bastato riavere un album ispirato, dopo tre dischi che si erano rivelati, nell’ordine, uno “Skyforger parte II” (“The Beginning of Times”), un tentativo di svecchiarsi riuscito a metà (“Circle”) e un lavoro che più di maniera non avrebbe potuto essere (“Under the red Cloud”). Parere soggettivo di chi scrive, sia chiaro. Tuttavia è un fatto che le ultime uscite dei finnici lasciano sempre qualcuno deluso, per questo o quel motivo, e non riescono a convincere appieno.
“Wrong direction”, secondo singolo estratto, ha un po’ frenato la speranza di una svolta, essendo il classico supersingolone targato Holopainen & co., tuttavia aveva messo in mostra una freschezza insperata, un ritornello che è quanto di più tipico per questa band, ma è pure talmente ispirato che è impossibile stare lì a scuotere la testa perché the song remains the same.
E dunque, che ci riservano le altre otto tracce di “Queen of Time”?
Dando a Cesare quel che è di Cesare, bisogna ammettere che il disco è decisamente più duro di quanto sentito negli ultimi anni dai sei finlandesi, ed effettivamente due canzoni come “The Giant” e “Grain of Sand”, cupa e martellante, lasciano di stucco per la sua loro cattiveria. Ma soprattutto “Daughter of Hate”, con quel ritornello che avrebbe fatto la fortuna dei Dark Tranquillity, lascia piacevolmente sorpresi nel sentire un Tomi Joutsen così a suo agio col growl e la band così a suo agio nel creare accelerazioni vertiginose tra una strofa pressoché in sordina e un refrain assassino.
Venendo al resto, bisogna dire che di growl, qua e là, ce ne sono sempre, ma il messaggio che traspare cristallino da “Queen of Time” è un altro, ovvero:
se a questi sei quarantenni gira bene, non ce n’è per nessuno
Perché a tutti gli effetti il 13mo disco dei nostri, in ormai quasi 30 anni di attività, è un lavoro che si distingue soprattutto per il fatto di saper mettere assieme riff assassini, melodie semplici eppure non banali e soprattutto, finalmente, canzoni ispirate. In questo disco c’è esattamente quello che ci deve essere: verve e il guizzo che distingue dei maestri dalle band comuni. Il guizzo che permette di tirare fuori un pezzo ispirato e coinvolgente anche partendo da una melodiuccia folkeggiante all’acqua di rose che sarebbe suonata bollita dieci anni, ma non è che stiamo parlando di “Message in the Amber” eh, sia chiaro.
Puoi montare (in Pyres on the Coast) un growl truculento su orchestrazioni alla Nightwish senza destare perplessità di sorta – e quiogni riferimento è puramente casuale. Puoi fare un duetto con la queen delle queen Anneke Van Giersbergen e trasformare un pezzo tutto sommato carino-ma-nulla-più come “Among the Stars” in una delle perle del disco. Perché c’è poco da fare il duetto tra due voci così inconfondibili affascina, coinvolge e, se servisse dirlo, è riuscito benissimo. E puoi fare l’altra grande perla del disco: “The golden Elk”, per la quale vale il discorso di “Wrong direction”. Trovi tutto quello che ti aspetti dagli Amorphis, ma è di tale roboante bellezza che non puoi rimanere indifferente. E qui sta la quadratura del cerchio.
Con “Queen of Time” gli Amorphis si presentano per quello che sono: una band che ha fatto la storia e che oramai ha trovato una sua forma standard – probabilmente già da “Silent Waters”. Questo sanno fare, ovvero canzoni estremamente catchy, mai banali, spruzzate da elementi estremi; e questo vogliono fare. Sbagliato, oramai, aspettarsi altro. Lecito invece aspettarsi due cose rare: passione e ispirazione. E in questo album ci sono entrambe, in quantità ragguardevoli. La band sta bene, gira a mille e tutto va nel verso giusto. Dopo moltissimi ascolti non c’è una traccia di questo album che sia calata di tono. Inutile fare paragoni col passato. Questo album non è un capolavoro immortale. Ma è comunque un gran disco. Spiega benissimo quale abissale differenza ci sia tra un lavoro di maniera messo insieme da professionisti annoiati e il lavoro genuino di professionisti che vogliono divertirsi e divertire. Dopo tanti anni come se fosse ancora il 1996. Gli Amorphis ci hanno dato alcune produzioni opache nel passato recente, ma stavolta siamo lieti di segnalare una grande ripresa. E speriamo che vadano avanti così.