Recensione: Rise Radiant
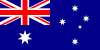
Tagliano il traguardo dei primi dieci anni di carriera anche i Caligula’s Horse, band australiana dal curioso moniker che ormai è entrata nell’immaginario di riferimento per chi ama il prog./djent metal.
Il sodalizio con InsideOut procede come da copione dopo il buon successo di Bloom che è valso la ribalta internazionale alla band. Per descrivere il quinto album della loro discografia, la label tedesca usa parole lusinghiera definendolo “an uncompromising exploration of the human experience dressed in vivid musical colour and virtuosic performances” (un’esplorazione senza mezzi termini dell’esperienza umana rivestita da vivida cromia musicale e performance virtuosistiche) e aggiungendo che Rise Radiant “is an anthem for the regeneration of self-belief” (è un inno alla rinascita della fiducia in se stessi).
Anche titolo e artwork (opera di Chris Stevenson-Mangos) strizzano l’occhio a una certa patina estetica, aspetto che da sempre ha contraddistinto il combo australiano. Tutto da programma, insomma, ma arrivati a questo punto della loro carriera o si raggiunge la consacrazione definitiva oppure la curva discendente è dietro l’angolo (i Dream Theater nel 1999, a dieci anni dal primo studio album, rinacquero dalle ceneri con il capolavoro Scenes From A Memory).
Diciamolo subito, Rise Radiant purtroppo presenta qualche buon pezzo, ma non è il magnum opus che avrebbe potuto far gridare al miracolo. Nei suoi cinquanta minuti (divisi in otto brani dai titoli rigorosamente concisi) torna l’ottima ricerca melodica che contraddistingue i Caligula’s Horse, specie nei refrain, e non mancano rimandi agli Opeth, oltre a una rivalità a distanza con i coevi Leprous, ed Haken (a breve sul mercato con l’atteso Virus). I momenti djent, infine, sono ben bilanciati, e la produzione discreta, tuttavia l’album putroppo non decolla mai.
E dire che s’inizia con un opener memorabile, “The Tempest”, già singolo prescelto e distribuito in streaming. Le ritmiche in stop and go danno la giusta adrenalina e groove, il ritornello è riuscito, mentre l’affiatamento dei componenti resta invidiabile (il quintetto riesce a mettere in campo una tecnica sorvegliata sotto ogni punto di vista). “Slow Violence”, invece, convince meno, c’è poca ispirazione e il brano scorre prevedibile fino al momento strumentale che regala qualche sussulto con un bell’assolo di chitarra. “Salt”, altro singolo estratto da Rise Radiant, riporta l’album su livelli non indifferenti, a partire da un intro ben calibrato per quanto riguarda la variazione di dinamiche. Ritroviamo le ritmiche spezzate in palm mute di “The Tempest”, ma anche rimandi agli Opeth crepuscolari e una buona vena poetica nei testi, oltre a certa devozione ai Dream Theater più scolastici. “Resonate” è un intermezzo ambient con un qualche pregio estemporaneo e va inteso come rampa di lancio per la seguente “Oceanrise”, altro pezzo sui quattro minuti di durata che purtroppo non prende mai il volo, nonostante la solita prova senza sbavature di Goleby e Vallen nel guitarwork. “Valkyrie” prova a variare le clean vocals di Jim Grey con alcuni filtri e proporre un approccio musicale più cattivo: ci riesce a metà, però l’impressione è quella di una traccia convincente in sede live.
Le ultime due composizioni coprono più di un terzo di Rise Radiant e meritano un commento più disteso. “Autumn” ha un avvio in pianissimo emozionante, poi a metà del suo svolgimento si apre con un assolo di chitarra elettrica che ricorda i cugini Circus Maximus. La voce cullante di Gray è il trait d’union del pezzo autunnale, che sembra prolungare la sua conclusione in modo esasperato visto il lungo segmento finale che si sostanzia di ritmiche volutamente dilatate. Il risveglio arriva con i primi secondi di “The Ascent”, un fulmine metallico a ciel sereno che dà avvio ai dieci minuti della mini-suite. La traccia non è un capolavoro assoluto, tuttavia si lascia ascoltare e gode di discreta longevità. Lo spettro di Akerfeldt & Co. aleggia nei continui contrasti tra parti distese e riprese tirate (inutile ribadire quanto gli Opeth siano seminali per il prog. del nuovo millennio…), mentre l’epilogo è poco riuscito, bisognava pensare a linee vocali più ficcanti e non un semplice monosillabo a effetto per chiudere degnamente il full-length,
Arrivati in fondo all’ascolto (possiamo tranquillamente soprassedere all’analisi delle due bonus track in scaletta, niente più che buone cover) la sensazione è di esserci persi qualcosa, di non aver pienamente goduto delle potenzialità della band australiana. I Caligula’s Horse, è vero, non hanno mai voluto andare oltre le righe e mantenere piuttosto un profilo non troppo svettante: sono vicini ai Leprous ma senza avvicinarsi a derive “pop”, sono a tratti djent ma senza esasperare il proprio sound per raggiungere Haken e Periphery…
Il risultato di queste mezze misure, dunque, è Rise Radiant, l’album delle occasioni perdute. Un vero peccato, per un gruppo che ha fatto tour con Mastodon, the Dillinger Escape Plan, Tesseract e Anathema bisogna necessariamente aspettarsi di più…



