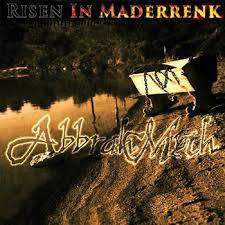Recensione: Risen In Maderrenk
Il mito è senza ombra di dubbio espressione primordiale della ragione umana la quale, prima dell’avvento della scienza e del suo sviluppo, cercava spiegazioni a domande di carattere esistenziale. La profezia è stato un altro elemento ricorrente nella percorso conoscitivo umano: se il mito aveva funzione giustificativa, la divinazione consentiva all’uomo di anticipare il futuro, nel tentativo di controllarlo o perlomeno di prepararsi ad eventuali ed inaspettate difficoltà e molteplici problematiche.
Partendo da queste basi, i sardi AbbrahMyth decidono di allestire un monicker che ruota attorno al mito di Abbrah, divinità fittizia, soggetto di una proposta musicale varia, che affonda le proprie radici nel metal classico e si impadronisce di elementi propri di altre sonorità. Il richiamo al metal più teatrale ed onirico non si fa attendere, riecheggiando nei vibrati d’apertura di “Rival, Don’t Kill”: gli assoli drammatici e orientaleggianti vengono presto spazzati da un’accelerazione di matrice power (ulteriore influenza dei Nostri). Il frontman articola le liriche con un’intonazione sgraziata, isterica, quasi fosse desunta dall’hardcore tricolore, che risulta dissonante con il resto del contesto, un effetto stonato che non tutti apprezzeranno. Risolleva la situazione il buon tune chitarristico al centro del brano, che delinea un bridge collocato tra un ritornello e l’altro, intervallo per nulla stucchevole.
Un riff ruvido, tumultuoso sporca “The Myth Of Abbrah” e viene contrastato da eleganti vibrati e divagazioni, innesti non certi privi di brio, a differenza di un cantato ancora troppo primitivo, che condanna il ritornello a stonature e rudimentali, assordanti vocalizzi.
Il processo di evangelizzazione prosegue con “Eternal”, prova verace che si lancia su tempi veloci, dove il singer improvvisa acuti, con i deludenti risultati che già sappiamo. I backings peggiorano l’impatto vocale, smarrendo alcune discrete soluzioni strumentali. Non contento, il cantato assesta il colpo di grazia finale, facendo sfuggire un rantolo che di poetico ha ben poco.
Detto questo spererete ad un serio cambio di registro, ma verrete smentiti da “The Last Letter Of Jeremy Hartwood”, che non si esime dal riproporre assoli vicini all’opener. Ancora una volta le parti vocali mostrano il fianco, maldestre persino nelle fasi più rallentate ed evocative. Per l’ennesima volta, si avverte la mancanza cronica di un momento veramente ispirato o coinvolgente.
Come per l’intro di “The Last Letter Of Jeremy Hartwood”, un plettraggio plumbeo introduce “The Music Of Erich Zann”, che rivela una duplice struttura: un lato più morbido e desolante, ed una parte più dura e rocciosa. L’urlato di Alessandro Boi non accenna a diminuire, con tanto di “ruggiti” improvvisati. Il bridge è sufficientemente d’atmosfera ma non risalta quel tanto che basta a rapirci perché saremo scossi dall’irritante intonazione “slang” degli ultimi versi.
“Cordolino Del Male” sembra essere segnato dallo stesso destino che incombe su tutto l’album: buon tiro affossato da un ritornello decisamente scontato, il cui grido, richiamando la musica “Oi!”, farebbe desistere pure gli AC/DC a cantare “Rock And Roll Ain’t Noise Pollution”. Buona la melodia del guitar solo, firmata da Michele Aretino, ma nulla potrà salvarci da una mal improvvisata chiusura, ad opera del main vox che si prende una pausa nella strumentale “Whisper” (heavy power dai ritmi frenetici) e nel piacevole folk celtico di “The Quiet Before”.
Se gli AbbrahMyth sono dei profeti, “Anomalies” ne è la dimostrazione: infatti, dopo un pattern dissonante (quasi a mimare eventuali interferenze), l’ennesimo guitar work viene inquinato dalla solita pessima intonazione, come se fosse sublimata da una sbornia memorabile. Condivisibile, invece, lo sforzo di dare dinamicità alla canzone, ricca di cambi di tempo. Buoni propositi che cadono nel dimenticatoio allorché pure gli inserti più meditati (a dire il vero, un po’ scarni) cadono preda del lento vociare del frontman.
Come se non bastasse “Freedom & Duty” riversa un’altra dose massiccia di rabbia isterica nelle ritmiche serrate mentre un hardcore/punk (masticato velocemente), su base power/heavy, sembra perseguitare le strofe come un’inesorabile piaga biblica. Come nel resto del platter, nessun elemento (tecnica, testo, songwriting) riesce pienamente a catturare o attirare l’attenzione dell’ascoltatore.
Scherzi a parte, gli AbbrahMyth alzano la posta in palio e “Prypjat’” miscela prog, hard rock (Black Sabbath) ed heavy impastando un’ambiziosa suite di circa otto minuti: è un pezzo ricco di suggestioni e influenze, il quale aggiunge una parte ardita, in cui le strofe vengono lette rapidamente (con effetto eco ed intreccio vocale) nella lingua italiana. Il main guitar si snoda in rapidissimi, confusi pattern, sempre terrorizzato da fastidiosi, stonati vocalizzi. Un collage dispersivo e disorganico, che raccoglie idee disparate senza riuscire a coordinarle tra loro al meglio.
Sembra che giunti alla fine gli Abbrah vogliono peggiorare la performance vocale, aggiungendo una jam di voci gutturali e belluine, stipandole all’interno di “Redrum”. La sessione strumentale diventa macchinosa e, assieme al comparto vocale, accentua la sensazione di caoticità e disordine trasmessa da un songwriting troppo sconnesso.
Insomma, “Risen In Maderrenk” possiede le tipiche connotazioni dell’autoprodotto in tutto e per tutto, che si possono riassumere semplicemente in una sola parola: migliorabile. Migliorabile nel songwriting ancora acerbo (ravvisabile già dalla durata delle canzoni e dalla commistione di generi diversi) ma soprattutto migliorabile laddove risiede il problema principale ed incontestabile che affligge questo lotto: la sessione vocale, backings vocals compresi. Perché il nemico più grande di Abbrah non è il dio Ilittacs ma è da ricondurre proprio ad una performance vocale troppo grezza e stonata, priva della potenza dell’estremo, del tecnicismo del power, della melodia dell’AOR e, purtroppo, è “doloroso” ammetterlo, della giusta, emotiva abrasività del thrash e grindcore.
Qualcuno potrebbe replicare che la timbrica e le pecche vocali siano scelte di registro: anche in questo caso le cose non cambiano, dato che simili linee non sono adatte alla proposta compositiva, a maggior ragione se il contesto narrativo tratta una materia come un presunto mito, al quale sarebbe più consono un mood epicheggiante o quantomeno evocativo, piuttosto che un main vox dall’inflessione tutta hardcore made in Italy o vicino a sonorità affini ad altre tematiche ed altri lidi musicali.
E’ una ammenda che gli Abbrah devono accettare, senza discussione, e il motivo è semplice: l’album presenta buoni spunti da parte del guitarwork, che potrebbero dare frutto con un supporto vocale azzeccato e con un songwriting più compatto e meno frammentario, per una maggior coesione stilistica. Viceversa, mantenendo la stessa condotta, il risultato rimarrà invariato. Un vero peccato perché le potenzialità si intravvedono ma è necessario farle emergere se i Nostri profeti vorranno divulgare il loro verbo.
Eric Nicodemo