Recensione: Score [DVD]

1 aprile 2006, Radio City Music Hall, New York
“The Showplace Of The Nation”
C’è una band che celebra venti anni di storia, e non ha nessuna intenzione di scherzare. A migliaia sono accorsi da ogni dove per assistere all’evento. E c’è un’intera orchestra ad accompagnare quei cinque nell’esibizione di stanotte. Ma non subito, no. Prima tocca a loro parlare, soli con la propria musica, della loro vita, dei primi passi, dei grandi successi, delle infinite emozioni che hanno vissuto e donato nel corso degli anni.
Dopo una burrasca come “Train of Thought” sembrava impossibile, ma il fulmine “Octavarium” ha avuto un impatto ancor più devastante. Troncata di netto la sequoia degli appassionati, vaporizzate le aspettative di eserciti di fan famelici e incazzati, cui il cambio di rotta – pardon: i continui, ininterrotti, disorientanti cambi di rotta – proprio non sono andati giù. Ma loro, i Dream Theater, suonano quello che vogliono.
Oggi, a due decenni dalla loro nascita musicale, i cinque newyorkesi sono famosi. I loro album entrano nelle classifiche di mezzo mondo, i loro concerti radunano frotte di appassionati, il volgo ne parla, li esalta, li idolatra. Naturale suscitare antipatie, insofferenze. Invidie. Ieri erano troppo tecnici, oggi non lo sono abbastanza. Una volta scrivevano capolavori su capolavori, ora si sono venduti. I Dream Theater, quelli veri, sono morti. Sono finiti con Six Degrees. Anzi, con Metropolis 2, con Awake. Con Images and Words. In fondo, non sono mai stati granché. Sono i migliori. Sono i più sopravvalutati. Hanno tradito i fan. Hanno tradito se stessi. Tutti ne parlano, tutti li giudicano. Tutti sanno che cosa non va, come avrebbero dovuto suonare. Strozzati dai luoghi comuni, talvolta ci dimentichiamo di prendere fiato, di sederci, e di ascoltare. Aveva ragione La Fontaine, e ancora una volta la fiaba del mugnaio e dell’asino coglie nel segno.
Ma ciò che importa è che ora siamo qui, a ripercorrere una carriera ventennale, a guardare negli occhi una band che di quello che pensa la gente se ne frega. Non rinnega nulla, neanche gli errori. E questa è la sua serata.
Si alza il sipario: che lo spettacolo abbia inizio.
Il tempo scorre rapido sulle raffiche ritmiche di “The Root of All Evil”, il primo anello della catena, opener irrinunciabile di tutti i concerti dall’uscita di Octavarium a oggi. Il riffing duro, strafottente, spudoratamente moderno, è la miccia che accende gli entusiasmi del pubblico, innescata dalla tenue fiamma di un refrain che riscalda e ipnotizza. Giusto il tempo di completare il warm up con la ruffiana “I Walk Beside You” – la più odiata dei fan duri e puri di una volta – prima che le lancette del tempo si riavvolgano fulminee fino alla nascita, fino al concepimento. Sono i giorni dei Majesty, giorni in cui “Another Won” era solo uno dei tanti pezzi strumentali incisi su un demo apparentemente senza futuro. Oggi invece può godere delle linee vocali di un James Labrie nel bel mezzo della sua seconda giovinezza, e si aggiudica un posto nella storia iniziando la danza dei ricordi che di qui a breve travolgerà tutto e tutti. Siete pronti?
“Afterlife”: perché “When Dream and Day Unite” non morde, e perché questo pezzo non ha nulla, ma proprio nulla da invidiare ai capolavori più blasonati che il futuro riserverà. Il riffing serrato, il cambio di ritmo prima del ritornello, la sua ultima strofa, secca ed enfatica, la sua apertura melodica prima dell’assolo bruciante di chitarra e tastiera. Se ancora non siete schizzati in piedi dalla sedia a gridare, forse siete troppo vecchi per questa musica.
E poi, naturalmente, immagini e parole. Che cosa volevate? “Pull Me Under”? “Take the Time”? Forse “Learning to Live”? E invece c’è “Under a Glass Moon”. Che, a dirlo par strano, talvolta in mezzo a quel ben di dio che le menti di questi ragazzini partorirono all’alba della loro carriera finisce per passare un po’ in ombra. Ma se fate un passo indietro, e sollevate un poco lo sguardo, da quelle ombre vedrete emergere un colosso in musica di proporzioni immani, innanzi al quale ogni voce si fa fievole, ogni parola superflua.
Ancora un balzo avanti, è il momento di “Innocence Faded”. Se non fosse ancora bene chiaro l’attuale stato di forma di LaBrie, è il momento di sradicare ogni dubbio. Per il resto, che cosa si può dire di un brano ormai noto e stranoto, in cui la band si diverte e fa divertire – e in questi casi, si sa, il buon vecchio Portnoy è sempre il primo – scatenandosi come se lo suonasse oggi per la prima volta?
Dunque, si proceda oltre. Tocca a “Falling to Infinity”. Anzi, non proprio. In realtà, tocca a “Raise the Knife”, b-side riesumata dal profondo dell’era Sherinian, imprevisto coniglio estratto dal cilindro più malconcio. Chissà perché un pezzo simile non riuscì a ritagliarsi uno spazio sul quel disco, che di passi falsi ne conteneva più d’uno…
Ma bando alle ciance. Quel che sta per arrivare vi strapperà il cuore, se ancora ne avete uno. Petrucci accarezza le sei corde, e si inventa un assolo da sciogliere un iceberg. È il preludio a quella che è forse la canzone più commovente, più romantica, oserei quasi dire più bella, che i Dream Theater abbiano mai composto. Le palpebre si socchiudono, il delicato tocco del pianoforte accarezza dolcemente la pelle, un brivido percorre la schiena. É un lento crescendo di emozioni, un’indescrivibile climax di passione che scava nell’anima, la sommerge, la sconvolge e la lascia attonita, felice, disorientata. Chitarra, basso, batteria, pianoforte, voce si sciolgono e si uniscono per forgiare l’irripetibile. Ecco, è finita. Si chiamava “The Spirit Carries On”.
Le luci si spengano, il palco si oscura. Ma non siamo neanche a metà. Eccola, la Ocatavarium Orchestra si desta dal suo sonno e sale in cattedra. È il momento di “Six Degrees of Inner Turbolence”. Quali pezzi? Tutti, naturalmente. Sì, la suite viene eseguita per intero, tutta d’un fiato, da band e orchestra insieme. L’apertura è interamente affidata a quest’ultima: improvvisamente pare di trovarsi in un altro teatro, ad assistere a un concerto di musica classica. Ma è anche heavy metal, e la devastante doppietta “War Inside My Head”/“The Test That Stumped Them All” sta lì a ricordarlo. É un tripudio di emozioni, una pioggia incessante di note variopinte, è spettacolo allo stato puro. La musica ti prende per mano, ti guida, ti abbandona e poi ti riprende, ti colpisce al volto quando meno te lo aspetti, ma poi ti accarezza e asciuga le tue lacrime, infine ti solleva, in alto, fino al cielo. Tanto che ti par quasi che allungando solo un poco ancora la mano potresti sfiorarlo con la punta delle dita…
Ritorno al presente. C’è solo la breve “Vacant” a rappresentare il pomo della discordia “Train of Thought” (e forse qualcuno sarà più felice così); introduzione ideale per la carezzevole “The Answer Lies Within”, che scivola quieta sulla seta di un sottile manto sinfonico, increspato solo dalla passione di una voce gonfia di melanconico pathos. L’escalation di emozioni sale un altro gradino con le drammatiche note di “Sacrified Sons”, e qui la cronaca deve fermarsi. Impossibile descrivere ciò che il pubblico di New York deve aver provato nel rivivere in questo brano – accorato, ma nient’affatto patetico – impossibile spiegare l’impatto emotivo che quelle immagini, quelle parole, quelle note possono avere suscitato allora, in chi le ascoltava, in chi le suonava.
Concediamoci dunque di passare direttamente al gran finale. “Octavarium”. La suite, il monumento, l’ultimo capolavoro. L’introduzione, esplicito tributo pinkfloydiano, pare fatta apposta per il privato sollazzo di Jordan Rudess. Le sue dita viaggiano precise e sicure sul suo balocco del momento, il continuum, lo percorrono di centimetro in centimetro, ne esplorano avide ogni andito. Masturbazione musicale: basta guardarlo in faccia per convincersene. Poi entra la chitarra di John, accompagnata dal flauto. Di seguito, la voce. E ancora basso e batteria. Lentamente, la canzone sboccia, senza fretta, guardinga e sorniona. È la storia del prog rock quella che stiamo ascoltando. Di nuovo, Jordan detta il cambio di passo, suona la sveglia, come a salutare una nuova alba vivace e solare. Ma di lì a poco, si sa, arriverà il tornado. La furia dei cinque elementi si scatena in uno scalmanato rito dionisiaco, un turbine che travolge tutto e tutti, fino alla strofa finale, all’apogeo dell’emozione, all’ultimo assolo e al definitivo commiato orchestrale. È finita? Certo che no.
Encore, non poteva mancare: la perla, la gemma, il diamante – Metropolis, parte prima. Il capolavoro dei capolavori, di nuovo assieme all’orchestra, che entra in punta di piedi, discreta e quasi timida di fronte a una canzone che ha segnato un’epoca. Ma a che pro continuare a discorrerne? Correte ad ascoltare.
Applausi, inchino, applausi. Ora è veramente finita. Mentre scorrono i titoli di coda, vien da ripensare a ciò cui si è appena assistito. Non se la scoredaranno facilmente, quei cinque, questa notte. E neanche noi.
È già tanto, è già troppo. Siamo sazi, ma c’è ancora un disco da esplorare, il fantomatico disco bonus. Che farsene di un disco bonus, quando si ha in mano uno spettacolo del genere? Eppure sarebbe un peccato dimenticarlo. E non tanto per la buffa animazione che accompagnava l’uragano strumentale di Octavarium, né per le tre tracce dal vivo, raccolte da concerti in giro per il mondo, che forse saranno maggiormente apprezzate quando l’euforia del recente ascolto avrà preso congedo onde lasciar spazio al gusto completistico del collezionista.
Ciò che davvero merita fin da ora tutta la vostra attenzione, invece, è quel documentario, “The Score So Far…”: vent’anni di carriera raccontati in poco meno di un’ora. Qui vedrete crescere un gruppo di ragazzini cappelloni appassionati di Rush e Black Sabbath, Iron Maiden e Metallica, Yes e Dixie Dregs. Conoscerete le speranze e le delusioni di “When Dream and Day Unite”, l’inatteso successo di “Images and Words”, le conquiste di “Awake”, le frustrazioni di “Falling into Infinity”, la resurrezione “Scenes from a Memory”, la frattura “Six Degrees of Inner Turbolence”, il terremoto “Train of Thought”, l’ultimo tratto del cerchio “Octavarium”. Sorriderete nell’ascoltare gli opinabili sproloqui e gli esagerati entusiasmi dei fan più sfegatati. E scoprirete che, tutto sommato, quei signori che sono saliti sul palco, stanotte, per suonare la musica che ascoltate, non sono creature divine o mostri ultraterreni, bensì cinque pimpanti ragazzoni, dotati sì di talento ma soprattutto di tanta, tanta determinazione. Uomini che hanno condiviso un sogno, e che hanno sudato e lottato e perseverato, fino a che non sono riusciti a realizzarlo. E se oggi sono dove sono, lo devono soltanto a se stessi.
Così si conlude “Score”, macchina del tempo che riunisce passato e presente, per orchestrare la colonna sonora di una vita in musica. Ora sta a voi. Potete levare il dito delatore, magari azzannare le rare sbavature dell’orchestra e ripetere macchinalmente le solite vecchie formulette accusatorie. Potete anche difendere a spada tratta i vostri paladini e lanciarvi furiosi contro le immortali schiere dei mulini a vento. Oppure potete scegliere il silenzio. In tal caso, se vorrete chiudere gli occhi, se vi lascerete sommergere e cullare da questo sconfinato mare di suoni ed emozioni, allora vi accorgerete che mille parole e mille lodi, mille invidie e mille pregiudizi, nulla possono di fronte alla bellezza di una singola nota.
Keep The Dream Alive
Disc One:
Set 1 – Dream Theater
1. The Root of All Evil
2. I Walk Beside You
3. Another Won
4. Afterlife
5. Under a Glass Moon
6. Innocence Faded
7. Raise the Knife
8. The Spirit Carries On
Set 2 and Encore with The Octavarium Orchestra
9. Six Degrees of Inner Turbulence
10. Vacant
11. The Answer Lies Within
12. Sacrificed Sons
13. Octavarium
14. Metropolis
Disc Two:
1. 20th Anniversary Documentary “The Score So Far…”
2. Octavarium Cartoon
3. Another Day (live in Tokyo, 1993)
4. The Great Debate (live in Bucharest, 2002)
5. Honor Thy Father (live in Chicago, 2005)

![Score [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81J6W4cnL._AC_SX466_.jpg)

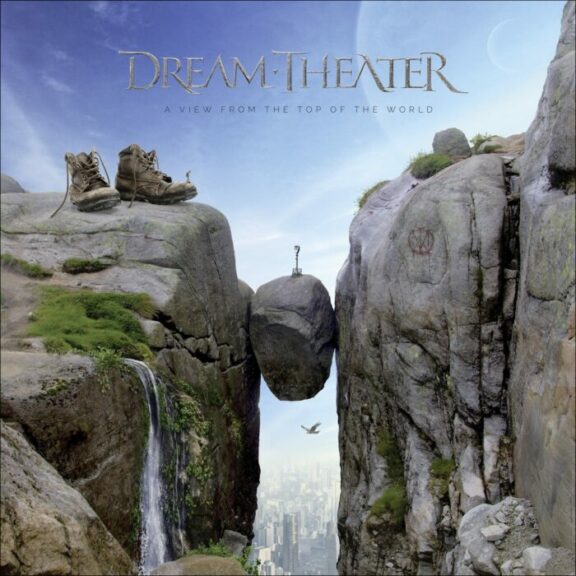
![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)


![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)
![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)
