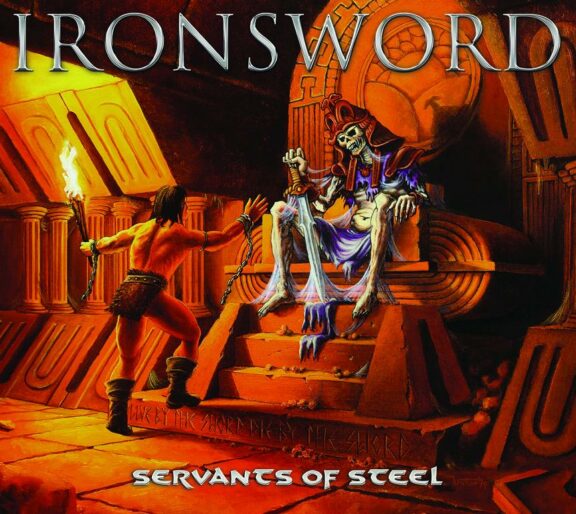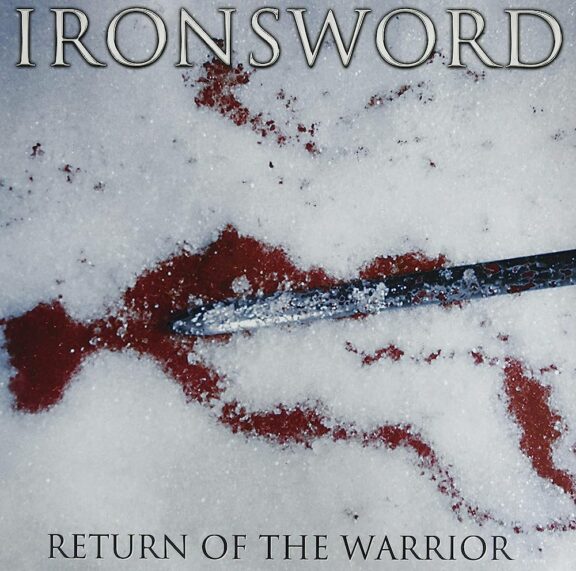Recensione: Servants of Steel

Dopo una pausa di cinque anni dal discreto “None but the Brave” tornano alla riscossa i portoghesi Ironsword col loro quinto album, “Servants of Steel”, che già dalla copertina – per la verità un po’ banalotta nel suo essere smaccatamente retrò – scopre immediatamente le carte nella sua citazione al barbaro più famoso del cinema. Una breve scorsa ai titoli delle dodici tracce (per una cinquantina di minuti complessiva) che compongono l’album, poi, toglie ogni dubbio sulle reminiscenze liriche del terzetto: qui, infatti, il saccheggio dei rimandi al bardo di Cross Plains e al suo iracondo cimmero raggiunge vette considerevoli.
Fatte queste premesse, cosa mai potranno suonare Tann e soci? Dai, gente: è facile. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto: il dinamico terzetto suona un feroce e battagliero metallo classico di stampo epico, fortemente debitore della scena più oscura degli anni ’80 che ha in gruppi come primi Omen, Cirith Ungol e Manilla Road alcuni tra i suoi più degni rappresentanti. L’adorazione degli Ironsword nei confronti dei Manilla Road non è un segreto, almeno per chi li segue da un po’, e anche stavolta questo sentimento si sublima in una vera e propria dichiarazione d’amore alle caratteristiche che resero celebre il (ahimè) defunto gruppo di Wichita. Ecco quindi che, dopo quelli presenti su “None but the Brave“, anche durante l’ascolto di questo “Servants of Steel” i rimandi ai Manilla Road si sprecano: si veda ad esempio quello a “The Ninth Wave” nella seconda parte di “Son of Crom”, o l’andamento di “Upon the Throne” che riecheggia più o meno vagamente “Divine Victim”, per non parlare della voce nasale – a richiamare alla mente quella di Shelton – che si insinua di tanto in tanto tra i ruggiti di Tann. Chiude il cerchio la presenza del buon Bryan “Hellroadie” Patrick come ospite in un paio di tracce. A fronte di quanto detto, sarebbe però ingeneroso ridurre “Servants of Steel” a un semplice tribute album mascherato. I portoghesi, infatti, non avendo a disposizione la vena compositiva e i solos dal profumo ipnotico dello Squalo, ci mettono comunque parecchio del loro e puntano giustamente su ciò che conoscono meglio, e cioè sull’impatto dirompente e l’epicità sborona del “La mia spada è più grossa della tua!”. Questo normalmente mi farebbe storcere il naso non poco, ma nonostante la mia allergia all’eccessiva ostentazione di coatteria sonora ammetto che il risultato finale, in questo caso, non è affatto male. Le chitarre sono corpose, graffianti, arcigne, e si affiancano al basso per trasmettere la giusta oscurità nelle melodie, il giusto fomento battagliero e la carica adrenalinica che ci si aspetta quando si prende in mano un racconto di Conan il Barbaro; la batteria pesta quando e quanto deve, dettando i tempi con diligenza a seconda delle necessità atmosferiche di ogni traccia per poi lanciarsi, di tanto in tanto, in fulminanti sfuriate dal retrogusto speed, mentre il vocione burbero di Tann spadroneggia con l’arroganza di un capoguerra in terra nemica. I ritmi delle canzoni si mantengono quasi sempre piuttosto agili, conservando così la bellicosità che piace tanto al trio, ma non è difficile imbattersi in qualche sporadico rallentamento dall’afflato solenne o sulfureo, utilissimo per screziare le composizioni con atmosfere oscure, minacciose o rarefatte e per donare una seppur minima varietà al tono generale dell’album. E qui arrivano le note più o meno dolenti, perché se è vero che i nostri non hanno mai fatto segreto della loro pervicace ed incorruttibile Trvezza – giustificando così la loro totale e sacrosanta adesione ai dettami di un certo modo di intendere il metallo – è anche vero che cinquanta minuti declinati secondo i medesimi stilemi possono risultare un po’ pesanti per orecchie poco allenate o non proprio fanatiche del genere.
Nonostante, infatti, tutte le tracce che compongono “Servants of Steel” si mantengano su un buon livello, trasmettendo l’arroganza e la furia battagliera incombente e minacciosa che vorrei sempre trovare in un album di heavy metal, devo dire che un minutaggio inferiore, anche di soli otto o dieci minuti, avrebbe sicuramente giovato alla sua fruibilità. Ad acuire questo piccolo problema concorre il secondo peccatuccio (non me la sento di definirlo difetto) di “Servants of Steel”, che va ricercato nella sua indiscutibile prevedibilità. Ciò, sommato alla sua lunghezza non indifferente, potrebbe provocare un abbassamento dell’attenzione durante l’ascolto dell’album, ma gli Ironsword riescono in qualche modo ad aggirare il problema (o quantomeno ci provano) grazie alla pura e semplice carica combattiva che infondono nelle canzoni.
Alla luce di quanto scritto mi sento di annoverare “Servants of Steel” tra i buoni album: non è un capolavoro, ma nonostante il suo carattere derivativo e la staticità di fondo presenta comunque canzoni carismatiche, quadratissime e dotate del giusto tiro; ciò rende “Servants of Steel” un album che, oltre a rappresentare un passo avanti rispetto al suo predecessore, di certo farà la gioia di tutti gli amanti dell’heavy più cafone, ma difficilmente farà breccia allo stesso modo nei cuori di ascoltatori meno settoriali.