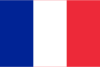Recensione: Seven Deadly Songs
Di album di questo tipo non se ne vedono molti in giro.
E non c’entrano il monicker bislacco o il concept insolito, ma la struttura delle canzoni, la loro forma, le influenze di genere che incarnano. C’è qualcosa di assurdo, di sfrontato, perfino di suicida in questa maniera di comporre. Pochi sono i terreni scivolosi quanto quello su cui pretendono di muoversi i francesi Lord of Mushrooms, giovani e dotati musicisti determinati con questa loro seconda uscita ufficiale ad abbattere barriere musicali cui il senso comune sconsiglierebbe persino di avvicinarsi. Per riuscire nello scopo i cinque transalpini approntano un insolito ordigno sonoro, all’apparenza innocuo, ma da maneggiare con estrema cura. Seven Deadly Sins è un disco accessibile solo in apparenza, impegnativo tanto per chi esegue quanto per chi ascolta, un disco audace, spericolato, insano, chiamato a destreggiarsi sulle instabili funi che ne connettono le parti. Un disco acrobatico, che rischia spesso di precipitare, e che pure riesce sempre a mantenersi in piedi.
Ma bando alle ciance, parliamo di musica, parliamo di queste sette canzoni capitali.
Pride: eccolo per primo il brano più sperimentale, spregiudicato, impudente del lotto. Filtri vocali sfacciatamente strappati a un pop moderno e conformista vengono costretti a danzare su un reticolo progressivo fatto di cambi di tempo, azzardi sonori e assoli tanto intricati da atterrire con uno sguardo l’etichetta “commerciale”, che qualche frettoloso ascoltatore si preparava ad appiccicare a un refrain spudoratamente coinvolgente e orecchiabile. Il bridge è da mani nei capelli: non si capisce se è il pop a essere sacrificato sull’altare del prog, o quest’ultimo a finire sottomesso dalle melodie facilone della musica delle masse. Una sola cosa è chiara: ci vuole un bel coraggio a scrivere un pezzo del genere.
Avarice: se tutto l’album fosse proseguito sullo stesso tono dell’opener, forse avrebbe ragione chi lo vuol definire un prodotto furbo, fatto per vendere. Ma già col secondo pezzo le linee vocali si inaspriscono, diventano più rauche e spigolose in un refrain strozzato, quasi forzato. Similmente, le tastiere si divertono a spiazzare l’ascoltatore cambiando suoni su suoni, consapevoli di contrarre debiti su debiti con un certo signor Rudess. Il brano non è semplicissimo da digerire, il contrasto con il precedente netto. Dove vogliamo andare a parare?
Envy: che i Dream Theater siano la fonte d’ispirazione principale della band, era già chiaro. Tanto più che qui i prestiti cominciano a diventare furti, ma il risultato è a dire il vero molto positivo. Le radici progressive della band proseguono anche oltre e vanno ad attingere linfa in casa Rush, c’è anche un tocco di Lucassen nel break centrale, perfino un repentino cenno a Malmsteen tra un riff e l’altro, ma il centro focale rimane fisso sulla band di New York, con strumenti che all’unisono si destreggiano su pattern ritmici proibitivi. Discorso a parte per le linee vocali che, di nuovo, si concedono un refrain ruffiano e ammiccante, incaricandosi della porzione melodica più consistente.
Anger: con un titolo del genere, parrebbe lecito aspettarsi una sfuriata strumentale, un pezzo potente e aggressivo, la Panic Attack francese. E invece no. Anger è infatti un brano aperto, armonioso seppur incalzante, sicuramente uno dei brani capitali meglio riusciti insieme al primo e all’ultimo. E la sua forza non sta tanto nel refrain facile e immediato, quanto nel lavoro straordinario di una sezione ritmica dinamica e fantasiosa, semplicemente irresistibile, nonché in una coppia di assoli consecutivi di tastiera e chitarra da applausi. Melodia, melodia e ancora melodia nelle linee vocali, che qualcuno vorrebbe sporche per non contraddire del tutto il titolo iroso, ma che imperterrite si mantengono affabili per tutti e otto i minuti abbondanti minuti di durata del pezzo, andando persino a riscoprire i filtri di Pride negli ultimi passaggi.
Sloth: il passo più breve pare anche il più incerto. Il momento è senza dubbio propizio per una ballad, ma Sloth si risolve semplicemente in un crescendo – manco a dirlo – pigro e piuttosto ripetitivo che con poche variazioni si protrae per tre minuti e mezzo indolenti e poveri di sorprese. Certo, l’accompagnamento pianistico è ancora una volta brillante, il tema principale innegabilmente piacevole, ma dodici ripetizioni in tre primi e trentacinque secondi paiono decisamente troppe.
Gluttony: qui la sperimentazione torna a farsi davvero interessante. Le linee vocali orami le conosciamo, ma stavolta è la strumentazione che si diverte ad esplorare lidi jazz, fusion, pop, rock, elettronici, psichedelici e naturalmente prog. Divagazione dopo divagazione, il pezzo ingrassa e si dilata senza ritegno, ma mantiene una propria forma e coerenza fondamentale, una luminosa linea guida che tra risate e grugniti animaleschi conduce fino a un conclusivo, impertinente attacco di aerofagia. Divertente, e non solo.
Lust: si torna su lidi prettamente progressivi con l’ultimo e più piacevole peccato capitale. Inquietante, naturalmente seducente, Lust offre fin dalle primissime battute una struttura ritmico/melodica compatta e tutt’altro che immediata, sostenuta da tastiere spettrali, spesso nascoste ma essenziali in fase di supporto a una voce che si lancia all’esplorazione di orizzonti ancora nuovi, ora carezzevoli, ora sadici, fino a sfiorare persino uno screaming sporco e allucinato. E l’ascoltatore che crede ormai di aver assestato la guardia contro gli eclettici e imprevedibili attacchi musicali della band non potrà fare altro che incassare la chiusura martellante da uno scacciapensieri tradotto in beat elettronici volgarmente discotecari, vero e proprio pugno nell’occhio che pure si lascia incassare con un sorriso, dopo tutto quel che si è ascoltato sinora.
A corollario delle sette mortali canzoni si innestano tre brani di complemento, di durata complessivamente propinqua alla dozzina di minuti, che abbandonano le ardite sperimentazioni offerte finora per ricompattarsi su coordinate più tradizionali. Potrete assaporarli per il loro valore espressivo, e allora apprezzerete le atmosfere rilassate di The Bewitching Air e i fraseggi intricati della breve ma complessa The Tempest, oppure interpretarli come chiave di lettura dell’intero album. In questo caso, mentre ascolterete il motivo portante di Pride ripreso e purificato nei cori di Paylee, vi renderete conto che i Lord of Mushrooms avrebbero effettivamente potuto produrre un album con arrangiamenti diversi, più ortodossi e fedeli alla tradizione. Ma non sarebbe stata la stessa cosa.
Il concetto dovrebbe essere chiaro, ma a scanso di equivoci gioverà ricordarlo: quest’album non è per tutti. Per qualcuno i primi ascolti saranno fatali, certe commistioni musicalmente blasfeme spaventeranno i puristi; ma chi vorrà accettare la sfida, alla fine, sarà immancabilmente premiato. E, sia chiaro, non è che i Lord of Mushrooms abbiano dato oggi vita a un nuova corrente progressiva – lungi da noi sostenere qualcosa di simile – al contrario gli strumenti creativi di cui fanno uso sono quelli della tradizione, o meglio delle tradizioni. Sta infatti nel felice accostamento dell’apparentemente incompatibile la loro intima forza, la loro effettiva originalità.
Sarebbe un peccato accantonare oggi questo eretico manifesto per poi riscoprirlo a distanza di anni, come è successo troppo spesso in passato per formazioni sepolte nell’indifferenza e divenute oggetto di culto quando era ormai troppo tardi per ritrovarle ancora in vita. Il consiglio è dunque quello di dare subito una chance a una band, anzi, a un’idea musicale che senza inventare nulla è riuscita a dire qualcosa di nuovo.
Tracklist:
1. Pride (6:45)
2. Avarice (5:24)
3. Envy (5:54)
4. Anger (8:41)
5. Sloth (3:35)
6. Gluttony (7:45)
7. Lust (8:41)
Legend:
8. The Bewitching Air (3:50)
9. The Tempest (2:54)
10. Paylee Control (5:25)