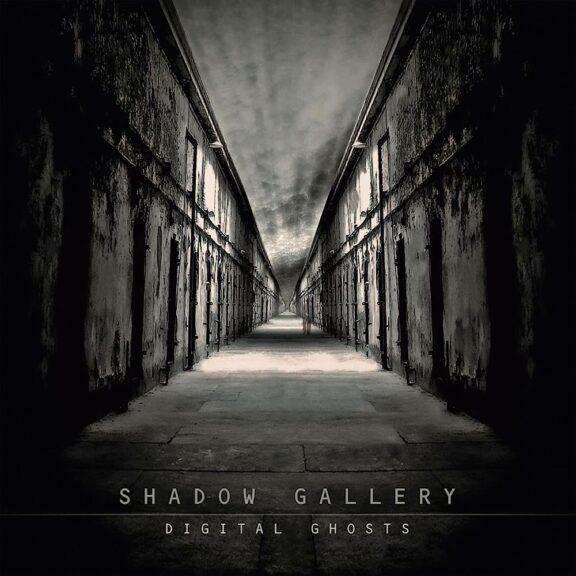Recensione: Shadow Gallery
«The key that opens up
A thousand doors of mystery
Unlocks a basement
Full of fears»
Posso immaginare cosa state pensando. L’omonimo Shadow Gallery non è il disco più noto della band, non è il più apprezzato e probabilmente non è nemmeno il più riuscito. Ciò nonostante, fra tutti, è quello che più di ogni altro merita un posto fra i grandi classici della storia del progressive metal. Com’è possibile – si chiederà qualcuno – che un gruppo come Shadow Gallery, il gruppo sottovalutato per eccellenza, a lungo trascurato anche dagli appassionati, possa reclamare un posto fra “grandi classici” come Fates Warning o Dream Theater? Dal punto di vista della Storia del rock, il suo peso specifico non è troppo esiguo, sia per il riconoscimento commerciale, sia per l’influenza artistica?
Non è così. Proviamo a capire perché.
Siamo nei primi anni ’80. Fra le verdeggianti distese pennsilvane della Lehigh Valley comincia a girare il nome di una talentuosa cover band locale – Sorcerer. Ne fanno parte Mike Baker, Carl Cadden-James, Ron Evans, John Coonie. Nel loro repertorio, Rush e Yngwie Malmsteen: per una formazione in erba, non c’è nulla di meglio per farsi un po’ di male. Dopo qualche tempo Evans cambia giro. L’eredità della sua chitarra è contesa fra Brendt Allman e Chris Ingles. La spunta il primo, e Ingles ripiega sulle tastiere: sarà un ripiego di lusso. Già che c’è, Allman si inventa un nuovo moniker, pescandolo direttamente dalle pagine della graphic novel ‘V For Vendetta’. È il 1985 e sono ufficialmente nati gli Shadow Gallery.
I nuovi arrivati portano nuova linfa e nuove idee. Poco alla volta i classici Rush e Malmsteen escono dal repertorio live per far spazio a brani originali. Comincia a prendere forma un demo di otto tracce, che passerà fra le mani di numerosi produttori discografici. Ma il mercato ha abbassato la saracinesca. Il metal classico si sta avviando sul viale del tramonto, dalle parti del progressive è già notte fonda: i primi anni ’90 vorranno saperne solo di house, grunge, hip-hop. Per grazia divina, c’è ancora qualcuno che la pensa diversamente. Mike Varney è un reduce della vecchia guardia con un chiodo fisso: far sorgere una nuova alba sulla scuola dei seventies. Quando si trova quel demo sulla scrivania, non crede ai propri occhi – non crede alle proprie orecchie. Pochi giorni dopo una telefonata inattesa richiamerà la band dalle vacanze. Il 21 agosto 1991 Shadow Gallery firma per Magna Carta.
Non c’è tempo per produzione o mastering professionali: Varney ha appena pubblicato il debutto di un’altra prog band di belle speranze e vuole dargli immediato seguito. Il demo viene pubblicato così com’è, senza alcun ritocco sui suoni: quello che gli Shadow Gallery registrano in studio è ciò che il pubblico ascolta. Nato e cresciuto in garage, l’album ha lo splendore di un diamante grezzo. Ma è il 1992, e tutto ciò che nella scena metal osa definirsi progressive viene oscurato dall’esuberanza giovanile di una talentuosa band newyorkese, destinata a farsi guida del movimento per gli anni a venire. ‘Shadow Gallery’ non ha lo stesso carisma universale di ‘Images And Words’, né la stessa risonanza mediatica. Ciononostante aprirà una via d’accesso al progressive metal compatibile se pur diversa da quella di Dream Theater. E di Fates Warning.
Fino al 1992, in realtà, di progressive metal si parla ancora poco. Nel Nuovo Continente si è creato un laboratorio di idee interessante, con la scena techno-thrash che si abbandona a voluttuose sperimentazione ipertecniche e quella U.S. power che lavora di fino su arrangiamenti e strutture. Fatte salve poche eccezioni (Fates Warning, Psychotic Waltz) i ponti verso la tradizione prog ’70 sono ancora sottili. Gli Shadow Gallery però appartengono a un’altra scuola. La memoria degli anni verdi, spesi a suonare rock n’ Rush, non si è estinta, Ora però lo sguardo mira di qua dall’oceano, verso la fortezza NWOBHM, i neoclassicismi di Malmsteen, le sinfonie degli Yes, la coralità dei Queen, la psichedelia dei Pink Floyd.
Il risultato? Qualcosa di nuovo.
Fra i membri fondatori, la mente creativa è Cadden-James. John Cooney si limita ormai a contribuire da esterno con qualche intervento alle percussioni – gli oneri di batterista toccheranno a Ben Timley, alias Alesis HR-16, alias una drum machine (sarà l’eccellente programmazione, sarà la qualità audio deficitaria, ma la mancanza di una mano umana alle pelli si nota appena) – al microfono invece un Mike Baker in rampa di lancio interpreta con il piglio del veterano linee vocali scritte per lui dallo stesso Cadden-James: il tandem è destinato a diventare uno dei marchi di fabbrica della Galleria delle Ombre. Decisivo sarà pure il contributo dei non-più-nuovi arrivi, Ingles e Allman. Tocca a loro a unire le forze per forgiare le linee strumentali per tre dei sette brani in scaletta – e non brani da poco. Al duo Allman/Ingles, per dirne una, appartiene la firma sulla monumentale suite conclusiva, ‘The Queen Of The City Of Ice’. Rari anche nella storia del progressive i brani capaci di competere, per fluidità e continuità della struttura, con questo piccolo gioiello di romanticismo artico – una vera ode d’amore, cantata da un flauto degno dei migliori Camel, che s’innalza piano in un tenue gioco di cori e contrappunti verso remote vette innevate. Magistrale l’interpretazione di Baker che conduce al secondo chorus, la cui ultima nota di malinconia è il preludio della fine che verrà. E infatti, a metà dell’ottavo minuto, ecco la caduta. Le tastiere aprono il certame strumentale: la città dei ghiacci si scioglie in un oceano di lacrime, mentre chitarre e tasti d’avorio si affrontano in un accanito duello senza esclusione di colpi. Tocca alla voce narrante di Gary Sloyer riprendere le fila e consegnare il testimone al nostalgico ritorno di voce e cori – gruppi come i Savatage ci metteranno ancora qualche anno prima di pensare qualcosa di simile – sfumando in un finale di inaudita delicatezza.
Se ‘The Queen’ da sola è già una killer track, le sei sorelle non si accontentano di un ruolo subalterno. ‘Dance Of Fools’ aveva aperto le danze con una sarabanda paradigmatica degli Shadow Gallery a venire: avvolgenti melodie pomp, rapide scorribande soliste e maestosi cori di scuola Queen. Poco oltre una ‘Mystified’ sofferta e rancorosa chiuderà i conti con le ballad strappalacrime delle decade precedente: Baker si chiude in un ossessivo dialogo col coro, negando il climax a un refrain che trova riscatto solo nell’orgoglioso solo delle sei corde. Su entrambi i pezzi, ancora la firma di Ingles e Allman. Quest’ultimo pone il sigillo anche sulla gagliarda ‘Questions At Hand’, brano seminale tanto dal punto di vista lirico quanto da quello strumentale per gran parte del techno-progressive che verrà. In confronto, l’approccio al songwriting di Cadden-James suona assai più melodico ed equilibrato. ‘The Final Hour’ rende omaggio ai sentieri neoclassici battuti in gioventù, fra assolo fulminanti e solenni rallentamenti, mentre ‘Darktown’, scritta a quattro mani con lo stesso Allmann, si erge fra le vette dell’album, preparando la via a pezzi da novanta come ‘Cristalline Dreams’ e ‘Warcry’. I vorticosi testa a testa fra tastiere e chitarre che faranno la gloria dei futuri Shadow Gallery sono già presenti, così come quella peculiare verve epica che sarà filo conduttore di molti, se non tutti i pezzi più riusciti della band. E del resto si sa, come Cadden-James mette mano al flauto, inizia la magia. Così è nel capolavoro (no, l’appellativo non è sprecato) ‘Say Goodbye To The Morning’, senza troppi complimenti uno dei migliori pezzi mai scritti dagli Shadow Gallery. Non a caso nasce dallo sforzo comune di tutte e tre le menti creative della band, Cadden-James/Allman/Ingles, portando in trionfo un Mike Baker semplicemente titanico sul maestoso refrain. Per consegnare il brano alle antologie basterebbe il solo epilogo, con quel devastante unisono strumentale che corre a immolarsi in uno stop n’ go mozzafiato, prima che l’ultimo, superbo refrain si scolpisca definitivamente nel cuore a caratteri di fuoco.
«Say goodbye to the morning
or rely on this warning
it’s not over when you die
so look out»
Ciò che gli Shadow Gallery decideranno di costruire negli anni si distaccherà in parte dal loro primo disco, ma troverà qui le sue imprescindibili fondamenta. Già con ‘Carved In Stone’, per chi scrive apice della loro discografia e monumento del progressive anni ’90, la band preferirà dare spazio alla poetica della melodia destinata a svilupparsi ulteriormente e fare la fortuna di ‘Tyranny’ e ‘Room V’. Resterà uno stile tecnicamente evoluto e una sensibilità per il lato maggiormente comunicativo del prog metal, capace di interpretare come nessun altro le imbeccate melodiche dello spartiacque ‘Images And Words’. Ma come si è già detto e ripetuto, ‘Shadow Gallery’ vale un discorso a sé, che non ha nulla a che vedere con Dream Theater o chicchessia. Avulso da stereotipi, quasi senza volere anticipa molto di ciò che gruppi come Symphony X, Threshold, Mind’s Eye o, per stare su nomi più freschi, Circus Maximus e Seventh Wonder avrebbero fatto nel corso delle rispettive carriere. Così, da un lato ‘Shadow Gallery’ fornisce un’alternativa sperimentale al progressive mainstream a venire, destinata a essere riscoperta solo molti anni dopo. Dall’altro conduce a compimento in modo affatto personale ciò che band come IQ e Pallas avevano tentato di raggiungere negli anni ’80 e cui forse solo i Marillion si erano realmente avvicinati: la resurrezione del progressive, quello vero, trasfigurato nelle forme della scuola hard n’ heavy.
Oggi, anche grazie a internet e al passaparola, gli Shadow Gallery sono una delle formazioni maggiormente autorevoli e apprezzate del metal melodico più ricercato. Si dice spesso che non abbiano inventato nulla, ma l’influenza che esercitano sulle nuove generazioni del progressive è un fatto incontestabile. Molti i fan e i musicisti che hanno riscoperto a posteriori le loro prime opere, ne sono rimasti affascinati e ora le tengono come reliquie preziose. Così, dopo tanti anni, forse è giunto il momento di tributare il giusto onore a questo diamante grezzo, scoperto quasi vent’anni orsono da un visionario produttore della Pennsylvania, e a chiamarlo col titolo che gli spetta – Classico.
Nel 1992 per volontà dei suoi autori questo album è stato dedicato a una delle Grandi Voci della musica: Freddie Mercury.
Oggi, 29 ottobre 2009, desidero nel mio piccolo dedicare questa recensione a un’altra delle Grandi Voci della musica: Mike Baker.
«Time survives and all that’s left is dust
We respond to the music of the earth
Our hands touch and to its tune we dance
Is our kiss just sand thrown to the wind
Where does it go?»
Riccardo Angelini
Tracklist:
1. The Dance of Fools
2. Darktown
3. Mystified
4. Questions at Hand
5. The Final Hour
6. Say Goodbye to the Morning
7. The Queen of the City of Ice