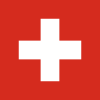Recensione: Singularity
Svizzera. 2005. Ginevra: Stortregn. Quattro membri: Romain (voce e chitarra), Johan (chitarra), Duran (basso) e Sam (batteria). Un demo (“Stortregn”, 2007), un EP (“Devoured by Oblivion”, 2008), tre full-length (“Uncreation”, 2011; “Evocation of Light”, 2013; “Singularity”, 2016).
Una band specificamente dedicata a un genere spurio: il blackened death metal. Behemoth, tanto per dare un nome a coloro che, fra i primi, e meglio, hanno profuso la propria carriera nella definizione dei dettami stilistici di base per configurare correttamente la foggia musicale di cui trattasi.
Foggia che, teoricamente, non dovrebbe esistere: black e death sono stili-madre assolutamente diversi per una quantità enorme di dettagli. Dalle filosofie primigenie che ne hanno dato il la e quindi dalle tematiche affrontate, dai luoghi di nascita degli ensemble progenitori; dalle interpretazioni vocali (screaming/growling); dai riffing. E tanto altro ancora che non basterebbe un tomo enciclopedico, per elencarle.
Malgrado ciò, black e death, o death e black, che dir si voglia, hanno qualcosa d’indefinibile, in comune, che li radica nel medesimo lembo di terra di crescita. Un qualcosa di cupo, oscuro, tenebroso. Qualcosa che ha un termine preciso per essere individuato, fra gli infiniti stati dell’animo umano: la misantropia. L’istinto d’isolamento dalla società degli esseri umani, improntata su valori del tutto effimeri. Caduchi. Superficiali. Populisti. Demagogici. Quando, spesso e volentieri, non intervengono quegli istinti bestiali che migliaia di anni di evoluzione della specie dovevano cancellare. Così non è stato, e sia il black, sia il death, a ciò si ribellano con l’unico modo che è loro concesso: l’aggressione musicale. Per formare quell’anello sferico in grado di tenere fuori il Mondo, con le sue atrocità. Le sensazioni, le emozioni, le pulsioni che sgorgano dal cuore di chi si sente inserito in tale popolazione di misantropi, allora, si trovano proprio qui, nel blackened death metal. Che, rivelazione finale, riunisce il vigore del death alla malinconia del black.
Allora, “Singularity” diviene un simbolo di (quasi) perfezione, per tutto quanto più su scritto. Con, in più, l’uso costante e presente della melodia, atta a sottolineare quella latente emozione, anch’essa sopra citata, che, come un triste sudario, avvolge le note di song dall’eccellente valore artistico come, per esempio, ‘Crimson Depths’ o, meglio ancora, la stupenda, dolce ma possente, struggente ‘Aurora’.
Il pathos intimista che gli Stortregn si portano dietro a ogni dove, nondimeno, non deve ingannare. Lo screaming/growling è straziante, a volte scellerato, spesso drammatico. Le chitarre dello stesso Romain e Johan, arabescando accordi arcani, erigono, grazie al loro riffing stentoreo, la classica muraglia di suono. Invalicabile. Con il bombardamento alle basse frequenze di Duran a preparare il terreno alle micidiali incursioni dei blast-beats di Sam, che spingono il sound del quartetto oltre la superficie conosciuta della sfera del suono (‘Never Ending Singularity’).
Svizzera. 2016. Ginevra: Stortregn. Dalla Nazione europea multietnica per eccellenza, giunge l’unitarietà. Quella che connota in maniera mirabile il blackened death metal.
“Singularity”: per i blackster, per i deathster.
Daniele D’Adamo