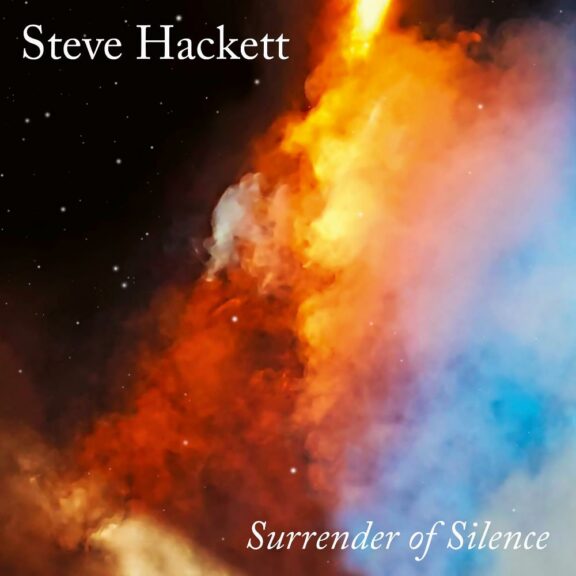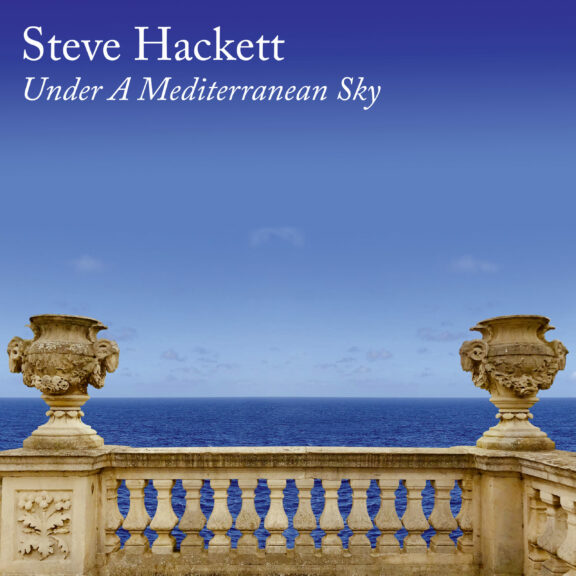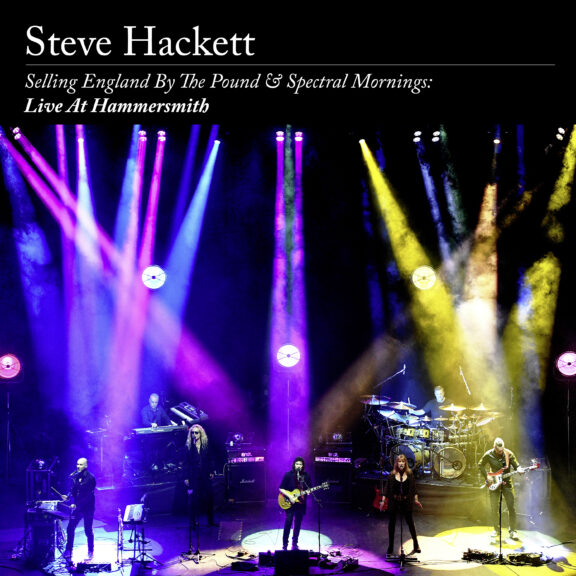Recensione: Spectral Mornings

Il mondo dell’arte, oltre alla sua innata bizzarria, viene pennellato da forti tinte di imprevedibilità, che talvolta si traducono in imponderabili “magnifiche sorti e progressive” atte a collocare una rappresentazione artistica nella bacheca dei capolavori.
Era il 1979 quando il genio di Steve Hackett pubblicò, con Charisma Records, l’incredibile “Spectral Mornings”, un disco la cui meraviglia, che lo colloca nella soprascritta bacheca, è avallata dall’aver sconfitto il vincolo delle catene del tempo per essere riconosciuto, ancora oggi e lo sarà per sempre, come un autentico splendore musicale. Il tempo, proprio quel tempo, la fine degli anni ’70, quando vedevano la luce un insieme di dischi dei più variegati, in un clima, tarato verso l’alto, di febbrile attività musicale, dove la concorrenza non era mai doma ed emergere non era azione semplice.
Per Hackett questo non era un problema, tra l’altro aveva dato già prova del suo spessore lasciando i Genesis che gli assicuravano un successo planetario, per seguire quella carriera da “indipendente” che lo porterà a sperimentare e a trovare nuove collaborazioni (per esempio con Stewe Howe nell’esperienza GTR).
“Spectral Mornings”, comunque, ebbe un discreto successo nell’anno della sua uscita, probabilmente perché Hackett veniva ancora etichettato come l’«ex chitarrista dei Genesis» (in realtà questo era il suo terzo album solista) o perché lui è sempre stato restio alla luce dei riflettori o, più verosimilmente, perché era un lavoro troppo avanzato e variegato per poter essere compreso fino in fondo; infatti in questo lavoro troveranno una felice commistione tradizione e sperimentazione.
Una rivalutazione postuma (ecco l’”imprevedibilità” di cui si faceva menzione all’inizio), dal punto di vista meritocratico e morale, rappresenta la giusta nemesi storica per questo lavoro incredibile, che tra i tanti meriti ha quello di risultare “visionario”, in grado cioè di proiettare l’ascoltatore in medias res, nel clima, nell’ambientazione e nelle atmosfere dei brani. Il “genio visionario” di Hackett prende per mano l’ascoltatore per accompagnarlo in un immaginario e immaginifico viaggio tra atmosfere orientali (The Red Flower of Tachai Blooms Everywhere) e malinconicamente spagnoleggianti in cui ci si perde in un clima onirico e privo di tempo (Lost Time in Cordoba), passando con ironia musicale dalle locande tipiche degli anni Venti/Trenta in cui emergono le difficoltà giornaliere (The Ballad of the Decomposing Man) fino a calarsi nei meandri più oscuri e metaforici del tempo, della storia, della guerra e delle leggende (Clocks – The Angel of Mons).
Di questo viaggio, che porta l’ascoltatore in una differente dimensione spazio/temporale, si ha già un’intuizione nella bellissima copertina dell’album, opera di Kim Poor, che sfuma il volto di Hackett per incastonarlo in una entità poco definita e concreta, a tratti fantastica, in piena aderenza con quelli che sono i numerosi passaggi del disco. Tutto il lavoro si sviluppa, inoltre, senza rinunciare a quella dote che ha sempre caratterizzato il percorso di Hackett: l’eleganza. Infatti il maestoso inizio di tutto l’album (Every Day, brano dedicato al mondo della dipendenza) ci consegnerà in pochi minuti l’ascolto di un assolo la cui eleganza potrebbe essere eletta a stilema universale della musica.
Entrando nel dettaglio delle tappe del viaggio onirico nelle mattine spettrali l’orecchio dell’ascoltatore subito si ammalia ascoltando Every Day. Con un intro davvero singolare in quanto a spensieratezza, ci troviamo più volte di fronte a cambi imprevedibili di tonalità. Bellissimo l’inserto di parti soliste in plettrata alternata durante la prima parte. Particolarissimo è il timbro vocale di Pete Hicks e anche molto suggestivo seppur con un testo molto breve ma intenso scritto da Hackett (con il verso “Cleopatra’s Needle conquered fear” l’asticella del cantautorato si alza tantissimo).
Il tema principale è di incredibile impatto emotivo (accennato inizialmente ½ tono sopra durante il verse), fa da controcanto un secondo bridge, poi a seguire si può ascoltare una delle più belle melodie di tutti i tempi (spettacolare l’effetto di mantenerla intatta e prolungata durante il fade out del brano, chi ha mai ascoltato Candelight Fantasia dei Symphony X sa esattamente di cosa si sta parlando).
In The Virgin and the Gypsy le lead vocals sono a opera dello stesso Hackett e il brano è ispirato all’omonimo romanzo di D.H. Lawrence; nel brano c’è un largo uso di tastiere del grande Nick Magnus (qui anche al clavicembalo) nella parte centrale, con inseguimenti davvero fiabeschi tra chitarra 12 corde e flauto.
In Red Flower of the Tachai Blooms Everywhere notiamo l’axeman alle prese con il koto giapponese, tipico strumento della tradizione nipponica. Armonie orientali riecheggiano e si fanno largo all’interno di quello che fino a questo punto si è rivelato un disco di grande classe. Segue il lavoro certosino di John Shearer alla batteria con Clocks – The angel of Mons, dove l’intro cupo e pieno di suspense esalta quella che sarà l’evoluzione finale in grado di generare forti emozioni.
In The Ballad of Decomposing Man le atmosfere festose e folk quasi da Oktoberfest si uniscono alla classe innata del walkin bass di Dick Cadbury.
Questo brano riserva un incredibile viaggio mentale e rappresenta una vera gemma a tal punto da essere una perfetta opener alla successiva Lost Time in Cordoba. Qui una chitarra lontana duetta col flauto traverso di John Hackett (fratello di Steve) inizialmente facendo lo “scherzo” ad alcune composizioni di Giuseppe Brescianello, noto compositore barocco italiano. Ipnotica la parte centrale, con arpeggi ostinati dove non c’è nulla fuori posto ed è qui che la vena più spagnoleggiante di Hackett si fa largo. Ogni nota conferisce un preziosismo al brano, armonici naturali compresi, che rappresentano un immenso valore aggiunto. La produzione ovviamente non aiuta ad enfatizzare determinati passaggi alla chitarra sei corde, ma è chiaro che qui siamo davanti all’era “post Genesis”.
L’intro di Tigermoth è di natura epica e contiene sfuriate chitarristiche a opera dell’inventore del tapping (o almeno così narra la leggenda…) che lasciano spazio alle keys spettrali (il titolo funge da ispirazione…) al limite della psichedelia pinkfloydiana (e qui i riferimenti alla precedente Clocks potrebbero dire molto). Al minuto 04:00 ex abrupto si ascolta il monumentale “Just like his old father before him, Who served in the great war would sing we’re proud to server Kaiser or King”, a opera del sempre puntuale Pete Hicks, e questo sembra un momento di altissima cinematografia.
Chiude il disco la pomposa Spectral Mornings, title-track strumentale, nel corso della quale Steve Hackett non solo dimostra il suo amore per le dinamiche e per le evoluzioni musicali, ma dà grande prova di lirismo e ispirazione, quasi a volerci regalare una chiusura in stile “titoli di coda”. Innegabilmente viene alla mente il ricordo delle splendide Firth of Fifth dei bei tempi che furono, con un occhio alle innovazioni per l’epoca. Pur non essendo famoso come strumento, per il sustain infinito, la chitarra di Steve Hackett in questo caso è fuori dal coro e sembra qui avere timbriche più violinistiche.
“Spectral Mornings” rappresenta un riferimento di rara fattura nel panorama del rock progressivo, un album che crea dipendenza e la cui bellezza invoglia l’ascoltatore a volerlo sempre risentire per goderne della bellezza e delle innumerevole sfumature, che ogni volta destano meraviglia. Un disco che valica ogni qualsivoglia classificazione di genere e dà una frustata al livello musicale medio, raggiungendo livelli per molti inarrivabili.