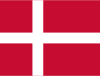Recensione: The Art of Evil
65
Giungono all’agognato traguardo del primo full-length, dopo sei anni di carriera, i danesi Theory, quintetto dedito a quel sound ibrido che va sotto la dubbia etichetta di “progressive power metal”. Fondato nel 2011 dal chitarrista Odin L. Madsen (nomen omen!) e dal batterista Martin Kilic (entrati in contatto suonando in un’imprecisata band technical death metal), il gruppo s’ispira a nomi quali Symphony X, Nevermore e Dream Theater; Aspera e Pagan’s Mind aggiungiamo noi.
The Art of Evil ha preso forma negli anni che vanno dal 2013 al 2015; nel 2016 le registrazioni, lo scorso febbraio la fatidica data di release, anticipata da una massiva campagna promozionale. Un gruppo che finalmente cerca di guadagnarsi la giusta fetta di visibilità, ma, lo diciamo subito, la scommessa è stata vinta solo in parte: artwork (curato da Martin Kilic) e sound, infatti, non lasciano il segno per originalità. Non mancano, comunque, alcuni aspetti positivi per un debut, entriamo nel merito con un rapido track-by-track.
Dopo un breve intro, l’opener sfoggia un tiro melodico godibile, bilanciato da ritmiche dropped (vero leitmotiv del disco) e alcuni inserti in growl. La voce di Nicklas Sonne ricorda quella di Tobias Sammet e del più dotato Mats Levén. Le liriche sono tra l’epico e il bellico (“This invasion marching through the lands/is a sign of the end”), il coro a metà brano non è proprio ficcante (e recita un trito “Hail – Rise – Fight !”), va meglio la parte solistica con buoni intrecci chitarristici e qualche concessione dissonante. “Sea of damnation” (titolo alla Symphony X) continua il discorso senza sorprese: I testi sono più smagati che mai (“Life inside /a world of closing doors/I feel caught, /caught in the devil’s claws”) e un filo prevedibili, ma facilmente memorizzabili. Compare lo spettro dei grandi Fates Warning e qualche tinta araboide.
Pezzo più divertito “Demons Domain”, con concessioni rockeggianti e linee di basso vistose e taglienti. Gustosi i bending in coda. La successiva “Strangers Descent” presenta un incipit suggestivo e l’ennesima bella prova solistica, arricchita dalla presenza del prezzemolino Derek Sherinian; “Frozen”, invece, parte spigolosa e prosegue abbastanza anonima in tracklist. L’intermezzo solistico di Odin in “Liquid Order” regala emozioni, il maestro Malmsteen applaude. Peccato sia solo un minuto di pausa, poi “” non è una via d’uscita da una certa noia incipiente. Tempi in levare in “In Silence We Ride”, qualche growl e inserti di synth. Testi luciferini, d’altra parte, in “Catch-22”: “I am the fallen /I came from the sky /I’ve conquered the darkness /I am the night”. I Theory sono pur connazionali di King Diamond… Nicklas Sonne in questo caso carica troppo la parte, nei panni del principe delle tenebre risulta un filo sguaiato. Ballad umbratile, e stranamene in penultima posizione, “Our Journey” presenta testi enigmatici: “You feel no shame when you leave me dealing with the pain”. Una storia d’amore andata a cattivo fine, o qualcosa di più? L’epilogo è affidato al brano più lungo in scaletta. Nei suoi 6 minuti “Skies Are Falling” non convince. Le ritmiche richiamano i già citati Nevermore, le liriche inneggiano a un’apocalisse tutt’altro che catartica.
The Art of Evil ha preso forma negli anni che vanno dal 2013 al 2015; nel 2016 le registrazioni, lo scorso febbraio la fatidica data di release, anticipata da una massiva campagna promozionale. Un gruppo che finalmente cerca di guadagnarsi la giusta fetta di visibilità, ma, lo diciamo subito, la scommessa è stata vinta solo in parte: artwork (curato da Martin Kilic) e sound, infatti, non lasciano il segno per originalità. Non mancano, comunque, alcuni aspetti positivi per un debut, entriamo nel merito con un rapido track-by-track.
Dopo un breve intro, l’opener sfoggia un tiro melodico godibile, bilanciato da ritmiche dropped (vero leitmotiv del disco) e alcuni inserti in growl. La voce di Nicklas Sonne ricorda quella di Tobias Sammet e del più dotato Mats Levén. Le liriche sono tra l’epico e il bellico (“This invasion marching through the lands/is a sign of the end”), il coro a metà brano non è proprio ficcante (e recita un trito “Hail – Rise – Fight !”), va meglio la parte solistica con buoni intrecci chitarristici e qualche concessione dissonante. “Sea of damnation” (titolo alla Symphony X) continua il discorso senza sorprese: I testi sono più smagati che mai (“Life inside /a world of closing doors/I feel caught, /caught in the devil’s claws”) e un filo prevedibili, ma facilmente memorizzabili. Compare lo spettro dei grandi Fates Warning e qualche tinta araboide.
Pezzo più divertito “Demons Domain”, con concessioni rockeggianti e linee di basso vistose e taglienti. Gustosi i bending in coda. La successiva “Strangers Descent” presenta un incipit suggestivo e l’ennesima bella prova solistica, arricchita dalla presenza del prezzemolino Derek Sherinian; “Frozen”, invece, parte spigolosa e prosegue abbastanza anonima in tracklist. L’intermezzo solistico di Odin in “Liquid Order” regala emozioni, il maestro Malmsteen applaude. Peccato sia solo un minuto di pausa, poi “” non è una via d’uscita da una certa noia incipiente. Tempi in levare in “In Silence We Ride”, qualche growl e inserti di synth. Testi luciferini, d’altra parte, in “Catch-22”: “I am the fallen /I came from the sky /I’ve conquered the darkness /I am the night”. I Theory sono pur connazionali di King Diamond… Nicklas Sonne in questo caso carica troppo la parte, nei panni del principe delle tenebre risulta un filo sguaiato. Ballad umbratile, e stranamene in penultima posizione, “Our Journey” presenta testi enigmatici: “You feel no shame when you leave me dealing with the pain”. Una storia d’amore andata a cattivo fine, o qualcosa di più? L’epilogo è affidato al brano più lungo in scaletta. Nei suoi 6 minuti “Skies Are Falling” non convince. Le ritmiche richiamano i già citati Nevermore, le liriche inneggiano a un’apocalisse tutt’altro che catartica.
Concluso l’ascolto resta una sensazione di già sentito, il sound dei Theory eccede in quadratezza e manca di un minimo d’eclettismo. Tutto suona moderno, sì, ma non si riesce a rilanciare né il prog, né il power, due generi che vivono un momento di stasi. In realtà per i danesi, sarebbe meglio parlare di un heavy metal venato di un pizzico di virtuosismo. La produzione è satura, le chitarre risultano invasive in ambito ritmico, così le linee vocali, troppo sguaiate a tratti. Detto ciò, il platter è oggettivamente ben suonato e curato: anche i testi, sebbene non originalissimi, acquistano un senso se pensiamo al tema dell’arte del male, il concept in senso lato che lega le 12 tracce in scaletta. Per ora è una sufficienza abbondante, in futuro ci aspettiamo di più da questa giovane band.
Roberto Gelmi (sc. Rhdamanthys)