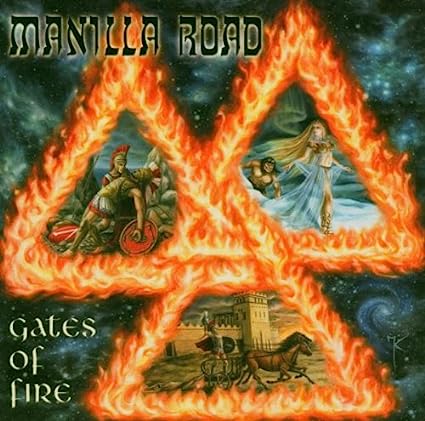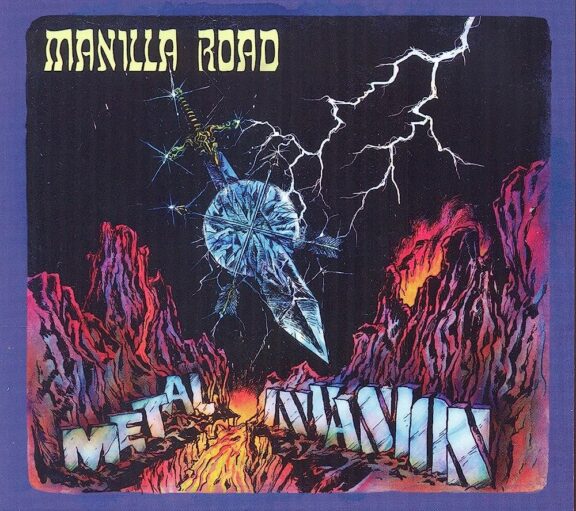Recensione: The Blessed Curse
Cos’è la coerenza? La capacità di rimanere fedeli a sé stessi e portare avanti il proprio discorso senza necessariamente ripetere sempre le stesse cose, ma variando la forma della propria proposta pur mantenendo intatto lo spirito che la anima. È questo che i Manilla Road hanno sempre fatto, lasciando ad altri le accattivanti mode passeggere o le baracconate strappa-consensi per dettare le regole della vera epica messa in musica, tragica e sacrale, e proporre all’umanità qualcosa di diverso, di primordiale e al tempo stesso sopraffino. Per farsi cantori della grandezza.
Diciassette album, dal 1980 ad oggi: diciassette capitoli della personale epopea della band di Wichita, per la verità non tutti proprio memorabili, plasmati dalla mente visionaria di Mark Shelton, che con questo “The Blessed Curse” ci ricorda perché l’epic metal non è cosa da tutti. Pubblicato a due anni dall’ottimo “Mysterium”, album forse penalizzato solo da una formazione non ancora ben rodata, “The Blessed Curse” è un corposo album incentrato sull’epopea di Gilgameš, la più antica saga epica a noi pervenuta. A dire la verità esiste anche un secondo dischetto, denominato “After the Muse”, ma ci arriveremo poi.
Il compito di aprire le danze è affidato alla title-track, introdotta dal classico arpeggio di scuola Shelton: prescindendo per un attimo dal valore intrinseco del brano alzo il pollice per il bilanciamento dei suoni, capace di conferire al gruppo la sua aura rituale e polverosa senza per questo sacrificare qualche strumento (uno a caso: il basso); anche la produzione, pur senza essere proprio cristallina (diciamo così), segna comunque un grosso passo avanti rispetto a certe uscite del passato anche recente. Chiusa questa breve ma doverosa parentesi torniamo alla traccia d’apertura che, com’era lecito aspettarsi, snocciola in cinque minuti scarsi tutto ciò che troveremo in questo primo dischetto: sezione ritmica arrembante e puntuale, passaggi sontuosi alternati a riff scanditi e, a condire il tutto, il solismo ipnotico di quel furbacchione di Mark “the Shark”.
Un riff d’altri tempi introduce “Truth in the Ash”, traccia veloce in cui la batteria di Andreas la fa da padrone, lasciato libero di duellare con la chitarra di Shelton e, addirittura, di prevaricarlo in più di un’occasione quando la canzone lo richiede. Concluso questo breve momento di ricreazione si torna tutti in riga e si rallentano i ritmi per passare ad uno dei gioiellini dell’album, “Tomes of Clay”, un brano lento e ipnotico giocato su una melodia mediorientale tanto semplice quanto suggestiva, il tutto impreziosito dall’accoppiata Shelton/Patrick alla voce. L’improvviso assolo contribuisce a mantenere l’atmosfera rarefatta del pezzo, prima di fondersi con la melodia portante tornata in primo piano e sfumare quindi nel finale più ritmato. Gran pezzo. “The Dead Still Speak” torna ai riff zanzarosi e ai tempi più frastagliati di “Truth…”, per un altro brano che profuma insistentemente degli assalti dei vecchi tempi, durante i quali la voce si fa solenne per intonare antiche minacce.
Altra canzone, altro cambio di ritmo: “Falling” fluttua dolce nell’aria, sostenuta dalle correnti sonore create dal gruppo e danzando tra gli intrecci delle due voci. L’arrivo del solo di Mark accompagna l’ascoltatore fino alla conclusione del brano aprendo la strada alla successiva “King of Invention”, in cui si torna a ritmiche più corpose e riff duri, mentre il chitarrismo del solito Shelton si fa nervoso e incalzante durante le brevi incursioni soliste. “Reign of Dreams” prosegue lo stesso discorso con riff pennellati e vocione cattivo, tutto sorretto dal basso pulsante e sanguigno di Josh e una batteria che tanto mi ha ricordato il buon Randy Foxe dei tempi che furono. Con “Luxiferia’s Light” l’incedere si fa più compassato e minaccioso, per un pezzo ossessivo e cadenzato che lascia traspirare qualche spiffero di ossigeno solo in concomitanza con il ritornello, unico momento d’aria in una traccia dominata da una sezione ritmica opprimente e muscolare. Il discorso non cambia neanche con la successiva “Sword of Hate”, altro pezzo di alta scuola dai ritmi bassi ma non per questo meno pesanti e minacciosi, impreziosito da una batteria che continua a spadroneggiare e da un assolo dello squalo che si tinge di maligna solennità nel finale. Il primo album si chiude sulle note di “The Muses Kiss”, introdotta da un arpeggio raccolto che si trasforma in una melodia intimista e rassicurante, ninnananna sepolcrale ed ossianica che si fa via via più avvolgente con l’ingresso dei vari strumenti, salvo poi spezzare la melodia e ricominciare da capo sotto il segno del solismo dilatato ed ipnotico del lìder màximo, ancora una volta supportato da una batteria che enfatizza solo quando deve, che accompagna l’ascoltatore fino alla fine di un album ostico ma notevole, capace di catturare quasi da subito ma che rivela i suoi segreti dopo un maggior numero di ascolti più attenti. Mi si permetta, in chiusura di questa prima parte, di alzare il pollice in favore di Bryan Patrick, il cui affiatamento e la cui capacità di sacrificio vocale in nome della tradizione del gruppo mi ha più volte impedito di distinguere il suo vocione da quello più nasale del vecchio squalo. Chapeau per questo e per molti altri motivi che non sto qui ad elencare.
Si arriva adesso alla seconda parte di questa recensione, che tratta il contenuto del secondo disco, noto come “After the Muse” e che raccoglie composizioni slegate dal concept precedente, nonché piuttosto spiazzanti per alcune orecchie. Si tratta, infatti, di brani completamente acustici e dal tono molto più rock-oriented, tendenzialmente più rilassati e romantici, che però permettono di capire meglio il bagaglio musicale di Shelton e l’origine di certe sonorità che abbiamo imparato ad amare nell’opera dei suoi Manilla Road. Poche concessioni alla musica elettrica (qualcosa si sente in “After the Muse” e nella lunga suite) in favore di arpeggi più contenuti e rimandi a melodie velatamente southern, le quali si intrecciano a lunghe e più dilatate escursioni soliste come impone la tradizione degli anni ’70 da cui i Manilla Road, non scordiamoci, sono partiti. Esempi perfetti sono le tracce “Life Goes On”, soprattutto nella sua ipnotica seconda parte che segue un inizio da classica ballatona, e “In Search of the Lost Chord”, più intima e tutta giocata su un arpeggio semplice ma efficace. Sono presenti anche due versioni di una canzone, “All Hallows Eve”, inizialmente composta nel 1981 e dimenticata tronca, poi ritrovata e completata nel 2014 con l’aggiunta degli ultimi minuti dalla formazione attuale beneficiando di una produzione più moderna. Il pezzo mescola rock e country a passaggi più psichedelici e non è affatto male, sebbene a mio avviso si dilunghi un po’ troppo nella parte iniziale forse troppo prolissa. Pollice altissimo, invece, per “Reach”, che sembra partire come un tipico brano southern, salvo poi cambiare direzione poco prima del terzo minuto per acquisire un’accezione più solenne e rituale, complici l’azzeccatissimo cambio d’atmosfera nell’arpeggio che diviene molto più inquietante e, soprattutto, una prestazione vocale da pelle d’oca. Sette minuti che esigono reverenza. E la ottengono.
Al termine di questa recensione lunga ma al tempo stesso insufficiente, cosa resta di questo doppio album? Innanzitutto l’ennesima conferma dell’apparente eternità della vena compositiva di un personaggio come Mark Shelton, tornato negli ultimi anni in grande spolvero; in secondo luogo un album decisamente superiore alla media, anche se meno metallico e più acustico di quanto ci si sarebbe aspettati; infine la consapevolezza che anche stavolta i signori incontrastati dell’epic metal hanno colpito al cuore.
Stefano Usardi