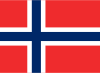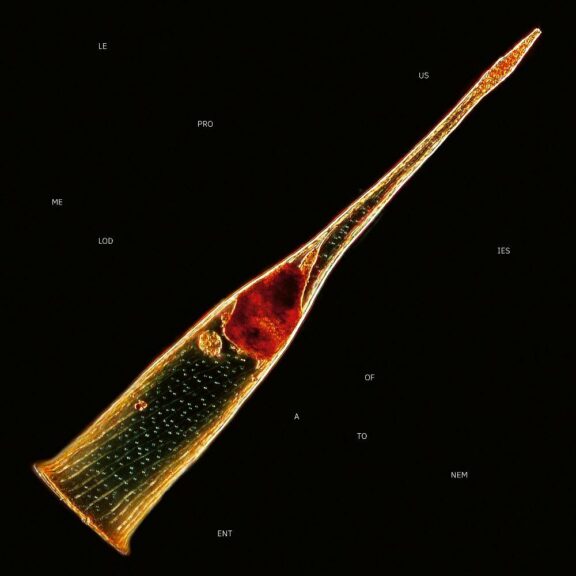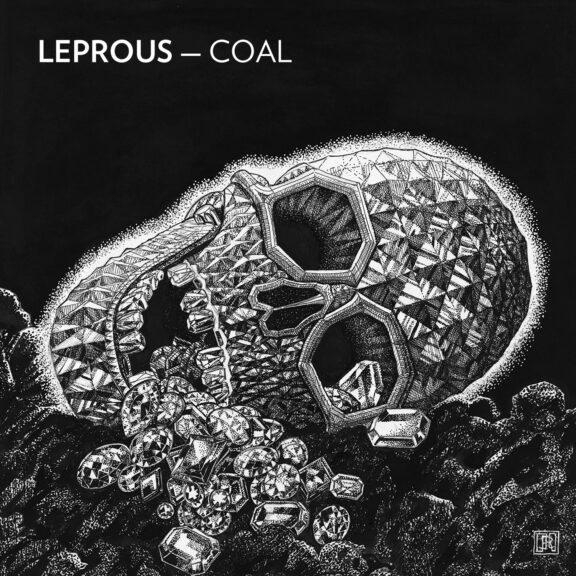Recensione: The Congregation
The Congregation, nuovo parto dei norvegesi Leprous, è indubbiamente uno degli album più attesi del 2015 in ambito prog. Il precedente Coal fu un mattone tosto da digerire e divise sia gli addetti ai lavori che i fan, ma partiamo dal principio. Omettiamo Aeolia e il bellissimo Tall Poppy Syndrome, arriviamo al 2011 e a quel Bilateral che scosse il mondo a tal punto da essere considerato uno dei dischi migliori del decennio nel suo ambito (almeno per noi). Un capolavoro di quella portata, in genere, risulta difficile da bissare anche per chi l’ha concepito; ecco quindi arrivare la calza col carbone e mai titolo fu più adatto. Se Bilateral era un calderone di idee tale da riuscire a dare una personalità a se stante ad ogni pezzo che proponeva, il suo successore si rivelò quasi l’esatto contrario dilatando all’impossibile e proponendo dimensioni oniriche non troppo riuscite. Furono davvero pochi i momenti di lucidità nel disco e per molti si rivelò una cocente delusione. Per capire The Congregation, e di conseguenza questa disamina, è corretto dire al lettore di provare a non usare Bilateral come metro di paragone, perché nel caso non ci sarebbe nulla da scrivere.
La prima novità in casa Leprous è il cambio del batterista: fuori Tobias Ørnes Andersen e dentro il giovanissimo e talentuoso Baard Kolstad, che ormai è ovunque come la gramigna. Rimane vacante il posto di bassista, qui interpretato da un session (Simen Borven).
Il compito di aprire le danze viene affidato a The Price, singolo apripista dell’album che si rivela un buon pezzo in grado di creare il giusto equilibrio fra tensione e melodia. Le successive Third Law, Rewind e The Flood alzano l’asticella della qualità e offrono all’ascoltatore del prog di altissima fattura. La prima facilmente assimilabile anche in seguito a pochi ascolti; la seconda a tutti gli effetti è la traccia migliore del lotto e la terza si dipana per quasi otto minuti pur essendo costruita su un riff di due note di numero, facendolo ottimamente. Le prime conclusioni che si possono trarre da questo “poker” sono praticamente quelle che spiccheranno alla fine dell’ascolto: la componente metal è totalmente sparita dalla proposta della band tranne una piccola parentesi in Rewind in cui fanno capolino pochi scream non molto convinti, il genere quindi si assesta su un prog rock con sprazzi di avant-garde e può ricordare dai conterranei Gazpacho a band ben più blasonate; la durata dei pezzi non si è per niente snellita e rimane dai 5 agli 8 minuti esclusi un paio di episodi. La voce di Einar è la componente più altalenante del disco in quanto risulta capace di tirar fuori linee vocali geniali e allo stesso tempo di infastidire esagerando con coretti tipo aa-a-a, oo-o-o, ee-e-e e via dicendo. Durante il primissimo ascolto ce li si aspetta anche e non è di certo un bene; sembra la soluzione più facile in alcuni punti con carenza di idee che andavano sfruttati meglio.
Triumphant è uno degli episodi più sintetici del disco e mette in tavola un piatto con un buon lavoro di tom e una linea vocale solida e ispirata; sale, scende ma non decolla mai, ed è concepita talmente bene da non renderlo necessario. Within My Fence è piuttosto insipida e non convince: sembra la brutta copia di Triumphant e risulta poco curata e ripetitiva. Non regge assolutamente il confronto con ciò che è stato proposto finora e passa inosservata senza lasciare segno alcuno, anche dopo tantissimi ascolti. Red porta l’ingombrante nome di un capolavoro dei King Crimson, di un fumetto e di un paio di meravigliosi film in cui vi sono 10 minuti di trama e 100 di esplosioni; l’ingombrante eredità riporta l’album a buoni livelli sostenuta da un riffing pazzesco e da sprazzi di elettronica ben dosati. Non c’è niente qui fuori posto e il pezzo è una vera e propria libidine; certo, The Congregation è si un album che risente fortemente di un’accelerazione o una variazione sul tema ma lo maschera molto bene e ne fa sentire la mancanza solo nel momento in cui la razionalità sostituisce la passione durante il lungo ascolto dell’opera.
Lungo sì, perché ci assestiamo intorno ai 70 minuti che per molti potrebbero risultare indigesti.
Slave è un altro colpo ben assestato e si rivela emozionante anche grazie a un testo davvero ben riuscito; la prestazione della band è notevole e matura specialmente in fase di arrangiamento. E’ un pezzo oscuro ma che lascia speranza, la famosa luce alla fine del tunnel; impossibile non riconoscerne la magia e l’altissimo contenuto emotivo. Moon continua con le coordinate di Slave e a questo punto il disco non sorprende più, anzi, si iniziano a percepire i primi segni di stanchezza e i primi segnali di un ritorno alla prolissità di Coal che vengono schivati con un songwriting di maggior livello e alcuni colpi di genio (vedi il finale del pezzo) che risvegliano immediatamente l’attenzione del fruitore. Ad un orecchio poco allenato il disco potrebbe qui sembrare finito e ricominciato: il riff portante di Down e praticamente identico a quello di The Price! Il pezzo nulla aggiunge e nulla toglie a ciò che finora abbiamo sentito; si tratta di un momento discreto che avrebbe goduto di miglior fortuna se fosse stato concepito sul ponte centrale, veramente notevole.
Lower chiude la tracklist ufficiale e si rivela l’inevitabile lentaccio che generalmente si ascolta durante i titoli di coda, quando ci si alza dalla sedia e ci si sposta verso l’uscita. L’ascolto quindi risulta disattento, l’orecchio è stanco e distratto e ha bisogno di ricaricare le batterie. Parliamo quindi di un pezzo di sottofondo, che forse è lì più per fare numero che chiudere seriamente; Lower è una canzone che trasmette timidezza ed è difficile capire se questo sia o no un bene. L’edizione deluxe in digipack offre un pezzo in più, Pixel, che ripete in toto le coordinate stilistiche e i riff già proposti ed è ovviamente tutt’altro che imprescindibile.
Tempo ora di trarre le conclusioni. The Congregation è un passo avanti rispetto a Coal? Si, ma non è assolutamente un passo da gigante. Il songwriting è incanalato in maniera migliore e più coerente e la band sembra iniziare a comprendere e ad essere meglio conscia dei propri mezzi e limiti. Nonostante questo rimane comunque una sensazione di incompletezza che lascia un pochino di amarognolo in bocca. The Congregation è un lavoro buono, buonissimo, a tratti eccellente, e la rabbia viene perché sarebbe bastato davvero poco a renderlo un discone: prima di tutto meno canzoni e un minutaggio più snello avrebbero di certo giovato. In secondo luogo il disco avrebbe necessitato di una qualche idea in più perché non è raro nella tracklist imbattersi in un passaggio o riff e dire: “Ma non l’hanno fatto poco fa”? L’essere monotematici paga; l’esserlo troppo danneggia. La prestazione in studio risulta cristallina assieme alla produzione che penalizza leggermente il basso e per i puristi potrebbe essere davvero troppo “pulita”, mentre la copertina sembra un pollo trovato sottoterra dopo secoli e poco si addice alla musica proposta.
Come detto poco fa, se dovessimo paragonare l’album a Bilateral ci verrebbe da piangere; non è però giusto che un ingombrante passato ponga delle ombre sul buono che il presente è in grado di offrire anche se molto diverso. Ci collochiamo quindi tra il 7 e l’8 e crediamo che il voto, come il disco, siano un passaggio: la nuova fase dei Leprous iniziata con Coal prosegue con The Congregation, il prossimo chiuderà il cerchio? Sembra un po’ una delle care e vecchie bombe di Mosca (RIp.), sostituiamo quindi il punto interrogativo con quello esclamativo perché ci crediamo davvero.