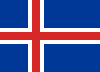Recensione: The Four Doors Of The Mind
Vale la pena soffermarsi su “The Four Doors of the Mind”, terzo e nuovo album dei Dynfari. E per due motivi strettamente concatenati tra loro. Anzitutto, il duo si era stampato nella memoria di chi scrive per la non esaltante peculiarità di essere stata la prima band islandese a ricevere un’insufficienza. L’album in questione era “Vegferð tímans”. L’altra peculiarità sta nell’impressionante maturazione raggiunta dai Dynfari in questo nuovo “The Four Doors of the Mind”. E le due uscite sono separate da appena 22 mesi.
Prima di passare all’analisi del disco, una premessa: il duo è divenuto un quartetto e l’inserto di un bassista e di un chitarrista a tempo pieno molto probabilmente ha inciso a livello compositivo, portando forse personalità, forse idee nuove, forse compattezza.
Ad ogni modo, al tempo della precedente recensione, il problema principale era parso essere una produzione non esattamente spettacolare. Ad oggi, piuttosto, sembra che i nuovi arrivi abbiano portato una certa maturazione per quanto concerne la gestione di cambi di ritmo ed atmosfera, unite ad alcuni spunti piuttosto azzeccati. E senza stravolgere più di tanto la proposta.
Ciò che è cambiato maggiormente, tuttavia, pare essere il cantato, ora per larga misura uniformato in un incrocio tra clean e gowl che ricorda un po’ la voce roca di uno dei cantanti degli Skálmöld o degli Shining svedesi, sebbene stilisticamente i Dynfari siano più grezzi degli Skálmöld e meno furibondi degli Shining. Il risultato risulta difficile da digerire nei primi ascolti, ma a tutti gli effetti dona alla proposta una certa personalità. Al growl fanno da contraltare sparuti clean e diverse parti recitate in inglese (tutto il resto è nella lingua di Snorri, a dispetto dei titoli) che spiegano il concept dell’album.
Dal punto di vista compositivo, invece, le tracce di “The Four Doors of the Mind” segnalano una certa qual deviazione più accentuata verso il progressive e il post black. Ne è splendido esempio l’attacco sognante di “1st Door: Sleep”, con il suo riff di chitarra sognante. Il pezzo poi si rivela essere basato, e questa è un’altra bella scelta, sul divenire piuttosto che su contrastanti cambi di ritmo, con un ottimo quanto naturale climax in cui la violenza aumenta adagio, ma costantemente.
E questa è una dominante dell’album. Tutte le canzoni risultano molto omogenee e i passaggi tra quiete e furia risultano molto naturali. Oltre a ciò, i Dynfari azzeccano un buon numero di riff vagamente indie e vagamente ispirati a certo black britannico (Fen e Winterfylleth), grazie ai quali brani relativamente lunghi come “Sorgarefni segi eg þér” e soprattutto “Madness” filano via che è un piacere. In particolare “Madness” che sfrutta a meraviglia un unico giro di chitarra coniugato in varie atmosfere. Apprezzabile in tutto questo anche lo strano interludio folk di “Sorg” che taglia l’album a metà, così come la suite conclusiva “4th Door: Death” summa dell’album, versione imponentemente allargata di “Madness” e nuova conferma che questi due islandesi, con le suite, ci sanno fare.
Insomma, “The Four Doors of the Mind” è un disco che si inserisce senza sfigurare nel sempre più ampio panorama del post-progressive black atmosferico. Non stravolge nulla, né tanto meno inventa qualcosa di nuovo. Non di meno, regala un’ora di buon metal, dominato da atmosfere sognanti nonostante la violenza, e non cade in composizioni arzigogolate o pretenziose. Comunque bel colpo.