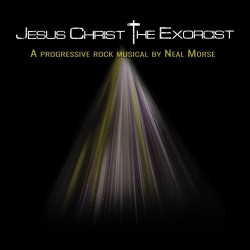Recensione: The Grand Experiment

Ottavo album solista progressive per il talento californiano ex-Spock’s Beard, nonché sedicesimo disco del sodalizio Morse–Portnoy (considerando anche Transatlantic e Flying Colors). Numeri ormai importanti, per una carriera che ha dato una coerenza unica alla proposta musicale dell’artista americano, prolifico come non mai.
Dopo la parentesi soft di Songs from November, Neal torna alla formula che meglio gli si addice: un platter dalla scaletta stringata, che prevede un opener di riguardo e una suite conclusiva pirotecnica, con, nel mezzo, tre brani più accessibili anche al grande pubblico, tracklist inclusa. Una setlist, dunque, vicina a quella di Lifeline del 2008 (però con minutaggio inferiore), ma anche a quella di V, capolavoro del 2000.
Da quanto leggiamo nel web, Neal questa volta è entrato in studio di registrazione senza alcuna idea pregressa. Le parole del mastermind suonano in tal senso promettenti:«I wanted to see what it would be like to create freely in the room with no preconceived notions. It was quite a risk!» (Ho voluto vedere come sarebbe stato creare liberamente in studio senza idee già in mente. È stato davvero un rischio!).
Da qui ecco subito spiegato il titolo e l’artwork del full-length. Voglia di sperimentare, ma sempre nei binari del miglior prog. d’annata. Il risultato, lo diciamo subito, in realtà non si discosta dalle coordinate tipiche della discografia morsiana, ma regala un quid in più che conferisce al disco maggiore visibilità e ragion d’essere rispetto al precedente Momentum, merito anche della voce e dello shredding di Eric Gillette, chiamato a dar man forte a Neal.
Fatta questa premessa, veniamo al track-by-track.
Inizio a cappella per “The Call”, brano caleidoscopico come da tradizione progressive, tra synth di clavicembalo e Hammond, e un drumwork sincopato di Portnoy che ricorda, mutatis omnibus mutandis, la pazzia ritmica di “Full Circle” (parte della title-track dell’omonimo album targato Dream Theater). Dopo i due minuti strumentali introitali, subentra la voce di Neal: il suo timbro è inconfondibile e si mantiene accogliente anche dopo anni di carriera alle spalle. A metà brano non può mancare un break crepuscolare, poi il basso di Randy George fa risorgere ritmi più rockettari, sfondo per unisoni chitarra-tastiera goduriosi. Si presenta, altresì, una breve sezione à la Allan Holdsworth (nello stile eclettico di Neal niente è fuori luogo!) con campane nell’immediato prosieguo, ripresa del refrain a cappella e un finale scoppiettante in tremolo picking. Un opener memorabile.
I tre brani successivi sono, come anticipato, più easy-listening. Si parte con la title-track, brano piuttosto anonimo, ma con un refrain catchy e un buon groove. Predominano le seconde voci e le armonizzazioni vocali, vero tratto distintivo dell’album. Non manca nemmeno un assolo di chitarra ispirato, cui segue un vellicante break con filtri vocali simil Gentle Giant.
“Waterfall” è una ballad cheta e rinfrescante con qualche armonizzazione di troppo (mi riferisco al registro alto e alla durata di certe linee vocali). La voce di Eric Gillette, tuttavia, ben si sposa con quella di Neal, in un brano tra Beatles e mielosità retrò. Gli ultimi secondi sono vellutati con note di sax e un basso fusion.
Dopo una traccia un filo scontata come “Waterfall”,“Agenda” è il brano pop ficcante che non ti aspetti e dà spazio alla vena ribelle e falotica di Neal. Regge il confronto con un’altra hit brevissima, in un album neo-prog. con canzoni chilometriche: mi riferisco a “The Sun in My Eyes”, pezzo di A Place in the Queue targato The Tangent.
Da ultimo, la suite finale “Alive Again” e siamo di fronte a un altro capolavoro sulla falsa riga di classici come “The Creation”, “The Conflict”, “So Many Roads” e “World Without End”. S’inizia con un basso fatato e tinte colorate di Yes; sul finire del quarto minuto Portnoy si scatena in un fill sincopato di charleston che ricorda i bei tempi di “Mystery Train”. Dopo altri momenti appaganti, al min. 10:15 prendono piede con fare scanzonato delle distorsioni goliardiche: lo show non è ancora finito! Stupisce, infatti, nel prosieguo una breve parentesi barocca (come in “Thoughts, Part II” nel già citato V), altro highlight di una suite che si dinapa indefessa tra cambi di tempo e atmosfere, facendosi improvvisamente più pesante con un assolo di chitarra petrucciano (non a caso è impiegata una Music Man). Gli ultimi dieci minuti regalano, infine, un’altra parte in pianissimo e, purtroppo, Portnoy al microfono. In un crescendo catartico l’ispirazione divina di Neal si fa potente e tutto è tripudio. Le ultime note cantate sono di Gilette, poi la coda diventa un po’ pleonastica ma tant’è.
Per chi non s’accontenta, nel bonus disk della deluxe edition figurano altri due brani inediti (d’ascoltare assolutamente “New Jerusalem“) e la gustosa cover di “MacArthur Park”, brano del ‘68 scritto dalla leggenda Jimmy Webb (e più volte reinterpretato), ancora con un Portnoy sugli scudi come singer. C’è spazio, infine, per un’altra mezzora di musica, con due suite di Neal registrare al MorseFest nello scorso novembre.
Cambiano i tempi, cambia in parte la line-up, ma il polistrumentista californiano non mostra segni di cedimento creativo. Neal evita, altresì, il rischio d’incappare nella solista autocelebrazione divina da new born christian e rispolvera un poco la sua dimensione pseudo-ludica per la gioia dei fan più datati. Cosa si poteva chiedere di meglio? Il “grandioso esperimento” è più che riuscito, ad maiora!
Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)