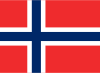Recensione: The Quiet Offspring
Ricordate il masterpiece Light of Day, Day of Darkness? Bene, dimenticatelo. Con A Blessing in Disguise la band di Tchort e soci avevano voltato decisamente pagina: non avrebbe avuto senso aspettarsi una marcia indietro, e infatti non c’è stata. Ma la nuova strada dove ha condotto il combo norvegese? Qui iniziano i problemi.
Si dice che in ogni incontro la prima impressione sia determinante: bastano cinque secondi per formulare un giudizio che poi diventa assai arduo da cambiare. Non so se ciò occorra anche nel mondo della musica, ma posso dire che in quest’occasione la regola è stata rispettata. Le prime note della title track mi hanno fatto strabuzzare gli occhi, e non in senso buono. Un riff di chitarra semplice e sincopato, pericolosamente vicino ai cliché di un certo crossover, irrompe con artefatta cattiveria, prima di essere puntualmente stemperato dal resto della strumentazione, impegnata a recitare una parte tra il malinconico e l’aggressivo, accanto ad una delle sezioni ritmiche più anonime che abbia mai sentito (tu quoque Kobro!).
Per nulla convinto di stare ascoltando un album di progressive metal, passo alla seconda traccia. Breve arpeggio introduttivo e via libera a una strofa traboccante di glassa stucchevole e appiccicosa, che non mi sento neppure di definire metal. Grossi, grossissimi dubbi. L’impressione che comincia a concretizzarsi è che il gruppo abbia indiscutibili capacità tecniche – beninteso, nulla di trascendentale ma la perizia c’è e si sente – oltre a qualche buona idea, ma che tutto crolli rovinosamente nel momento in cui vuole spingere a forza nella traccia il motivetto orecchiabile. E questo secondo brano credo riassuma al meglio la contraddizione insita nell’album: sprazzi di buon senso musicale, se non propriamente belli comunque lodevoli (parlo del break di tastiera), annegati in un mare di banalità easy-listening pseudo-modernista (parlo di tutto il resto).
E per quanto si proceda nell’ascolto, nulla cambia: solo si intensifica il presentimento che questo album avrà successo. Non potrà non averne, le canzoni sono di facile presa, decisamente orecchiabili. Troppo orecchiabili: è qui l’inghippo. Song come A Place for Me o The Everlasting Moment possono piacere un po’ a chiunque: i riff si lasciano ascoltare senza problemi, il suono è limpido, cristallino. Posticcio. E ruffiano. Non c’è nulla da scoprire, nessun significato nascosto tra le note, nessun brivido che si riveli tra le note per stimolare la sensibilità, sorprendere. In qualche modo sa tutto di già sentito, un’accozzaglia di suoni agglomerati con innegabile competenza ma clamorosamente privi di originalità, con poche e sporadiche eccezioni. Bene Child’s Play, entrambe le parti, dove finalmente tacciono le odiose chitarre più volte pericolosamente vicine al confine del nu metal, e finalmente qualcosa sembra muoversi. Per il resto, alcuni discreti alcuni passaggi qua e là, come la prolissa ma gradevole intro di Pile of Doubt (mai titolo fu più profetico), tuttavia il dramma è proprio che non si riesce a trovare una canzone che si mantenga costantemente al di sopra dei livelli minimi di pudore: ora colpisce un bel riff di tastiera, ora un refrain quasi sincero, ora il pregevole arpeggio di un basso avaro negli interventi ma pur sempre apprezzabile; eppure in qualche modo il sound, per quanto si sforzi di variare, non riesce mai a conquistare interamente.
Vien da chiedersi perché nell’arco di due soli album tutto sia cambiato in modo così drastico. Certo, non si vuole negare ad una band il sacrosanto diritto di sperimentare nuove strade, di compiere nuove scelte stilistiche, di evolvere. Ma l’evoluzione non deve diventare il dito dietro cui nascondere un fallimento: alla base deve potersi riconoscere un processo graduale, naturale, che mantenga una fondamentale coerenza con l’ente originario. Altrimenti si può parlare di trasformazione, di sconvolgimento: non di evoluzione. Dunque, ci si chiede, perché non abbandonare il nome Green Carnation? Perché non ricominciare da capo con un nuovo monicker, con premesse ed idee nuove? Probabilmente i più smaliziati obbietteranno: “ma chi glielo fa fare?”. Si sono fatti un nome, ora è ovvio che si vogliano avvantaggiare del meritato successo. Senza dubbio è così, ma a questo punto non mi si potrà negare il legittimo sospetto di un certo interesse per il lato pecuniario della faccenda. Che pensare altrimenti quando le canzoni si susseguono imperterrite con monotona indulgenza verso le melodie facili e, come se non bastasse, con una diffusa aridità nei testi? E non pensi qualcuno che i ripetuti ascolti possano migliorare l’impressione generale; anzi, nella più squallida traduzione dell’easy-listening troppo ruffiano, alla lunga ciò che prima semplicemente non convinceva finisce proprio per annoiare.
Che cosa resta alla fine? Delusione, sicuramente, e rammarico, per una band esperta e magari animata di buone intenzioni, incapace tuttavia di ricreare quella magia che aveva saputo infondere nei precedenti lavori. Al giorno d’oggi, in un 2005 saturo di offerta, non si può scodinzolare a tutti gli ossi che il mercato butta, e “commerciale” è il termine che meglio si presta a definire le undici tracce di questo album troppo edulcorato perché si possa di buon cuore promuoverlo. Da un gruppo chiamato Green Carnation, da songwriters delle capacità e della caratura di Tchort e compagni, è lecito, se non dovuto, aspettarsi qualcosa in più di un disco che vorrebbe essere un po’ prog, un po’ heavy, un po’ melodico, un po’ gotico, un po’ folk, un po’ cattivo, un po’ buono, un po’ alternativo, insomma un po’ di tutto, ma che alla fine non è niente.
Tracklist:
1. The Quiet Offspring
2. Between the Gentle Small and the Standing Tall
3. Just When You Think It’s Safe
4. A Place for Me
5. The Everlasting Moment
6. Purple Door, Pitch Black
7. Childsplay Part I
8. Dead But Dreaming
9. Pile of Doubt
10. When I Was You
11. Childsplay Part II