Recensione: The Snake King
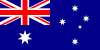
Rick Springfield è della classe 1949. Il dato non è tanto importante in sé, quanto alla luce della freschezza della sua proposta musicale datata 2018; una freschezza non certo innovativa, ma sicuramente compositiva. Rispetto alle più recenti uscite del Nostro, The Snake King segna un ritorno a sonorità meno sperimentali, più intimiste e istintive, capaci di valorizzare le doti indiscutibili di rocker di classe dell’australiano.
Data una qualità generalmente buona delle composizioni, a stupire in positivo di The Snake King è la varietà dei suoni, degli arrangiamenti e delle atmosfere. Si passa dalla rock ballad vagamente bonjoviana al rock che strizza l’occhio al country, fino al blues che più classico non si può: il tutto è ben amalgamato dalla personalità di Springfield, che si impone senza strabordare, favorendo così il piacere dell’ascolto del disco nella sua interezza.
Land of the Blind apre The Snake King con un bel giro di chitarra acustica e una melodia tanto eterna da poter essere stata composta in qualsiasi momento dagli anni sessanta in poi. Niente di trascendentale, per carità, ma un onesto rispetto del rock che va ammirato nella sua costanza proprio nell’attraversare i decenni.
Tanto tanto groove in The Devil That You Know, dove Rick si trasforma in una sorta di crooner con tanto di fiati a supporto. Sulla stessa linea, con una ventata di hard blues, è la successiva Little Demon, mentre Judas Tree rappresenta l’archetipo del giro blues che non stanca mai e fa comunella con le varie God Don’t Care, Suicide Manifesto e Blues for the Disillusioned (che è molto bella).
Jesus Was An Atheist ci porta nelle praterie del west americano e vena il blues di un atteggiamento tipicamente country. Insomma, una festa di paese con cappelli da cowboy e rodeo.
The Snake King e The Voodoo House sarebbero piaciute ai Cinderella di Heartbreak Station, o al Bon Jovi di Blaze of Glory, e rappresentano due dei migliori momenti del disco.
Infine, ecco il rock ‘n roll molto fifties di Santa Is An Anagram e lo spleen dolce amaro decisamente Springsteeniano di Orpheus in the Underworld, che lascia una nota nostalgica nel congedo del disco.
In un mondo travolto da suoni standardizzati, freddezze digitali e chitarra iperdistorte che non fanno male a una mosca, il calore di un disco di Rick Springfield è sempre un bel regalo. Che scaturisca da un fuoco acceso tanti anni fa e mandi quel sapore di antico è più un pregio che un limite. Spiace solo che la massa delle uscite discografiche nel grigio diluvio democratico moderno affosserà il ricordo e la tradizione di un bel pezzo come Orpheus in the Underworld.


