Recensione: The Trembling Voices of Conquered Men
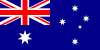

Gli australiani Vahrzaw sono attivi dal 1994. Questo per dire che non sono i primi arrivati ma che, anzi, possono vantare un’esperienza pregressa di tutto rispetto. Oltre alla realizzazione, fra produzioni minori, di quattro full-length di cui l’ultimo è questo “The Trembling Voices of Conquered Men”.
Stranamente, come è accaduto più volte in passato, la nazione dell’Oceania ha proposto act dediti al metal oltranzista più buio e oscuro, quasi a reagire alla luce di terre baciate dal sole che posseggono, fra l’altro, torridi deserti e lunghissime, luminose spiagge.
Un fulgore di aria frizzante e di oceano blu che viene adombrato da un death metal totale, intendendo con questo termine uno stile uniforme nella sua aggressività sonora, quasi fosse una marea di fango che ricopra tutto e tutti. Stile non particolarmente innovativo ma ben formato nelle sue componenti essenziali, volte a dar luogo a un sound adulto, maturo, indicativo di un gruppo che sa bene quale sia la strada da percorrere nella propria carriera.
Un sound ostico, arcigno, in cui regna indisturbata quasi ovunque la dissonanza escluso qualche improvviso, delicato orpello della sei corde (‘Vultures’). I trentaquattro minuti di durata del platter, infatti, offrono sette brani, anzi cinque per via dell’intro (‘The Trembling Voices…’) e dell’outro (‘… of Conquered Men’), decisamente duri da digerire, perlomeno a chi non alberga costantemente nel regno del metal estremo. Cinque tracce piuttosto lunghe, e non poteva essere altrimenti, fra le quali spicca la suite conclusiva ‘The Pessimist’. In esse, come più su affermato, il lievito fecondante è il death metal. Tuttavia, proprio lo spessore del background aggiunge a esso tracce di thrash, rinvenibili come eredità del periodo in cui è nata la formazione australe. Poi, una manciata di sludge giusto per donare al tutto un tocco… fangoso. Ma niente di preponderante, comunque, rispetto a un insieme che appare sempre coeso e compatto attorno al un nucleo compositivo che fa fede al death.
Van Doorn, pure bassista di poche pretese, propone delle linee vocali tradizionalmente ancorate a un growling diffuso, inintelligibile, roco e profondo. È chiaro che è il genere stesso a dare una spinta naturale a questa modalità di approccio al cantato, ma così facendo esso si uniforma a quello di una miriade senza fine di colleghi che non si discostano da un cliché trito e ritrito. Un aspetto, questo, che non aiuta I Nostri rendersi autonomi nella proposizione di una foggia musicale che si discosti nettamente dalle altre. Anche perché, alla fine, volenti o nolenti, la voce è un elemento di spicco ovunque, in tutti i dischi di metal e non. E se essa non si fa notare per un qualsiasi tocco di originalità, allora si parte sin da subito con il piede sbagliato.
Più che buono, invece, il lavoro svolto da Williams alla chitarra. Un lavoro gravoso, giacché, come unico membro a mulinare l’ascia da guerra, si sobbarca un compito complesso, arduo e faticoso. Arpeggi, assoli, incroci disarmonici, ma soprattutto una quantità enorme di riff fuoriescono dalle sue mani. Riff come detto dal leggero sapore thrashy, che formano una struttura dalle membrature complicate nella loro geometria mai lineare. A lui, si somma il drumming labirintico di Gawith, notevole nella lambiccata arte dei campi di tempo, in grado di spaziare entro un intervallo di BPM assai esteso. Dai pesanti, cadenzati slow-tempo sino alla follia dei blast-beats, non c’è un attimo di tregua ma, soprattutto, non c’è un attimo pausa nell’erogazione di un valore energico grazie alla quale il trio di Traralgon può vantare un rilevante impatto frontale.
Nella sua globalità, “The Trembling Voices of Conquered Men” è un lavoro scevro da dettagli che ne inficino gravemente una riuscita pertanto quasi sufficiente. Il songwriting non regala granché di nuovo né di dirompente, limitandosi a dar luogo a tracce… di sicurezza, idonee per produrre un disco coerente con le idee della band ma nulla più.
Un po’ poco, insomma, per risvegliare l’attenzione per via di un’opera che, inesorabilmente, resta intrappolata in se stessa e, presumibilmente, in un anonimato perpetuo.
Daniele “dani66” D’Adamo

