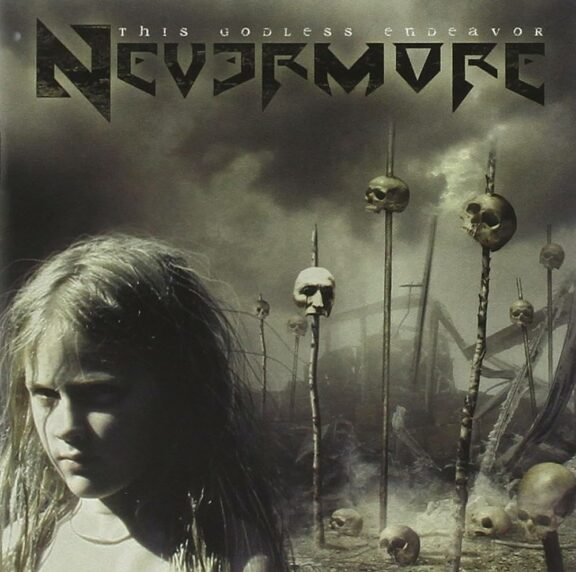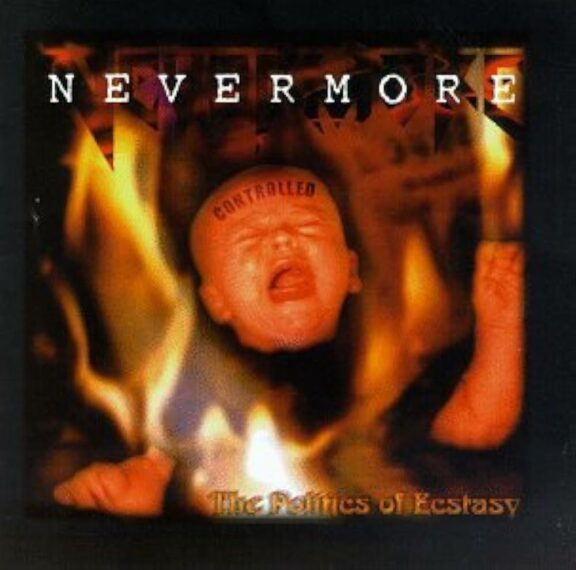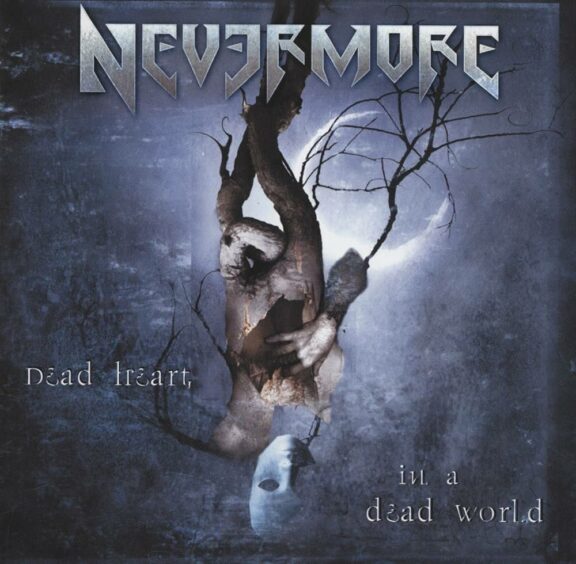Recensione: This Godless Endeavor
Abituare troppo bene il proprio pubblico può rivelarsi un’arma a doppio taglio: non è una novità per i Nevermore, che non dimenticano le reazioni contrastanti suscitate due anni or sono dall’uscita di Enemies Of Reality, un ottimo album mutilato da una produzione inadeguata. Le critiche non si sono fatte attendere: chi ha (legittimamente) contestato l’ingaggio di Kelly Gray – provocando peraltro un discusso dietrofront, con il remix ad opera del ‘mago’ Andy Sneap – chi non ha approvato la direzione generale del songwriting, tacciato di superficialità e puro onanismo.
Mai paghi di una carriera costellata di successi (ed eccessi), i quattro di Seattle – ora cinque, con l’innesto dell’ex-Testament Steve Smyth – hanno preparato una rentrée che promette strage di consensi, pronti a far piazza pulita della concorrenza. Il risultato è un platter stupefacente, maniacale nella rifinitura di ogni dettaglio, maturo nel fare tesoro di un’esperienza decennale sul campo: in tre parole, This Godless Endeavor.
Il preoccupante punto interrogativo lasciato dal biennio 2003/2004 – un periodo nero per la band, tra incomprensioni contrattuali e liti con il management della Century Media, senza dimenticare i ben più gravi problemi di salute di Warrel Dane, tali da compromettere un’intera tournée – trova risposta nelle note del nuovo lavoro, l’ottavo tra EP e full-length. I Nevermore ripartono dalle trame al limite del parossismo del capitolo precedente, investendo tuttavia sull’architettura di ogni composizione piuttosto che sul singolo sfogo di tecnica: ne esce una vincente collezione di brani in cui si sente praticamente di tutto, dalle atmosfere ipnotiche che furono della mitica Garden Of Gray ai martellamenti senza tregua di Narcosynthesis, il tutto pregno di un flavour crepuscolare che è rinomato (e ineguagliato) marchio di fabbrica.
Mai come oggi il lavoro di squadra premia le doti di ogni singolo musicista, emblema di un collettivo affiatato e sicuro dei propri mezzi. Convince la novità del songwriting a quattro mani, con l’asse Loomis–Dane a spartire onori e oneri in compagnia del neo-promosso Steve Smyth – alla prima, vera ‘prova del fuoco’, se si esclude la parentesi con i Vicious Rumors e la partecipazione ai Dragonlord di Eric Peterson – e un inedito Jim Sheppard. Sbalordisce (ma non sorprende) il saggio di tecnica sfoggiato con fiera consapevolezza dal leader Jeff Loomis, atteso al varco del pluri-rimandato debutto in veste di guitar hero: un talento che, al pari del compagno Van Williams (performer di prima classe regolarmente ignorato dalla critica specializzata), paga a caro prezzo l’indole riservata e sfuggente che ne limita l’esposizione a vantaggio di colleghi ben più modesti. Strappa applausi, infine, la prestazione intensa e cangiante di Warrel Dane, restituito in piena forma dopo un’annata trascorsa tra una clinica e l’altra a disintossicarsi dall’alcool (cattiva compagnia per un diabetico) e a curare in tempo una pancreatite: il biondocrinito frontman ha vinto la sua battaglia, ed è tornato in pista con una foga che giustifica le scariche di inaudita cattiveria disseminate qua e là tra i solchi del disco. Rabbia che trova uno sfogo ideale nei testi a corredo della musica, da sempre fiore all’occhiello dell’ex-Sanctuary. This Godless Endeavor ha il fascino del concept pur mantenendo la dovuta distanza tra un episodio e l’altro: il tema generale verte sulla diatriba secolare tra scienza e religione, storiche rivali nella ricerca dell’identità e delle origini umane. Un argomento trattato con un occhio di riguardo al presente e al futuro del pianeta, pur senza la pretesa di una posizione super partes.
The pigs order us to follow orders and obey / The flies drink the decaying nectar of their tortured effigy
Cling to wasted beliefs and visions and bathe in apathy again / No solution, the retributions of spiritual sickness begins…
La furia iconoclasta di Born è un battesimo terremotante e impietoso. Massicce infiltrazioni di matrice death metal hanno il merito di irrobustire anziché sconvolgere il classico Nevermore sound, più che mai roccioso nel suo incedere: protagoniste indiscusse le chitarre, che sprigionano riff saturi e convulsi senza cedere il fianco. In mezzo a tale marasma sonico brilla per compatibilità nel suo essere antitetico lo splendido ritornello, impreziosito da architetture melodiche di pregevole fattura. L’ugola di Dane è portavoce di un’umanità che si ribella al giogo delle religioni (senza distinzioni di sorta), ombra dietro una società plagiata dall’ipocrisia e dalla corruzione: i sentimenti ricorrenti sono il dolore, lo sconforto che deriva dall’impotenza, la rabbia come unico sfogo di fronte a una realtà di cui si è segretamente complici.
Look at the world, look at the hell, look at the hate that we’ve made / Look at the final product, a world in slow decay
I’m told that all your seeds are black / I’ve learned the question is unanswered and opaque…
Non offre spiragli di luce Final Product, futuristico melodramma che fotografa uno scenario desolante e caotico. Se è evidente il parallelo in termini di liriche con la traccia precedente, lo stesso non si può dire delle parti strumentali: il brano – cautamente scelto come singolo apripista – rievoca con successo le sonorità che resero grande Dead Heart In A Dead World, dai più considerato l’apice creativo del combo di Seattle. Meccanici riff fanno strada lungo un mid-tempo lineare e granitico, scandito con puntualità dalla sezione ritmica: la voce è vittima di un conflitto interiore tra spirito di rivalsa e rassegnazione, due opposti che si attraggono e si inseguono come i vorticosi assoli riservati dal finale.
The sands of time are pointless in a useless ugly world / Nothing brings peace of mind, I leave nothing behind if my words are left unheard…
My Acid Words abbandona per un istante le apocalittiche visioni di un pianeta sull’orlo del baratro e si rifugia nell’intimità di un’infanzia difficile, vissuta tra mille incomprensioni; ogni riferimento autobiografico non è casuale – nella fattispecie un ipotetico monologo rivolto al fratello – sebbene i testi di Warrel Dane abbiano spesso il pregio di sapersi prestare a molteplici interpretazioni. La cruda spontaneità delle parole si sposa alla perfezione con il feroce assalto iniziale, dal vago retrogusto At The Gates, presto sostituito da tempi spezzati e un groove che riportano sulla dimensione Nevermore: il ritornello giunge tempestivo al culmine delle emozioni, accompagnato da chitarre delicate e suadenti. Tra gli highlight assoluti.
The sheep march to the fire and wait to host the flies / Their greedy little maggots clean the wounds with pride / This is your final warning, a war on freewill is coming…
La firma è di Steve Smyth, ma Bittersweet Feast suona Nevermore al 100%; non è un caso che il mastermind Jeff Loomis abbia fortemente voluto come spalla l’ex promessa dei Testament, dopo anni di gavetta e sporadici riconoscimenti. La sensazione è quella di ritornare idealmente ai tempi di Dreaming Neon Black, con chitarre allucinate e dissonanti e un cantato disturbante, quasi sadico nel suo mettere in luce le follie del mondo moderno. Il testo gioca su metafore grandguignolesche che rincarano la condanna delle religioni organizzate, il cui potere è costruito sul controllo delle menti e sull’inganno: quella del banchetto è un’immagine forte ma tragicamente reale, affogata nel sangue delle vittime dei fanatismi.
Superior is digital, human flesh is so trivial / I hate that I can’t see the one that made me…
Sentient 6 è il nome in codice di un robot che studia silenziosamente l’essere umano, covando in gran segreto il desiderio di ribaltare i ruoli e assumere il controllo. La mente corre subito al soggetto della storica The Learning, ma le analogie finiscono qui: il pezzo è una power-ballad pianistica che spezza l’impeto delle tracce precedenti e celebra le doti canore di un Warrel Dane incontenibile, perfettamente inserito nel personaggio. Il finale ed è alto voltaggio, con chitarre in loop che fanno da colonna sonora alla riscossa delle macchine, veicoli di distruzione e morte. La fase di emulazione è terminata: la tecnologia si è ribellata ai padri-padroni.
Trapped in dark seductive miracles, deified addictive rituals / All you feel and all you do, the medication controls you
Did you remember to feed me while I was broken and bleeding?…
L’andamento sinuoso e serpeggiante di Medicated Nation registra l’avvicendamento in cabina di regia di Jim Sheppard, chiamato all’ingrato compito di ribadire gli standard eccelsi della cinquina appena terminata. Missione riuscita solo in parte: pur crescendo ascolto dopo ascolto, la canzone manca di spunti geniali, limitandosi a ribadire con forza una formula già collaudata ma evidentemente ancora fresca; solo l’esame del palcoscenico – dimensione che rende appetibili pezzi catchy e lineari – saprà fornire indicazioni più precise. Meno intuitivo è l’impatto con il testo, che nasconde velati riferimenti al tema già toccato da Bittersweet Feast; l’aria che si respira è torbida, allucinogena: la dipendenza da falsi ideali e promesse tradite non conosce cure o antidoti.
The Holocaust Of Thought è un intermezzo strumentale che compare e scompare nel giro di un minuto, senza lasciare particolari tracce: del resto nessuno sente il bisogno di ulteriori ragguagli sulla caratura dei musicisti all’opera.
Did you ever wonder why the wind blows cold? / Did you ever realize your face is painted on my soul?
Sell My Heart For Stones lascia da parte le distorsioni e si muove su territori più placidi, rivelandosi una ballata piacevole e studiata per far cantare a squarciagola il pubblico. A onor del vero le linee melodiche del chorus non raggiungono l’eccellenza di titoli più o meno recenti del repertorio come The Heart Collector o The Hurting Words, pur giovando di alcune scelte stilistiche piuttosto interessanti: su tutte l’alternanza simmetrica delle due voci, una sorta di chiaroscuro mutuato dalle struggenti lyrics, ai massimi livelli – poeticamente parlando – della produzione firmata Warrel Dane. Tappa di transizione qui (un lusso che pochi si possono concedere), punta di diamante in altre produzioni.
The pain is born from memory of pleasures unparalleled and pure / In velvet sleep I live the past again / There is no chance to release me, no answer to bring peace…
Parole e immagini si incontrano e si fondono tra le note di The Psalm Of Lydia, che ha radici forti nell’artwork realizzato da Hugh Syme: luce che filtra a malapena, grigio e nero come tinte dominanti, assenza di ossigeno; non è di Lydia il volto della cover – parola del frontman – nonostante cenni espliciti nel testo, ma il riferimento, forse per la sua sorprendente casualità, è ancora più convincente. Il massiccio riff iniziale conferma Jeff Loomis pregevole songwriter, ma è come solista che l’ex-Sanctuary (un’avventura terminata troppo presto) dà il meglio di sè, tra passaggi esotici e contorsioni al limite dello shred: l’ennesima dimostrazione di classe offerta da un artista sottovalutato, capace a soli 16 anni di presentarsi a un provino per entrare nei Megadeth (era il 1989); quella volta andò male – complice anche la giovane età del candidato – ma il ragazzo è cresciuto…
As we face the bleak horizon under crushing skies / The truth belying a future uncertain and dark / We are but one small race, all wear a human face / Yet our image is imperfect and flawed…
A Future Incertain si divide tra esplosioni elettriche e momenti più introspettivi, recuperando gran parte della velocità che aveva caratterizzato la prima metà della tracklist; non mancano alcune sorprese, come accade nella sezione centrale del brano, a riprova del prezioso contributo compositivo di Steve Smyth. Si leggono richiami a Final Product tra le righe, ma la fredda lucidità di fronte all’imminente tragedia (leggi: estinzione umana) è un sentimento nuovo, che ha ormai spazzato via ogni scampolo di speranza: l’uomo appartiene a una razza corrotta, vittima del suo stesso nichilismo.
Our organic equation has shown it’s flaw / Can we agree to disagree on the concept of god? / As I lifted up my brother he said to me / “Abandon naive realism, surrender thought in cold precision”
Tanto affascinante quanto impegnativo, l’eterno conflitto tra religione e scienza (intesa in senso lato, alla stregua di pensiero razionale) è un argomento che si dimostra sempre di grande attualità, a patto di essere trattato con cognizione di causa. I Nevermore non si sono lasciati scoraggiare dalle difficili premesse e hanno forgiato un capolavoro che non conosce precedenti nella loro nutrita discografia, una grandiosa cavalcata metallica che pesca dall’intero catalogo della band e si candida al titolo di composizione ‘definitiva’: This Godless Endeavor. La prestazione corale è fenomenale, dall’incipit acustico alla tempestosa sezione centrale, un trionfo di perizia tecnica e rapidità esecutiva che lascia a bocca aperta; le corde vocali di Warrel Dane sanno carezzare e graffiare con la stessa malizia, muovendosi tra le righe di un testo lunghissimo e enigmatico, testamento di un uomo che non si dà pace nel vivere sulla propria pelle l’irrazionalità della generazione di cui fa parte. Mai conclusione fu più degna.
This Godless Endeavor è un colpo di coda orgoglioso, che spazza via con decisione ogni incertezza sullo stato di salute dei Nevermore e ne rafforza lo status di band leader nel panorama odierno. Nessun particolare è stato lasciato al caso, dalla produzione magistrale ottenuta da Andy Sneap – sinonimo di garanzia assoluta – al delizioso packaging che accompagna l’opera, un ulteriore incentivo all’acquisto (obbligatorio) per ogni Neverhead che si rispetti. Disco dell’anno.
Welcome to the end my friend, the sky has opened
Federico ‘Immanitas’ Mahmoud
Tracklist:
01 Born
02 Final Product
03 My Acid Words
04 Bittersweet Feast
05 Sentient 6
06 Medicated Nation
07 The Holocaust Of Thought
08 Sell My Heart For Stones
09 The Psalm Of Lydia
10 A Future Incertain
11 This Godless Endeavor